 SOLOFRA: LA CHIESA DI SANT’ANGELO.
SOLOFRA: LA CHIESA DI SANT’ANGELO.
 SOLOFRA: LA CHIESA DI SANT’ANGELO.
SOLOFRA: LA CHIESA DI SANT’ANGELO.
La collegiata: scrigno di fede, arte e storia secolari.
Nell’Archivio storico diocesano
di Salerno si conserva il documento scritto più antico relativo alla primitiva
chiesa matrice sotto il titolo di sant’Angelo. E’ una pergamena originale del
giugno del 1042 sotto il principato di Guaimario e 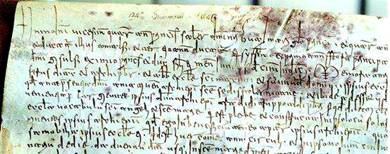 del
figlio Gisulfo, in età longobarda, discretamente conservata. Il
memoratorium sancì la cessione perpetua della pieve
di sant’Angelo, contitolata a santa Maria, al presbitero di Solofra
Truppoaldo, figlio del fu Diletto chierico del medesimo
locum.
Non
si conservano notizie scritte anteriore al secolo XI . Tuttavia appare certa
l’esistenza della pieve solofrana sin dal secolo IX, fondata dalla gente
longobarda dimorante nella valle solofrana, a ridosso del vicino fiume e
dell’antica strada consolare.
del
figlio Gisulfo, in età longobarda, discretamente conservata. Il
memoratorium sancì la cessione perpetua della pieve
di sant’Angelo, contitolata a santa Maria, al presbitero di Solofra
Truppoaldo, figlio del fu Diletto chierico del medesimo
locum.
Non
si conservano notizie scritte anteriore al secolo XI . Tuttavia appare certa
l’esistenza della pieve solofrana sin dal secolo IX, fondata dalla gente
longobarda dimorante nella valle solofrana, a ridosso del vicino fiume e
dell’antica strada consolare.  La
storia millenaria della chiesa matrice di sant’Angelo è oggetto di un profondo
studio storico/scientifico ed archeo/palegrafico da parte di Francesco Guacci, di prossima
pubblicazione. Altri Autori locali hanno profuso, negli ultimi tempi, notevoli
contributi culturali di ricerca. Notevole anche il recente contributo degli
storici della Soprintendenza ai Beni architettonici, artistici, storici ed
ambientali delle provincie di Salerno ed Avellino, con la specialistica opera
di restauro/consolidamento globale della chiesa collegiata dissestata dal sisma
del 1980 e l’edizione di studi storici interessanti. Testi importanti sono
stati profusi anche dal solofrano avv.
La
storia millenaria della chiesa matrice di sant’Angelo è oggetto di un profondo
studio storico/scientifico ed archeo/palegrafico da parte di Francesco Guacci, di prossima
pubblicazione. Altri Autori locali hanno profuso, negli ultimi tempi, notevoli
contributi culturali di ricerca. Notevole anche il recente contributo degli
storici della Soprintendenza ai Beni architettonici, artistici, storici ed
ambientali delle provincie di Salerno ed Avellino, con la specialistica opera
di restauro/consolidamento globale della chiesa collegiata dissestata dal sisma
del 1980 e l’edizione di studi storici interessanti. Testi importanti sono
stati profusi anche dal solofrano avv.  Francesco
Garzilli, nel 1989 e da altri Autori non locali, attraverso lo sviluppo di
tematiche affini (A. Braca, V. Pacelli, R. Lattuada ed altri). La storia della
medievale chiesa di sant’Angelo, sorta poco distante dal fiume e posizionata a ridosso del punto viario
sannitico/romano, è legata a rari documenti cartacei per lo più risalenti alla
fine del XIV e XV secolo. Piccola, angusta, con poche cappelle patronali fondate
da alcune famiglie nobili locali, la primitiva pieve evolve in forma
basilicale a partire dal 1522, con un nuoovo progetto e l’abbattimento della
preesistente obsoleta struttura. La tipologia della pianta del XV secolo
mostra una pieve a tre navate e triabsidata di schietta matrice romanica.
Francesco
Garzilli, nel 1989 e da altri Autori non locali, attraverso lo sviluppo di
tematiche affini (A. Braca, V. Pacelli, R. Lattuada ed altri). La storia della
medievale chiesa di sant’Angelo, sorta poco distante dal fiume e posizionata a ridosso del punto viario
sannitico/romano, è legata a rari documenti cartacei per lo più risalenti alla
fine del XIV e XV secolo. Piccola, angusta, con poche cappelle patronali fondate
da alcune famiglie nobili locali, la primitiva pieve evolve in forma
basilicale a partire dal 1522, con un nuoovo progetto e l’abbattimento della
preesistente obsoleta struttura. La tipologia della pianta del XV secolo
mostra una pieve a tre navate e triabsidata di schietta matrice romanica.
La navata centrale era il vero
corpo della chiesa con il suo titulus
ovvero l’area del presbiterio, con le absidi e l’altare maggiore. Le navatelle
laterali, strette, anguste e scarsamente illuminate, con capriate a
vista, accolsero le prime cappelle patronali a partire dalla seconda metà del
XIV secolo. Al 1389 risale il più antico atto diocesano che autorizzava al
nobile Marzillo de Guarino di fondare la cappella gentilizia sotto il titolo di
san Giovanni, successiva alla preesistente cappella angioina dei potenti e nobili
Fasano, eretta sotto il titolo di
san Filippo, poi contitolata a san Giacomo apostolo verso la fine del XV secolo.
Nel 1459 l’arciprete solofrano d. Salvatore Papa erige la cappella patronale
sotto il titolo di san Lorenzo martire:…ad manus dexteram quando intratire
ad dictam ecclesiam. Nei primi anni del XVI secolo la
chiesa medievale si era ingrandita
con l’aggiunta, verso occidente, di una cappella/confraternita sotto il titolo di
santa Maria delle grazie.  Nell’interno della chiesa medievale, ormai
insufficiente e contrastata dalla mole della viciniora magnifica chiesa di sant’Agostino, accolse
le cappelle patronali di don Paolo Papa, sotto il titolo dell’Epifania, del
feudatario Ettore Zurlo, fratello del rettore di
sant’Angelo, l’abbate don Giovanni Zurlo, e
dell’arciprete/cappellano della detta chiesa don Cosmo Guarino ronca sotto il
titolo di san Pietro e Paolo. Erano situate nelle absidiole di sinistra (Zurlo)
e di destra (Guarino ronca) del titulus.
L’arciprete, ricco e dotto, aveva già contribuito al restauro dell’antica
chiesa, ormai cadente ed angusta; con proprio denaro aveva costruito un pulpito
di legno. Più tardi, nel 1520, farà scolpire da
abile artista napoletano della cerchia del Malvito, il suo sarcofago marmoreo
sito nell’attigua cappella verso occidente con proprio altare, cancello
ligneo/dorato e pavimento maiolicato ad esagonette con stemma nobiliare.
Nella cappella dei nobili Zurlo, sotto il titolo di santa Maria della neve, eretta
nel 1516/19, è certa la sepoltura del Suo figlio più illustre, morto nel 1536
:don Giovanni Zurlo, per decenni rettore di sant’Angelo e di sant’Agata di Serino.
Nell’interno della chiesa medievale, ormai
insufficiente e contrastata dalla mole della viciniora magnifica chiesa di sant’Agostino, accolse
le cappelle patronali di don Paolo Papa, sotto il titolo dell’Epifania, del
feudatario Ettore Zurlo, fratello del rettore di
sant’Angelo, l’abbate don Giovanni Zurlo, e
dell’arciprete/cappellano della detta chiesa don Cosmo Guarino ronca sotto il
titolo di san Pietro e Paolo. Erano situate nelle absidiole di sinistra (Zurlo)
e di destra (Guarino ronca) del titulus.
L’arciprete, ricco e dotto, aveva già contribuito al restauro dell’antica
chiesa, ormai cadente ed angusta; con proprio denaro aveva costruito un pulpito
di legno. Più tardi, nel 1520, farà scolpire da
abile artista napoletano della cerchia del Malvito, il suo sarcofago marmoreo
sito nell’attigua cappella verso occidente con proprio altare, cancello
ligneo/dorato e pavimento maiolicato ad esagonette con stemma nobiliare.
Nella cappella dei nobili Zurlo, sotto il titolo di santa Maria della neve, eretta
nel 1516/19, è certa la sepoltura del Suo figlio più illustre, morto nel 1536
:don Giovanni Zurlo, per decenni rettore di sant’Angelo e di sant’Agata di Serino.  La
medievale chiesa di sant’Angelo, accresciutosi delle nuove cappelle patronali
riccamente ornate, fu demolita dalle fondamenta verso la metà dell’anno 1522. Il
nuovo progetto, amplissimo, si deve, verosimilmente, ad un architetto cavese;
della medesima città sono i fabbricatori esperti utilizzati, nonostante vi
fossero a Solofra bravi magistri experti nell’arte del fabbricare
. Tuttavia il poderoso cantiere, sostenuto dall’Università solofrana
titolare ab antiquissimo
tempore dello jus patronato della
chiesa mater et matrice di
sant’Angilo, e controllato dai magistri costituenti la
fabrice omonima, con economi e
procuratori, eletti annualmente, conobbe seri momenti di crisi, in particolare
verso l’anno 1528 con la fine del feudatario
Ercole Zurlo, catturato dagli spagnoli perché filofrancese
nella guerra del Lautrec. Durante tutto l’anno vi fu carestia e peste con
centinaia di morti, proseguita per altri mesi dell’anno 1529. Il cantiere fu
sull’orlo del fallimento più volte, tanto che il
primicerio Cosmo levò il Suo grido contro tutti, in particolare
contro l’Università, il sindaco e gli eletti, per la trascuratezza e la cattiva
sorveglianza dei lavori:…male fatti…! La basilica, nel
frattempo, fu elevata a rango di vera collegiata con bolla dell’ordinario
diocesano nel 1526 e confermata dal santo padre Clemente VII con bolla e sigillo
plumbeo del 1529. Vi fu insediato un Capitolo canonicale di 12 sacerdoti
solofrani con a capo un primicerio; furono stabilite le quote delle prebende ed
ogni altra prerogativa spettante ad un Capitolo collegiale, compreso l’uso del
sigillo proprio. Un esemplare, tra i più antichi, è stato ritrovato dall’Autore
nell’Archivio diocesano salernitano.
La
medievale chiesa di sant’Angelo, accresciutosi delle nuove cappelle patronali
riccamente ornate, fu demolita dalle fondamenta verso la metà dell’anno 1522. Il
nuovo progetto, amplissimo, si deve, verosimilmente, ad un architetto cavese;
della medesima città sono i fabbricatori esperti utilizzati, nonostante vi
fossero a Solofra bravi magistri experti nell’arte del fabbricare
. Tuttavia il poderoso cantiere, sostenuto dall’Università solofrana
titolare ab antiquissimo
tempore dello jus patronato della
chiesa mater et matrice di
sant’Angilo, e controllato dai magistri costituenti la
fabrice omonima, con economi e
procuratori, eletti annualmente, conobbe seri momenti di crisi, in particolare
verso l’anno 1528 con la fine del feudatario
Ercole Zurlo, catturato dagli spagnoli perché filofrancese
nella guerra del Lautrec. Durante tutto l’anno vi fu carestia e peste con
centinaia di morti, proseguita per altri mesi dell’anno 1529. Il cantiere fu
sull’orlo del fallimento più volte, tanto che il
primicerio Cosmo levò il Suo grido contro tutti, in particolare
contro l’Università, il sindaco e gli eletti, per la trascuratezza e la cattiva
sorveglianza dei lavori:…male fatti…! La basilica, nel
frattempo, fu elevata a rango di vera collegiata con bolla dell’ordinario
diocesano nel 1526 e confermata dal santo padre Clemente VII con bolla e sigillo
plumbeo del 1529. Vi fu insediato un Capitolo canonicale di 12 sacerdoti
solofrani con a capo un primicerio; furono stabilite le quote delle prebende ed
ogni altra prerogativa spettante ad un Capitolo collegiale, compreso l’uso del
sigillo proprio. Un esemplare, tra i più antichi, è stato ritrovato dall’Autore
nell’Archivio diocesano salernitano.  La
grande chiesa fu completata a pezzi ed in modo non sempre efficiente;solo nel
1544 furono elevati i pilastri di una delle navate laterali e nel 1553 fu
coperta con tetto a capriate a vista l’imponente navata centrale. Qualche anno
più tardi furono coperte anche le navate laterali. La grande chiesa madre si
completò con la costruzione del turrito campanile , eretto tra il 1565 ed il
1572;due campane magne vi furono poste nella mai completata cella campanaria nel
1576, donate dall’Università titolare del patronato.
La
grande chiesa fu completata a pezzi ed in modo non sempre efficiente;solo nel
1544 furono elevati i pilastri di una delle navate laterali e nel 1553 fu
coperta con tetto a capriate a vista l’imponente navata centrale. Qualche anno
più tardi furono coperte anche le navate laterali. La grande chiesa madre si
completò con la costruzione del turrito campanile , eretto tra il 1565 ed il
1572;due campane magne vi furono poste nella mai completata cella campanaria nel
1576, donate dall’Università titolare del patronato.  Tuttavia
l’imponente cantiere non ebbe fine; tra il 1578 ed il 1583 furono realizzati il
gruppo ligneo/dorato del pulpito, della cantoria, dell’organo e del portale
centrale. Nel 1594 il pittore napoletano Giovan
Bernardo Lama dipinse la pala dell’incoronazione della Vergine e
dei sette arcangeli. Per il tutta la seconda metà del XVI secolo si alternarono
magistri fabbricatori cavesi, scalpellini da Calvanico, artisti napoletani.
Durante il XVII secolo dominarono artisti locali con la bottega dei Guarino ed
il grande cassettonato ligneo/dorato ed i dipinti vetero/testamentari di
Giovantommaso Guarino (1573-1637)
completati dal figlio Francesco nella crociera (1536/1642 ed oltre). Nel 1614 fu
finalmente completato il magnifico apparato lapideo del portale centrale, già
commissionato nel 1553 e mai
Tuttavia
l’imponente cantiere non ebbe fine; tra il 1578 ed il 1583 furono realizzati il
gruppo ligneo/dorato del pulpito, della cantoria, dell’organo e del portale
centrale. Nel 1594 il pittore napoletano Giovan
Bernardo Lama dipinse la pala dell’incoronazione della Vergine e
dei sette arcangeli. Per il tutta la seconda metà del XVI secolo si alternarono
magistri fabbricatori cavesi, scalpellini da Calvanico, artisti napoletani.
Durante il XVII secolo dominarono artisti locali con la bottega dei Guarino ed
il grande cassettonato ligneo/dorato ed i dipinti vetero/testamentari di
Giovantommaso Guarino (1573-1637)
completati dal figlio Francesco nella crociera (1536/1642 ed oltre). Nel 1614 fu
finalmente completato il magnifico apparato lapideo del portale centrale, già
commissionato nel 1553 e mai  eseguito
per il completamento della copertura lignea, urgente ed irrinunciabile. Notevole
appare anche il magnifico pavimento maiolicato
a modulo complesso di fabbrica napoletana, ascrivibile al
maestro dei profili corrucciati, riscoperto
da Francesco Guacci già nel 1978 e ricomposto da più saggi del 1988, eseguiti
sotto il pavimento marmoreo del 1876.
eseguito
per il completamento della copertura lignea, urgente ed irrinunciabile. Notevole
appare anche il magnifico pavimento maiolicato
a modulo complesso di fabbrica napoletana, ascrivibile al
maestro dei profili corrucciati, riscoperto
da Francesco Guacci già nel 1978 e ricomposto da più saggi del 1988, eseguiti
sotto il pavimento marmoreo del 1876.
La collegiata è uno scrigno di
fede, di opere d’arte importanti, alcune ereditate miracolosamente dalla distrutta
chiesa medievale, la stragrande presenza è opera dell’immenso cantiere di
arricchimento decorativo, terminato solo nel 1750, con il grande restauro post
terremoto del 1688, 1731 e 1732. Lunga e complessa è la storia dei suoi primiceri
e degli antichi arcipreti e rettori; una pagina di rara suggestione ricomposta
dall’Autore e di prossima pubblicazione. Il secolo XVIII vide esplodere la
grande fede popolare; Solofra elesse in sant’Antonio da Padova il suo secondo
patrono. Si incentivano le feste sacre e le processioni con i simulacri
ligneo/dorati dei santi portati a spalla;primo fra tutti il bel san
Michele, opera squisita di Giacomo Colombo. 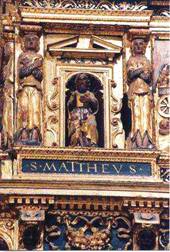 Tradizioni, fede, folclore
ereditate con orgogliosa forza campanilistica. Tuttavia nei tempi recenti
confinate a pura esibizione estetico/visiva, annualmente cadenzata da stereotipe
scenografie viventi neo/pagane. Il testo dell’Autore, in allestimento, è frutto
di una meticolosa ricerca a 360°, durata oltre 16 anni con fruttuosa e
stravolgente rilettura di documenti cartacei inediti o sconosciuti. Una miniera
inesauribile di informazioni storiche sulla vicenda del lungo cantiere della
nuova chiesa collegiata, durato oltre 2 secoli, sui personaggi più eminenti, fra
cui il rettore Giovanni Zurlo e l’arciprete Cosmo Guarino ronca, primo primicerio, veri
artefici della rinascita della nuova collegiata. A loro è dedicata una
biografia molto approfondita, ricomposta attraverso la puntigliosa lettura di
decine di atti cartacei epocali, confrontati e miscelati con eventi storici
collaterali, con una metodologia analitico/descrittiva innovativa. Della nuova
collegiata si conosceranno gli architetti illustri, i magistri scalpellini, i
decoratori, i pittori illustri del viceregno e quelli locali, sconosciuti ma non
di mediocre estro, tanto da costituire in Solofra una vera fucina d’arte
rinascimentale a diffusione provinciale. Così si conosceranno pittori e
scultori solofrani della prima metà del XVI secolo di illustre
prestigio, personaggi nobili, ricchi ed acculturati fautori della costruzione di
palazzi importanti ed opere artistiche notevoli, donate alle numerose chiese e
confraternite di Solofra. Straordinaria quanto stravolgente è la storia
ricomposta della magnifica (…. . distrutta nel 1887 !) chiesa di
sant’Agostino e dell’annesso convento
(…distrutto nel 1985…. sic!), così lontana dalla tradizionale fonte storica
sulla loro origine e fondazione. Dati storici di notevole
suggestione, scientificamente documentati ed annotati, per le numerose chiese
minori, monasteri, palazzi gentilizi oltre al poderoso palazzo ducale degli
Orsini, e la storia archeologica alle
Origini, la genealogia ricomposta dei feudatari, degli artisti minori, degli uomini
illustri che hanno fatto la vera Storia di Solofra, sono descritti
meticolosamente nel testo sulla Collegiata di
san Michele, con grafici e foto inediti, di prossima pubblicazione.
Tradizioni, fede, folclore
ereditate con orgogliosa forza campanilistica. Tuttavia nei tempi recenti
confinate a pura esibizione estetico/visiva, annualmente cadenzata da stereotipe
scenografie viventi neo/pagane. Il testo dell’Autore, in allestimento, è frutto
di una meticolosa ricerca a 360°, durata oltre 16 anni con fruttuosa e
stravolgente rilettura di documenti cartacei inediti o sconosciuti. Una miniera
inesauribile di informazioni storiche sulla vicenda del lungo cantiere della
nuova chiesa collegiata, durato oltre 2 secoli, sui personaggi più eminenti, fra
cui il rettore Giovanni Zurlo e l’arciprete Cosmo Guarino ronca, primo primicerio, veri
artefici della rinascita della nuova collegiata. A loro è dedicata una
biografia molto approfondita, ricomposta attraverso la puntigliosa lettura di
decine di atti cartacei epocali, confrontati e miscelati con eventi storici
collaterali, con una metodologia analitico/descrittiva innovativa. Della nuova
collegiata si conosceranno gli architetti illustri, i magistri scalpellini, i
decoratori, i pittori illustri del viceregno e quelli locali, sconosciuti ma non
di mediocre estro, tanto da costituire in Solofra una vera fucina d’arte
rinascimentale a diffusione provinciale. Così si conosceranno pittori e
scultori solofrani della prima metà del XVI secolo di illustre
prestigio, personaggi nobili, ricchi ed acculturati fautori della costruzione di
palazzi importanti ed opere artistiche notevoli, donate alle numerose chiese e
confraternite di Solofra. Straordinaria quanto stravolgente è la storia
ricomposta della magnifica (…. . distrutta nel 1887 !) chiesa di
sant’Agostino e dell’annesso convento
(…distrutto nel 1985…. sic!), così lontana dalla tradizionale fonte storica
sulla loro origine e fondazione. Dati storici di notevole
suggestione, scientificamente documentati ed annotati, per le numerose chiese
minori, monasteri, palazzi gentilizi oltre al poderoso palazzo ducale degli
Orsini, e la storia archeologica alle
Origini, la genealogia ricomposta dei feudatari, degli artisti minori, degli uomini
illustri che hanno fatto la vera Storia di Solofra, sono descritti
meticolosamente nel testo sulla Collegiata di
san Michele, con grafici e foto inediti, di prossima pubblicazione.
Per approfondimenti si rimanda al testo in preparazione: F. Guacci, la Collegiata di Solofra, un millennio di fede, arte, storia ed archeologia.