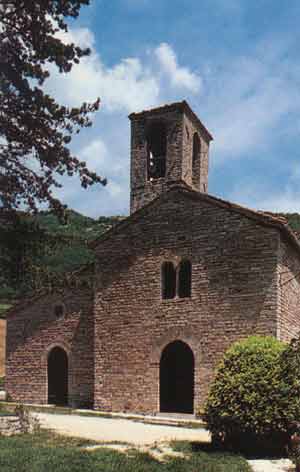
Nella frazione di Fiegni si trova il Santuario del Beato Ugolino, precedentemente chiamata chiesa di
S. Giovanni Battista, nel quale sono custodite le sue spoglie mortali, centro spirituale delle popolazioni locali.
La struttura del Santuario è romanica con due navate e nell’interno vari affreschi, il più antico è quello raffigurante S. Antonio Abate di Paolo Bantulli da Percanestro.
La morte del Beato Ugolino è avvenuta l’11 dicembre 1373.
Le fonti biografiche del Beato sono tardive e scarsissime di elementi storici. La data e il luogo di nascita sono meno certi. La nascita forse risale al 1320, da Magalotto IV e Lucia, che abitavano sia nel palazzo sia nel Castello di Poggio sia in quello di Macereto.
Come luogo di nascita alcuni mettono in dubbio Fiegni, pur accettando che per lungo tempo visse in quel territorio. Fiegni infatti non fu mai feudo dei Magalotti e non vi possedevano né case né terreni.
La causa della sua vocazione, alcune fonti la fanno risalire all’educazione profondamente religiosa datagli dal padre essendo rimasto orfano di madre sin dalla nascita.
Questi avvenimenti segnarono profondamente l’esistenza del giovane
portandolo alla scelta di una vita da eremita su queste montagne, di
penitenza e di povertà, seguendo le orme del poverello d’Assisi; vi
contribuì altresì l’amore non corrisposto per una damigella, Clara
Riguardati da Norcia,sfuggita al conte di Fiastra, fattasi suora di Santa
Chiara a Visso. Ugolino avrebbe potuto stabilirsi dai monaci benedettini di
Rio Sacro, ma poiché era un ordine aristocratico in cui vigeva la proprietà
anche se di tutti, sentì il forte richiamo della povertà e cosi si ritirò in
una piccola grotta ubicata in Val di Nicola in meditazione.
In questo luogo dimorò per 30
anni vivendo in unione di preghiera e di meditazione con Dio, tra digiuni ed
astinenze.
Lo ristorava l’acqua della sorgente a cui la tradizione ha lasciato il nome
del Beato perché sarebbe stata fatta da lui stesso scaturire.
La morte lo colse sulla montagna di Fiegni. Dopo la morte il corpo venne
trasferito nel vicino castello di Fiegni. Viene riconosciuto Beato il 4
dicembre 1856.
Ci parla del Beato Ugolino un manoscritto latino conservato nella chiesa di
Fiegni, ma poi perduto quando nel 1662 morì il parroco D.Pasini.
IL SANTUARIO
L’attuale chiesa del Beato Ugolino, insieme a quella della Canonica
e della casa colonica, non è che il residuo di un antico monastero
benedettino.
Si trova al centro dell’esedra, che nelle antiche scritture prende il nome
di Valle Segge.
Si pensa che gli abitanti situati intorno all’abbazia monastica abbiano
costituito in seguito la comunità di Fiegni, dove sorse ben presto una
chiesa plebale, con diritti e giurisdizione ecclesiastica.
Il suo nome era S. Flaviano, di cui ancora oggi si conserva il suo fonte
battesimale.
Si trova sul punto più alto della sella spartiacque e dentro il perimetro
del castello. Tuttavia nel ‘300 la vita benedettina di queste valli era in
crisi e i monasteri erano sempre di meno. Alla morte del Beato Ugolino, la
chiesa con il nome di S. Giovanni Battista, era già stata abbandonata dai
religiosi e quindi rimase sotto il controllo della chiesa di S. Flaviano.
Nel 1373 il corpo del Beato Ugolino viene deposto nella chiesa di S.
Giovanni, e così accentra il culto delle popolazioni di Fiegni.
Al titolo di S. Giovanni dapprima si aggiunge a voce di popolo quello di
Ugolino che poi entra negli atti ufficiali.
Gli elementi architettonici della vecchia chiesa benedettina, sebbene
sopraffatti da trasformazioni e restauri non sempre soddisfacenti, sono
ancora evidenti. Saldezza romanica nello spessore dei muri e nella linea
degli archi a pieno centro o ribassati.
In origine aveva tre navate, invece oggi non rimane che la navata centrale
con soffitto a capriate e chiusa dall’abside semicircolare e la sinistra
comunicanti attraverso due archi sostenuti da un pilastro al mezzo. Il
soffitto spiovente di questa è a semplici travi scoperte; all’esterno, sulla
facciata, ha un bel portale in pietra bianca.
In corrispondenza della navata centrale c’è un antico arco acuto di rozze
pietre ; sopra la porta principale d’ingresso, c’è scolpito, al vertice ,
un simbolico animale dalle forme grossolanamente trattate e difficilmente
classificabile. Nell’interno, oltre la struttura architettonica, solo le
pietre elegantemente scolpite nella parte anteriore e centrale dell’altare
maggiore , conservano il ricordo della costruzione primitiva. La navata
centrale, specialmente nella parte del presbiterio, ci offre un ciclo di
pitture dei sec. XVI e XVII, notevole documento della storia della chiesa e
del culto del Beato Ugolino, anche se mediocre espressione di tecnica e di
arte. A metà circa della parete destra della navata maggiore, un affresco
rappresenta S. Carlo Borromeo in preghiera. Il catino absidale è tutto
occupato dall’Incoronazione della Madonna: la Vergine è al centro di uno
sfondo di cielo, inginocchiata con le braccia incrociate sul petto e avvolta
in un ampio manto turchino tempestato di stelle, fra l’Eterno Padre, alla
sua sinistra, e il Redentore alla destra, in atto di porle sul capo la
corona. Con la destra il Cristo sostiene un’enorme croce mentre l’Eterno
appoggia la sinistra sulla sfera del mondo. Al di sopra di Maria la colomba
dello Spirito Santo. Tutte le quattro figure sono incorniciate da enormi
aureole di scarso gusto. Ai lati Angeli musicanti che vanno a congiungersi
al sommo dell’arco e ai piedi delle tre figure centrali. Intorno all’abside,
in continuazione del catino e fino a mt. 1,60 da terra, sono rappresentate
sei grandi figure di Santi disposti simmetricamente tre a destra e tre a
sinistra di una antica finestrina leggermente spostata dal centro, e
inquadrate da leggere cornici pittoriche a fiorami, non tutte uguali. Al di
sotto di ciascuna figura sono segnati i nomi in lingua italiana; da sinistra
a destra:
S. Paolo Apostolo, S. Carlo Borromeo e il B. Ugolino, S. Lucia, S.
Apollonia, S. Vittoria.
Le tre Sante, oltre l’aureola, hanno una corona di
fiori intorno al capo e in mano gli emblemi del loro martirio. Sul pilastro
che sorregge i due archi di valico alla navata sinistra e nella parte
interna di questa è dipinto, pure un affresco, S. Antonio Abate che è anche
la pittura più antica fra tutte. La Chiesa ha subito notevoli trasformazioni
attraverso i secoli e recentemente a cura dell’Ufficio Amministrativo
Diocesano è stata particolarmente consolidata nelle strutture murarie.
