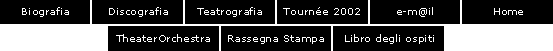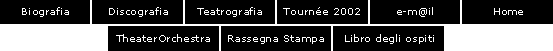
Rassegna Stampa |
Le anime di milioni di vittime tornano a cantare l'indicibile |
di Giovanni Raboni |
| Meglio dirlo subito: il Dybbuk di Moni Ovadia e Mara Cantoni non è fatto per chi crede che si debba o si possa dimenticare ciò che è successo in Europa mezzo secolo fà. O forse, invece, è fatto proprio per loro: ma come il rimorso è fatto per i colpevoli e la giustizia per gli ingiusti. Lo spettacolo, che è prodotto (come iprecedenti di Ovadia) dal CRT Artificio, è di quelli che non si raccontano: e non soltanto per le sue caratteristiche strutturali - si tratta, in sostanza, di un ininterrotto rito musicale in cui è la stessa musica a farsi evidenza corporea, immagine e narrazione -, ma anche e soprattutto perché racconta, appunto, ciò che non si può raccontare: la realtà delle deportazioni, dei campi di sterminio, della Shoah: Una realtà che in Oylem Goylem, con cui Ovadia si era imposto nelle scorse stagioni alla nostra ammirazione, vi era presente come un segreto taciuto, o appena alluso, come il non detto che dà senso al detto; e il detto era, là, il frasario della nostalgia e della sopravvivenza, l'identità culturale e religiosa del popolo ebraico difesa con disperata tenacia ma anche con le armi sottili del paradosso e dell'ironia. Mentre in Dybbuk balza essa stessa in primo piano a chiedere, a esigere d'essere testimoniata. Sono stati i tempi in cui viviamo - tempi di oblii dolosi e colposi - di revisionismo e "sdoganamenti" - o è stato un'evoluzione interiore a dettare questo mutamento? L'una e l'altra cosa, direi. Sulla prima, temo che non occorra spendere parole: tutti l'abbiamo sotto gli occhi. Quanto alla seconda, penso che ogni grande artista (e Ovadia lo è) preceda più o meno gradualmente, nella sua storia espressiva, dai margini al centro, dalle affascinanti ceremonie della reticenza alla "spudoratezza" della verità. Così è stato in questi anni, ora possiamo rendercene conto, per questo geniale autore-attore-cantante concentrato sino allo spasimo, come su una missione, sui temi che qualcuno o qualcosa ha irrevocabilmente assegnati. Ed eccolo arrivato, così, con l'aiuto congeniale di una compagna di lavoro che giàaltre volte gli era stata accanto, a questo splendido, sconvolgente punto di non ritorno. Ho già detto che lo spettacolo non si può raccontare; mi limito a suggerirne qualche dato essenziale. Il dybbuk, nella cultura ebraica dell'Est, è "l'anima di un essere umano la cui vita è stata spezzata prematuramente con violenza e che torna a possedere un vivo"; qui, naturalmente, è l'intero popolo della Shoah, rappresentato in scena dallo Sposo e dalla Sposa, entrambi deportati, e da un'orchestra di dodici elementi - una di quelle orchestre che i nazisti organizzavano con gli "ospiti" dei loro campi. Quanto alla partitura verbale, deriva da una elaborazione di due testi della tradizione letteraria yiddish: un dramma dello scrittore romantico An-ski intitolato appunto Dybbuk, e il Canto del popolo ebreo massacrato del poeta Yitzchak Katzenelson, ucciso ad Auschwitz nel 1944. Le lingue in cui si parla e si canta sono l'ebraico, lo yiddish, il tedesco, l'italiano; ciò che importa capire si capisce, ciò che non si capisce entra ancora più violentemente e irracusabilmente, a mio avviso, nella mente e nell'anima (ma di tutto è disponibile, nel programma di sala, la traduzione). Ed è inutile dire che oltre ai due Sposi e ai dodici meravigliosi suonatori-attori che dispiace non poter citare un per uno, è continuamente e costitutivamente presente nella veste del "testimone" - che vuol dire anche, si capisce, l'evocatore, la guida, il maestro delle apparizioni, il regista e, soprattutto, il "posseduto", il vivo nel quale le anime di tutti i morti urgono per entrare - lui, Moni Ovadia: lui con le sue canzoni, le sue invettive, le sue preghiere; lui al centro o ai margini di ogni processione e di ogni liturgia sonora. Sono stati cento minuti di un'emozione continua, quasi insostenibili, senza pausa o lacune; poi, un trionfo. |