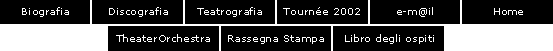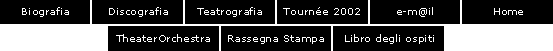
Rassegna Stampa |
"Dybbuk", voci yiddish lontane sempre presenti |
di Oliviero Ponte Di Pino |
| In questo fine secolo - un secolo che si è macchiato dei peggiori massacri della storia, e che si sta chiudendo con altre stragi d'innocenti, da Sarajevo al Ruanda, dall'Algeria al Chiapas, e da domani anche altrove - assumono un rilievo ancora più lancinante fue antiutopie teatrali: quella delineata da Jean Genet nel saggio La strana parola di...dove s'immaginava di recitare nei cimiteri; e quella teorizzata e praticata da Tadeusz Kantor nel suo "Teatro della Morte". Da queste visioni, e dalla riflessione sulla possibilità della poesia e sul concetto di Dio dopo Auschwitz, si è messo Moni Ovadia (in collaborazione con Mara Cantoni) per approdare a Dybbuk. Sulla scena, Ovadia è il "Testimone", ma anche il narratore e l'officiante di un lancinante rituale, costruito sull'intreccio di due testi. Uno è per l'appunto Il Dybbuk di An-ski, lo scrittore che diede forma a un'antica leggenda ebraica, secondo la quale chi muore prima del tempo, per morte violenta, resta sulla terra cercando pace nelle anime dei vivi, e dunque tormentandole. Protagonista del dramma di An-ski, che fu portavoce della rinascita della consapevolezza ebraica e della cultura yiddish all'inizio del secolo, è la coppia di sposi che vediamo in scena, a cantare il loro amore ormai impossibile, doloroso e ossessivo. Lei nel suo abito bianco, sposa in attesa del suo promesseo. Lui destinanato a confondersi sempre più nella folla dei morti, senza smettere mai di cercarla. Il secondo testo utilizzato da Moni Ovadia per questo Dybbuk è Il Canto del popolo ebraico massacrato di Yitzchak Katzenelson, poema composto per incarico del collegio ebraico del ghetto di Varsavia, inciso nella memoria, poi trascritto e sepolto nel campo di Vittel (n Francia), e ricuperato doo la fine della guerra (e dopo la morte dell'autore ad Auschwitz). Questo Canto è dunque stato scritto durante Auschwitz e non dopo. Ed è poesia, certo, spesso altissima. Ma è anche una poesia di atroce durezza, quasi insostenibile, un grido di dolore che potrebbe essere strappato a Giobbe, e che ruota intorna ad una grande domanda, forse la più grande: com'è possibile che agli Dei del cielo abbiamo permesso tutto questo? Che Dio può essere quello che ha lasciato sterminare un intero popolo e i suoi figli innocenti? "Ciascuno dei miei bimbi ammazzati può essere il loro Dio!", grida il poeta. Come un Dybbuk, il popolo massacrato invade l'anima del "vivo". Tormenta il Testimone, il Sopravvisuto, non dà pace alla sua solitudine. Come un Dybbuk, lo invade anche la lingua di quel popolo martoriato, lo yiddish. Anch'essa massacrata, cancellata, azzerrata, come la sua cultura. E lo invade il canto. Canzoni popolari e inni di lotta e di sconfitta, composti nei ghetti assediati, e ora ricreati sulla scena dai deportati: una di quelle orchestre che accoglievano i treni da cui sbarcavano i prigionieri all'arrivo, e che li accompagnavano allo sterminio. Forse è proprio questa l'invenzione più spettacolare di un allestimento semplicissimo, e perciò perfetto nella sua linearità: i dodici musicisti-attori della TheaterOrchestra nelle loro divise grigie, lacere e spente. Quasi tutti scalzi, anime morte eppure presenti, in continuo movimento, compongono figurazioni di atroce efficacia e bellezza, animando incessantemente lo spazio della memoria. Sono loro a risalire l'oblio come un contagio, con tempi ballabili e melodie che portano in sé un dolore infinito, un'ironia disperata, fatta di ritmi trascinanti che spingono verso la danza o verso la processione rituale; e di pathos travolgente, che invita alla passione d'amore o all'estasi mistica. Fatta di riso e di lacrime insieme. A tornare, dunque, evocata da questi suoni dolcissimi e strazianti, è una voce che invade e possiede. Una voce che dal nulla si fa canto e preghiera, maledizione e lamento funebre, rantolo e urlo, sospiro. Poesia e memoria. Bestemmia, a tratti. Ecco così l'essenza intimamente musicale degli spettacoli di Moni Ovadia, la sua ricerca vocale e religiosa. Mentre canta, si ascolta continuamente: ascolta quella che è insieme la propria voce e una voce che viene da un altrove irraggiungibile, precario, forse illusorio. In questa discrepanza continua interrogazione, sta l'attenzione che dà vita al suo canto. |