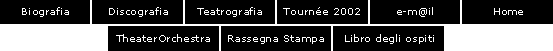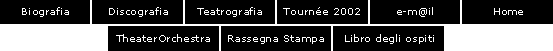
Rassegna Stampa |
Sposi per lo sterminio |
di Franco Quadri |
| Moni Ovadia continua la rivisitazione del teatro ebraico in chiave personale e, con la sua magnifica TheaterOrchestra, ora passa dal divertimento del cabaret al grande requiem. A ispirarlo è Il Dybbuk, il testo scritto dal polacco Shlomo An-ski all'inizio del secolo, divenuto famoso più che per i suoi valori grazie allo spettacolo-capolavoro che ne trasse nel 1920 Vachtangov al Teatro Nabima di Mosca. E una decina d'anni fà Bruce Myers, attore israeliano, ne creò all'interno del gruppo di Peter Brook una rielaborazione per due interpreti destinatata a fare il giro del mondo e a rivivere, con Franco Parenti e Lucilla Morlacchi, in quello stesso salone Pier Lombardo che ora ospita e coproduce con il CRT Artificio l'attuale proposta. Ma in questo contenitore, assai appropriato per il suo aspetto diroccato e fatiscente, il testo originale del dramma serve solo da spunto. Il "dybbuk" è uno spirito sopravvissuto a una violenta fine terrena, che cerca d'impossessarsi di un nuovo corpo: e nella pièce tocca a un fidanzato sfortunato reincarnarsi nella sposa mancata per frustrarne un altro matrimonio. Ora la vicenda si contamina confrontandosi non con una fine singola ma con un'ecatombe, l'Olocausto: dopo le nozze i due sposi vivono la prova terrificante dello sterminio. Sono infatti loro stessi deportati: dopo il discorso di Hitler che aveva suggellato l'entrata della troupe, dopo il rito festoso dell'unione, il rumore del treno fatale accompagna il girovagare del gruppo sulla scena. Il destino della coppia resta indissolubile da quello dell'orchestra, che indossa le uniforme grigie ed azzerranti del lager. I versi salvati del testo di An-ski, che Claudia Della Seta e Olek Mincer recitano in yiddish, s'incrociano o si sovrappongono al canto ebraico dei suonatori: ma s'alternano anche ai giambi ritmati che Moni Ovadia ci declama, ci sussurra, c'insuffla in veste di testimone, tratti da un poema di un altro polacco, "Il canto del popolo ebreo massacrato" di Yitzchak Katzenelson, scritto su ordinazione del comitato di resistenza durante la rivolta del ghetto di Varsavia nel '43, prima della sua morte a Auschwitz. Il lirico sconsolato lamento, dalla cronaca tremenda e incredula all'accusa verso il silenzio divino, si riconduce alla coralità di altri esili che hanno costellato la passione del popolo eletto. Moni Ovadia, che ha montato con Mara Cantoni il complesso discorso, disceso dall'alto della gradinata come un sacerdote, lo pronuncia magari aggirandosi col rotolo della Torah come un officiante. E ha luogo un vero cerimoniale, che include anche la festa d'apertura col lungo valzer a piedi nudi o il motivo di "Rosamunda" che scandisce l'incolonnarsi della lugubre processione carceraria. Nelle geometrie del coro di vittime condannate al moto perpetuo, avanti e indietro sulla scena tutte assieme e poi via in fila in girotondo senza fine, si possono cogliere suggestioni di Kantor. Ma fa pure capolino il ricordo dell'orchestrina di ciechi di Raffaele Viviani, una marcia arieggia Brecht e si sente un'eco dei "Mysteries" del Living accanto a una bocca che si spalanca come nell'"Urlo" di Munch; è la nostra cultura - anche quella di chi non è ebreo - accorsa per urlarci la sua impotenza angosciata davanti all'assassinio industrializzato, al rifiuto della ragione. Le toccanti immagini della sposa che non smette di cercare rifugio nel rito, dietro il suo velo bianco teso, s'assommano e si confondono con quelle dell'orchestra recitante che avanza con le mani in alto fino al proscenio o esegua il suo ultimo pezzo, interrotto dalla mitraglia, con le corde da impiccati a legarne i corpi al cielo. Non ci sono parole. E la concomittanza col ritorno in un vicino teatro milanese dell'Istruttoria di Peter Weiss fa pensare che non sia casuale questo riaffiorare trascinante di una memoria che qualcuno vorrebbe cancellare. |