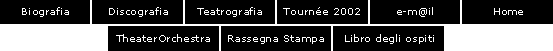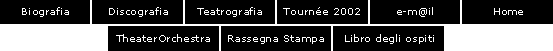"Ricordarsi di non dimenticare" sta scritto sul questionario distribuito nel foyer del Teatro Franco Parenti, per un Museo Ebraico dell'Olocausto a Milano. E la memoria è il motivo ispiratore di "Dybbuk", l'ultimo spettacolo di Moni Ovadia e Mara Cantoni. Dal dramma in quattro atti di Shlomo Rapoport, detto An-ski, e il Canto del popolo ebraico massacrato di Yitzchak Katzenelson, testimone vittima dello streminio nazista. Quel dybbuk della tradizione cabbalistico-chassidica, l'anima di un ussico che per compiere il suo destino s'impossessa del corpo di un vivo. L'anima del poeta morto ad Auschwitz, sul palcoscenico di via Pier Lombardo. In una scenogarfia ridotta ai cordami, le tavole, i mattoni rossi fornace del teatro, per i dodici musicanti klezmer della TheaterOrchestra. Scalzi, pallidi, l'uniforme grigia dell'orchestrina di Treblinka che agli aguzzini suonava Rosamunda, "la caduta nel kitsch del mito nibelungico", secondo Moni Ovadia. Il suo urlo funereo a tratti interrompe questo mix di musiche di strada e paraliturgiche, stemperandosi nelle note cantate dai chassidim quando andavano nelle camere a gas. Qui non c'è spettacolo, ma la rielaborazione di un lutto, dolore tutto yiddish, incomunicabile. Come lo si può far capire agli altri? "Cieli che stavate a guardare, cieli azzurri, in voi non c'è nessun Dio!" esclama il poeta-teatrante, quasi blasfemo, rivolgendosi direttamente agli spettatori. Come per chiamarli in causa, perché nessuno è innocente o come diceva Pier Paolo Pasolini "l'innocenza è una colpa". Rituale di liberazione, questo, non solo per il popolo ebraico, ben oltre la rievocazione storica dell'Olocausto:"Qui i nazisti sono solo echi, voci, la vera domanda - spiega l'attore - è perché l'umanità abbia fatto questo a se stessa". E gli ebrei secondo Moni Ovadia sono un po' in tutti noi, "un uomo che cominciò a riflettere sul suo ombelico, costruendo un ethos che è tre quarti del mondo". Sotto le luci delle lampade, basse, quei cali di tensione così funerei, la musica regala le suggestioni d'un Oriente mitteleuropeo fatto di note tzigane che a tratti sembrano fondersi col canto dei muezzin. Musiche da Scheunenviertel, di quel ghetto "bellissimo" che era la parte migliore di noi. Il cuore di un Europa che non esiste più, Mitteleuropa di transiti, vagabondaggi di confine, indisciplinate flaneurie di apolidi cittadini di una terra di mezzo, terra di nessuno, anzi, di tutti. Ora non c'è che deserto, un appello di nomi senza risposta, numeri, pianto, la memoria che è un urlo soffocato.
Sul palco entra una coppia di sposi con la valigia in mano. Leah e Chanan, lo sposo predestinato alla morte sentendo che lei avrebbe sposato: sono gli uomini e le donne dei lager e l'umanità intera divisa tra vita e morte, in bilico sui suoi ricordi. Quella memoria che non è morta, passato da conservare nella teca di un museo se non da rimuovere, addirittura: ma un marchio a vita, un fardello di disperazione e speranza di vita per il futuro. Una vitalità dell'arte, insomma. Il modo di Moni Ovadia per rappresentare la memoria. |