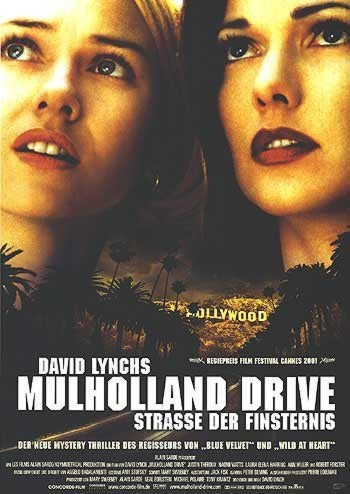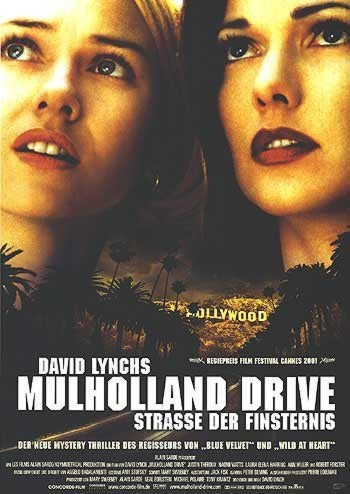Mulholland
Drive
di
David Lynch
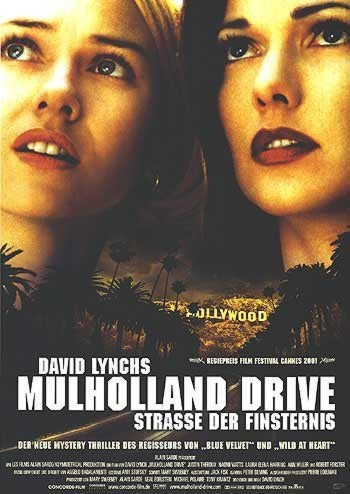
Fr.-USA 2001 - Durata 146 Min.
REGIA di David Lynch con Naomi Watts, Laura
Elena Harring, Justin Theroux, Ann Miller,
Robert Forster.
Ultimo
lungometraggio firmato da David Lynch, nasce ufficialmente come il pilot
di una serie televisiva abortita dalla “Abc”. Archiviato dalla
popolare rete americana con l’accusa di incomprensibilità, il pilot
diventa un lungometraggio grazie al francese Alain Sarde e al suo
“Studio Canal”, che già aveva collaborato col regista per The
Straight Story
(Una storia vera, 1999).
Con
Mulholland Drive il
cerchio “ambiguo”, secondo un’accezione di Dario Tomasi, sembra
chiudersi definitivamente. Non solo per la totale, lucida coerenza di una
mente che da quasi trent’anni si nutre e alimenta l’immaginario
cinematografico contemporaneo (dimostrando l’autorialità di questo
regista), ma soprattutto per ciò che il suo “mondo virtuale”
significa all’interno del “mondo reale” del cinema. Mulholland
Drive infatti, è “una storia d’amore nella città dei
sogni”, ma anche un piccolo aneddoto sui tortuosi ingranaggi dello
spettacolo, un’ indagine onirica sul bene e il male, e ovviamente...
mille altre cose.
Un
gruppo di ballerini modello anni Cinquanta, si muovono a suon di musica su
uno sfondo viola. Stacco. Una giovane donna bionda (Naomi Watts) sorride,
immersa in una luce accecante. Stacco. Un letto vuoto, le lenzuola, la
coperta, un cuscino rosso. Dissolvenza in nero. Ancora la dimensione
onirica del racconto, il suo andamento a spirale, il gioco delle identità;
e poi il desiderio e la sua negazione, il nano, la Stanza Rossa in cui si
muovono inquietanti personaggi (non lontana da quella di Fire
Walk with Me)... I topoi lynchiani sono sempre quelli. Eppure in
quest’ultima opera firmata dal regista del Montana, entra in gioco
qualcosa in più, un elemento che sembra portare a compimento quella
poetica che abbiamo definito del “sublime espressionista postmoderno”.
L’elemento in questione è il cinema stesso, inteso come focalizzazione
sui meccanismi nascosti dello spettacolo: la facoltà di creare sogni per
poi arbitrariamente distruggerli, l’intreccio delle parti, il gioco dei
ruoli, l’importanza delle gerarchie all’interno di un mondo dorato
dove tutto e il contrario di tutto risultano realmente possibili.
Tralasciando per un momento il contenuto in fondo
lineare della storia d’amore saffico finita in rovine, Mulholland
Drive presenta una serie intrecciata di personaggi e vicende che
al solito porta con sé i connotati del “lynchianismo” puro. Primo
elemento da ricordare, quel piccolo cubo blu, pescato fra le cianfrusaglie
e gli avanzi di un misterioso barbone, rifugiato sul retro di un diner
della catena Winkies. Un oggetto pronto a testimoniare che lo scambio di
mondi è possibile, e che spesso a manovrarne misteriosamente i fili non
è proprio la fatina buona del mago di Oz.
David Lynch costruisce ogni inquadratura del suo universo astratto
e simbolico con minuzia e precisione, non lasciando mai nulla al caso (a
meno che il caso non vi si infili di proposito), né al gratuito: non
tenta di aprire false piste giocando con lo spettatore - nella più
classica “maniera” postmoderna - al cruciverba audiovisivo
provocatorio e destrutturato. Anche quando “non significa”, ogni
inquadratura “significa” sempre, direbbe Wallace, e ha ragione. In
realtà Lynch, esercitando il controllo assoluto su ogni singolo elemento
linguistico, mai si trova a sollecitare gratuitamente l’irrazionalità,
piuttosto si dimostra sempre rivolto alla creazione di un “disegno
retorico fondato sulla messa a punto di un dispositivo emozionale spinto
al massimo, (che) non mira alla confusione”.
Mulholland
Drive
si presenta diviso in due segmenti, sulla scia del precedente Lost Highway (di cui sembrerebbe rappresentare quasi una versione
“al femminile”). In una delle inquadrature iniziali, riconosciamo la
soggettiva di un cuscino che, sarà chiaro soltanto dopo, è quella di
Diane che si appresta ad adagiarsi sul letto. Ciò che segue da questo
momento in poi, potrebbe essere tanto la simulazione virtuale di un sogno,
un “sogno pre-morte” in cui Diane immagina una vita felice da attrice
in carriera e amante ricambiata, quanto la visione ultraterrena di un
“sogno post-mortem” in cui la donna vede realizzati i sogni terrestri.
O in modo ancora più semplice, a diventare visibile sullo schermo
potrebbe essere il costante scambio di dimensioni e identità parallele
con cui il cinema di Lynch da sempre si diverte (con “coscienza”) a
giocare. Il progetto di un cinema come “scrittura del sogno” allora,
rimane coerente fin da Eraserhead,
“cinematizzazione” di un incubo personale del regista sul tema della
generazione e della paternità. Con Mulholland
Drive l’incubo s’ intreccia al sogno, che a sua volta si
presenta legato al meccanismo cinematografico, il cui potere mitopoietico
risucchia irreparabilmente vita e relazioni umane. La narrazione si dipana
ancora una volta all’insegna della circolarità (apparente): una strada
percorsa a folle velocità verso le lost highways prima, una luce in cui
Diane sorride, lontana dalla sofferenza, adesso. La struttura ellittica
del racconto, pur presentando continue sfasature ed elementi variamente
disarmanti (vedi la sequenza iniziale dell’uomo letteralmente
“spaventato a morte” dalla visione onirica di un barbone), non si
risolve nel capovolgimento della narrazione, né sembrerebbe renderla in
qualche modo impercorribile. La messa a punto di precise “rotture di
equilibrio” all’interno del racconto, veri “buchi neri” dosati e
calibrati attentamente nel corso della diegesi, non diviene mai sinonimo
di “antinarrazione”; piuttosto sembra voler assumere i connotati di
una precisa riflessione sui meccanismi di significazione in atto al
cinema, di stampo postmoderno. Se poi a questo, aggiungiamo la spinta
continua verso una forma archetipica di “mistero” (che coincide
significativamente con il concetto di “enigma contemporaneo” di
impronta borgesiana), una poetica che fa deflagrare i concetti di spazio e
tempo attraverso la definizione di “spazi percettivi” e la
“detemporalizzazione” degli eventi, un discorso filmico intertestuale
costellato di riferimenti al medium spettacolare, e infine una serie di
immagini (e suoni) rivolta alla produzione di un unico “feeling”,
secondo le parole stesse del regista, avremo ancora una volta quello che
chiamiamo un “cinema espressionista e postmoderno”. Perfino il dato
acustico, infatti, risulta subordinato a questo progetto generale, di dar
forma a un mondo onirico-surreale (inconscio), non troppo lontano dal
nostro quotidiano, fatto anche di materia cinematografica (citazioni
intertestuali), col fine ultimo di rappresentare un unico, totalizzante e
polisensoriale “stato emotivo”. Il cinema lynchiano allora, può dirsi
espressionista, ma può definirsi anche postmoderno nella misura in cui,
piuttosto che capovolgere radicalmente il linguaggio cinematografico,
tenta di renderlo “inservibile”, quasi “inutile”, suggerendo nuovi
approcci (quello di assumere “alla lettera” il senso delle sue storie
assurde è uno di questi), e dimostrando la velleità di un progetto
interpretativo finora basato (quasi esclusivamente) sull’applicazione di
procedimenti logico-analitici. Può dirsi “postmoderno”, inoltre,
perché oltre a dare una sferzata di energia al concetto di “consumo
filmico” e di ricezione del prodotto audiovisivo (grazie al suo tipico
coinvolgimento emotivo, percettivo e sensoriale), si rende al tempo stesso
portavoce delle angosce dell’uomo contemporaneo, della perdita dei punti
di riferimento in una società opprimente e dominata dall’immagine
mediale. Di qui il passo è breve verso quella poetica ibrida, tipicamente
lynchiana, di “macabro + banale”, descritta brillantemente da Wallace.
Risultato di questa bizzarra equazione sembra essere una sorta di
“macabra ironia del quotidiano” d’impronta postmoderna. E di questa
sottile ironia (esclusa dai primi cortometraggi, come da Elephant
Man), sarebbero “portatori sani” Eraserhead,
Blue Velvet, Fire
Walk with Me, Lost Highway
e anche Mulholland Drive.
L’“ironia del macabro” nel cinema di Lynch, si scopre allora
quintessenza del postmoderno, in quanto realizza la medesima operazione
ibrida che unisce contenuti alti e bassi, portando a compimento
l’identico meccanismo sotteso al palinsesto televisivo: la fusione
simultanea di vita reale e fiction, di cronaca nera e videoclip
pubblicitario, in una parola di infinitamente macabro e infinitamente
banale.
Tornando
a noi, Mulholland Drive
ritrova “il tema del doppio come convergenza perturbante dell’identico
e del diverso”, com’era già successo in Lost
Highway, e come sempre nelle visioni deliranti dei film di Lynch.
Betty rappresenta tutto ciò che Diane avrebbe voluto essere, Rita è
colei che Diane avrebbe voluto amare. Un gioco di relazioni reali e
fittizie, ma soprattutto di sentimenti e percezioni ambiguamente
“familiari”. Infatti
Mulholland Drive
è anche un film che indaga sulla natura paradossale e grottesca del
quotidiano. I fratelli Castigliani, la coppia di vecchietti, l’uomo in
preda a incubi “mortali”, la strage involontaria compiuta dal killer
nel tentativo di rubare il libro nero di Ed (ma poi chi è questo
Ed? e che cosa è contenuto nel libro nero?), sono tutti frammenti
di storie introdotti e lasciati sospesi dal regista (oltre che per il
motivo contingente che il film nasce come un serial), per meditare su
fatti reali, e per confermare ancora una volta il fatto che di
“macabro” e “banale” sia impregnata la vita di ogni giorno.