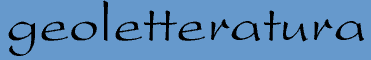 |
| Indice della sezione | Le altre sezioni | Torna alla Home |
|
La trimurti del romanzo americano: Hemingway,
Faulkner, Scott-Fitzgerrald Pier Francesco Paolini
|
||
|
1/2 |
||
|
I. DILETTANTI E PROFESSIONISTI DELLA VITA IN HEMINGWAY Ai piedi del monte Kilimangiaro, in Africa, un uomo giace — in attesa della morte — su una branda, all'ombra di una mimosa, guardato a vista da alcuni avvoltoi. La gangrena lo sta divorando, da quando si è graffiato con uno spino durante un safari. Quest'uomo, a nome Harry, è uno scrittore che ha "distrutto il proprio talento a furia di non usarlo". E ora, rivangando il passato, si rende conto di aver tradito sé stesso perché ha rinunciato ad essere un serio professionista per condurre una vita da allegro dilettante. Ormai è troppo tardi e, nel corso dei suoi amari rimuginamenti, incorriamo in questo illuminante scambio di battute fra il moribondo e sua moglie:
La citazione è tratta dal celeberrimo racconto "Le nevi del Kilimangiaro" di Ernest Hemingway. In un altro racconto dal titolo "Un idillio alpino" troviamo questo identico concetto — sebbene in un contesto tutt'altro che drammatico — espresso nel dialogo fra due turisti reduci da un'escursione in montagna.
Questo tema, di qualcosa che "si protrae troppo a lungo" — sia l'attesa della morte o sia la mancanza di birra — spunta con tanta frequenza e insistenza qua e là, in tutta l'opera di Hemingway, da indurci a ritenere che si tratti di un sintomo ben preciso. Il sintomo di un malessere che affligge alcuni personaggi hemingweiani — quelli cioè che vivono la vita con spirito da "dilettante" nel senso più vasto del termine, in netto contrasto con quei pochi "eroi" che invece vivono da professionisti, quale che sia la loro vocazione, quali che siano il loro mestiere e il loro talento. Gli uni, i dilettanti, sono destinati alla sconfitta — morale o materiale — sono insomma dei falliti, mentre gli altri — i professionisti — saranno invece dei vincitori, anche quando "non prendono nulla" ("Winners Take Nothing" è un celebre titolo di Hemingway) e saranno, anche quando soccombono, degli invitti. "L'invitto" (The Undefeated) è appunto il titolo di uno dei maggiori racconti di Hemingway. È la storia di un anziano torero alle sue ultime armi, Manuel Garcia. Quando Manuel Garcia, appena uscito dall'ospedale, si presenta a un impresario di corride, la sua posizione di "professionista" si delinea dalle primissime battute.
Anche ai consigli dell'amico Zurito, che gli chiede perché non la smette e non si taglia la coleta (cioè la treccina caratteristica dei toreadores) Manuel Garcia risponde con la stessa tenace semplicità: "Non lo so. Ma devo." E poi alla fine (sconfitto ma invitto) anche sul tavolo operatorio troverà in punto di morte la forza di opporsi al taglio di quel segno emblematico della sua professione e della sua illusione. Dilettante è, dunque, bene spesso sinonimo di "fallito" nel mondo
di Hemingway. E il malessere che affligge i suoi falliti è soprattutto
una "noia" di tipo speciale, diversa dalla noia romantica degli
eroi di Stendhal, dal tedio filosofico di Leopardi, o dalla inerzia
di Oblomov, per fare tre esempi disparati. La noia di marca hemingweiana
deriva dalla mancanza di un ubi consistam, di un perno
intorno al quale ruotino il senso del dovere, l'impegno, l'ideale
insomma di una vita professionalmente vissuta. Questo tema, con
le sue variazioni, ricorre — come si è detto — in tutta
l'opera di Hemingway. Se ne colgono rifrazioni in un racconto
minore come Oggi è venerdì:
E così pure nel celebre racconto "The Killers" (I sicari) laddove un uomo braccato che attende l'arrivo dei suoi uccisori dice al giovane ch'è andato ad avvertirlo perché si metta in salvo:
E così pure in quel capolavoro che è Il sole sorge ancora, da cui citiamo due diversi passi:
In queste e altre consimili battute (ora dritte come frecciate, ora svagate come ritornelli; ora in situazioni centrali, ora in marginali episodi) ci è dato individuare un importante aspetto del dissidio interiore che angoscia chi non ha impegnato la propria anima, pienamente, in alcunché, ed è abbastanza cosciente e intelligente da rendersene dolorosamente conto. Uno smagliante esempio del conflitto, predominante nell'opera di Hemingway, fra queste due opposte concezioni di vita — che abbiamo, per comodità, definito "da dilettante" e "da professionista" — ci è offerto dal grande racconto Breve la vita felice di Francis Macomber. Al pari del protagonista delle Nevi del Kilimangiaro, anche Macomber è finora vissuto in un ambiente di ingannevole ricchezza, di "accidia e snobismo", ma ecco che, durante una battuta di caccia al leone, egli si rivela per quello che è in sostanza: un codardo. Ora, per lui il leone rappresenta il momento della verità, della crisi, del redde rationem. A questo dilettante si contrappone un professionista per antonomasia: il cacciatore bianco Robert Wilson, che sotto la maschera quasi cinica di uno che fa qualcosa solo perché è pagato per farlo, cela il volto di un vero umanista — a suo modo. Oltretutto, cita Shakespeare. Fra i due si inserisce la moglie di Macomber, Margot, la quale — obbedendo all'istinto primordiale e ferino di una lupa che sceglie il più forte del branco — per punire la codardia del marito, si concede al cacciatore di professione. Quando Macomber trova la forza e il coraggio di riscattarsi, la donna — con fredda determinazione, simulando un incidente di caccia — lo uccide. Leggiamo alcuni passi essenziali di questo stupendo racconto:
Ma un colpo di fucile a tradimento arresta Macomber nel pieno del suo slancio vitale. Orbene, per Macomber il momento maligno della morte rappresenta il momento radioso e culminante della su "breve vita felice" e, quasi, il suggello del suo trionfo: la vittoria cioè della parte migliore di sé sulla paura che sta, oltretutto, a simboleggiare quanto c'è di dispersivo, di ignobile, e, nel senso tutto speciale — e specifico hemingwayano — che qui si è dato a questo termine, di "dilettantesco" nella vita umana. *** Ernest Hemingway,
di cui ricorreva nel 1999 il centenario della nascita, conobbe
il successo ancor molto giovane; giunse all'apice di esso sui
trent'anni, dopo la pubblicazione, nel 1926, del suo primo — e
forse migliore — romanzo: The Sun Also Rises, Il sole
sorge ancora — titolo alternativo Fiesta — e tre decenni
prima che il Premio Nobel lo consacrasse ufficialmente, nel 1954.
Un successo di stima, assai lusinghiero, gli aveva arriso — da
parte di critici del calibro di Edmund Wilson e Lionel Trilling
— fin dalla comparsa dei Primi racconti, pubblicati quasi alla
macchia nel 1923-24 in edizioni di poche centinaia di esemplari.
Il successo ben presto straripò — negli anni Venti — oltre i confini
della patria, procurandogli in tutto il mondo estimatori e imitatori.
|
||
|
1/1 |
||