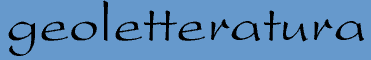Quel giorno Tommasino Landolfi non aveva dormito. Aveva fatto
le ore piccole e lì, verso le 4 del mattino, si accorgeva che
il bar sotto casa stava per alzare le saracinesche. Si alzò per
un sorso di caffè, come era abitudine. Tornando a casa, si vide
di fronte al diario da scrivere. Come riempire quelle angosciose
pagine? Sarebbe possibile riempirle di grandi e fulgidi segni
grafici? Gli pesava lo scrivere, ma allora perché scriveva… Scriveva
perché doveva, che diavolo! Non aveva altro espediente se non
continuare a riempire quelle pagine. Ciecamente, a testa bassa…
Tommasino Landolfi affondò nella sedia e prese la penna. Questa,
però, gli sfuggì dalle mani, scivolosa e scaltra. Mentre si abbassava
a riprenderla, Tommasino Landolfi pensò al diario. Cosa scrivere…
cosa scrivere… Era possibile scrivere? Il grande romanzo che aveva
progettato era soltanto un ricordo. In questo momento esisteva
soltanto un diario e la condanna all'uso della prima persona.
Vedeva soltanto un grande vuoto, un muro bianco di fronte a lui
che riverberava l'angoscioso foglio bianco da coprire con trame
di parole. Come farle stare nel terribile foglio bianco, in quello
spazio esiguo tra larghi margini?
La penna continuava a rimanere sul pavimento. Tommasino Landolfi
ebbe l'impressione che lo spiasse con aria di scherno. La mano
palpava il pavimento. Tommasino Landolfi guardò di sfuggita la
pila di carte accumulate sul tavolo. Meditava anche sulla trama
di un racconto. Che racconto? E intanto questo racconto doveva
essere scritto presto. Esigenze dell'editore. Scrivere cosa?,
si chiese Tommasino Landolfi. La mano tastava il pavimento alla
ricerca della penna beffarda. Non sapeva cosa scrivere. Gli restavano
soltanto le parole. La parola è l'anima del mondo. Tommasino Landolfi
aveva con le parole una relazione d'amore e terrore, che gli proveniva
dall'infanzia. Lo affascinavano le loro molteplici possibilità,
i loro significati polivalenti, il loro potere di allusione e
di reticenza. Usava dire che erano quasi la sua unica realtà.
A Tommasino Landolfi piaceva giocare con le parole ed estrarre
da esse il potenziale latente, che qualche volta affermava non
era stato totalmente sfruttato. Inventava parole. Riformava parole.
Questionava parole. Scriveva parole. Si ricordava di un racconto
in cui le parole apparivano a un povero scrittore e reclamavano
nuovi significati, in pieno mattutino rituale di pulizia dentale.
Dopo un tentativo di controllarle, esse erano scappate. Come adesso.
Come sempre. Tommasino Landolfi sapeva che non poteva ottenere
dalla parola ciò che essa non poteva dare. Conosceva la sua insufficienza.
I suoi occhi si fermarono a caso - il caso, una delle sue grandi
angosce - sul dorso di un libro nel vicino scaffale. Era Dostoevskij.
Tutti loro erano lì, su quella pagina da scrivere e in quell'angoscia.
Dostoevskij, Gogol, Tolstoj, Kafka, Poe, Leopardi, D'Annunzio.
La sua angoscia collettiva di scrittore. La penna ancora gli sfuggiva,
ma Tommasino Landolfi la inseguiva lungo i reconditi percorsi
del pavimento. Sentiva la testa pesare. E se avesse trovato un
ragno? E se improvvisamente un ragno con la testa di uomo fosse
spuntato sulla soglia della porta, così come in un racconto che
aveva scritto? Tommasino Landolfi ebbe un soprassalto. Come immaginava
fosse accaduto al padre di Kafka: una creatura con corpo di uomo
e testa di ragno, in una specie di metamorfosi reinterpretata,
alcuni potrebbero reinterpretarlo come una metamorfosi di qualcuna
delle sue creature. O di qualcuna delle sue ossessioni. Il porrovio,
per esempio. Il porrovio non è un animale, ma una parola. Nuovamente
la parola. Parola, cupa sentinella. Le sue perplessità già prendevano
il corpo e il colore delle parole. Udì un passero cantare fuori.
Che prodigio quelle note. Sempre nuove a ciascuna emissione. Al
contrario della parola, che invecchia appena pronunciata. La parola
significa e questa è la sua morte. Nulla significare, nulla dire,
forse questo sarebbe il supremo atto d'amore. Sarebbe possibile
liberare la parola?, si domandava Tommasino Landolfi. Sarebbe
possibile ripeterla tante volte, fin quando essa, svuotata di
ogni significato, fosse appena una forma pura?
Cosa scrivere… cosa scrivere… La penna ancora sul pavimento, schivava
la mano dello scrittore. Tra seccato e stanco, egli tastava ancora
alla ricerca della penna. Essa lo sfidava, senza curarsi dei suoi
bisogni e delle guance arrossate. La testa pesava… la mano si
stancava… Cosa scrivere… cosa scrivere… Non poteva non scrivere…
ma cosa scrivere… era ancora possibile scrivere? E se avesse scritto
sull'impossibilità di scrivere? Sembrava l'unica possibilità.
Pensò al romanzo che, riformulato in diario, non veniva fuori.
Si ricordò del complesso dell'Africa non scritta, quando redigeva
quel diario e quel complesso trasmutato si trasformò nella sua
stessa Africa. Osservando la superficie diseguale della penna,
vide come un labirinto. Prima aveva scritto qualcosa di simile?
Non ricordava. Ma il labirinto era una sensazione viva. Gli scrittori
devono molto ai labirinti, pensò. Si immaginò di scrivere un racconto
in cui si immaginava di scrivere un racconto. Un racconto sull'impossibilità
di scrivere un racconto. Un racconto che dialogasse con le sue
proprie perplessità senza espellere il mondo dalle sue frontiere.
Un racconto che raccontasse la sua propria storia. O la sua propria
crisi. Che raccontasse la storia di molti racconti. Tommasino
Landolfi era in piedi, penna in mano e cominciava a scrivere un
racconto in cui lo scrittore scriveva sulle difficoltà di acchiappare
una penna che era caduta per incuria sul pavimento. Più tardi,
il casinò lo aspettava.
Traduzione dal portoghese di Antonino Infranca