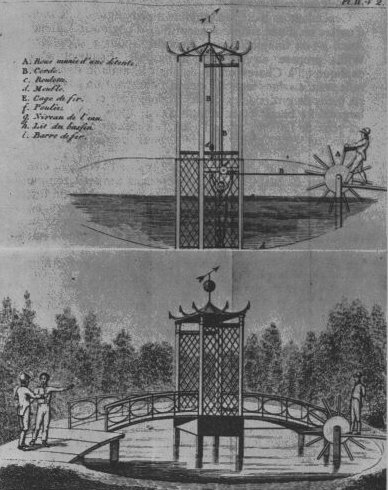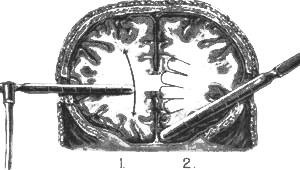|
<<Il
tassì si fermò. Mi fecero scendere ed entrare di corsa in una
larga portineria dalle pareti gialle, macchiate di umidità, dove mi
fermarono e diedero in fretta le mie generalità. Subito dopo due
enormi uomini mi afferrarono per le braccia e mi portarono di peso,
attraverso un tristissimo cortile, fino ad un cancello che fu
dischiuso avaramente e serrato dietro di me.
Una
coppia di grasse infermiere mi prese in mezzo e mi ingiunse di
spogliarmi. Ero all'Ospedale Civile, reparto Astanteria dei pazzi,
centro di raccolta e di osservazione dei candidati al manicomio.
Portavo
una sciarpetta fermata con una spilla; mi cominciarono a tremare le
mani e, nell'affrettarmi, non riuscivo ad aprire la piccola molla.
Dovevo spogliarmi in presenza loro e delle ricoverate, non ebbi modo
di indugiare: mi strapparono gli abiti di dosso, non badando a che
cosa si lacerasse: capo per capo, tutto mi fu tolto e buttato su di
un tavolo.

Una
terza infermiera elencava ogni cosa su di un gran registro; ogni
cosa, compreso le scarpe, le calze e quanto avevo nella borsetta,
osservando ogni oggetto con commenti peregrini. Ero nuda. Continuavo
a tremare, non di orgasmo soltanto, ma anche di vergogna.
Scrutandomi
la pelle e indagando tra i capelli, un'infermiera osservò con
evidente compiacimento che ero pulita. Mi diedero delle pianelle che
puzzavano di creolina e mi spinsero nel bagno dove mi aspettava una
densissima nuvola di vapore che offuscava l'ambiente e la vasca
d'acqua caldissima, sul bordo della quale era un pezzo di sapone
nero.
La
nettezza della mia pelle e il fatto di non avere insetti non mi
risparmiarono da una densa saponata sul capo dal cui impeto tentai
invano di difendermi strizzando forte gli occhi. Ripetuti rovescioni
d'acqua mozzafiato: evidentemente avevano, più che un fine
igienico, la funzione di calmante preventivo pel caso di una mia
eventuale ribellione.
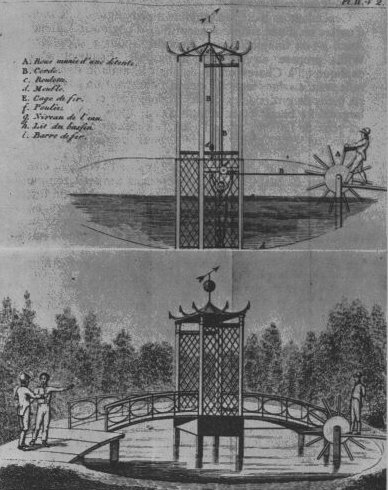
Io
ero, purtroppo, assai più che calma, al punto che ero finita lì
affetta dalla morbosa calma tipica della depressione nervosa.
Mi
rizzarono alfine in piedi e il bagno finì.
Un
ruvido pettine fitto tuffato in una densa soluzione disinfettante,
mi appiccicò i capelli sulla cuticagna. Mi fu infilato un ruvido
camicione spaccato di dietro, senza neppure il bottone dell'unico e
vedovo occhiello alla collottola. Ogni volta che dovevo scendere dal
letto, non potevo evitare l'esibizione involontaria del dorso.
Fui
stesa nel letto n° 7. Avevo le spalle gelate. In tutto quel tempo
le infermiere non avevano scambiato che qualche parola tra loro,
ignorandomi come persona e manipolandomi come un oggetto. Da parte
mia non ero stata capace di aprir bocca dall'istante del mio
ingresso.
*

La
corsia, stretta, con una trentina di letti di ferro addossati alle
pareti, aveva tre grandi tavoli rettangolari nel mezzo, sui quali si
svolgeva tutto quanto era attinente a quel genere
approssimativo di vita; non c'era altro, all'infuori delle <<comode>>
o seggette a foggia di poltrona, in ferro smaltato di bianco, poste
tra un letto e l'altro, e qualche sedia; non un armadio, non un
tavolino da notte, non uno specchio; non un quadretto né un vaso di
fiori, nulla; soltanto, dalla parete di fondo, pendeva l'agonia di
un bruno Cristo in Croce. Ai ferri dei letti, celate dalle coperte:
le <<manette>> e le <<gambette>> per legare
i polsi e le caviglie delle donne furiose o delle povere illuse di
poter compiere una qualsiasi reazione.
Tenute
a dovere per le braccia del nerboruto personale, inizialmente quasi
tutte le internate si dibattono mugghiando, urlando, come animali
che recalcitrino all'ingresso del mattatoio; finiscono poi, con la
bava alla bocca, assicurate a far corpo unico con il letto,
ansimanti, gli occhi strabuzzati o chiusi.

L'infermiera
che mi aveva rastrellato i capelli, grata forse che io non ero di
quelle <<che fanno tribolare>>, mi portò un bicchiere
di latte freddo. Il recipiente di alluminio puzzava di rancido; ma
bevvi con gratitudine; la gola mi si disserrò, ma le mani non
smisero di tremare e fecero così traboccare parecchio latte sul
camicione. Imparai ben presto che il <<latte bianco>>
era prezioso perché di solito veniva distribuito un insipido e
lungo caffellatte. Qualcuno cominciava ad avere pietà di me, della
mia faccia pallida di ragazza smarrita in mezzo a visi precocemente
senili, tormentati dal male, erosi, cincischiati ed inieme nodosi
come torcioni strizzati. Più
tardi, mentre ad occhi chiusi tentavo di <<non vedere>>
quanto sentivo di intravvedere, una vecchia ubriaca fradicia fu
proiettata più che sospinta verso il letto accanto al mio. I suoi
capelli grigi erano un impenetrabile casco di lana infeltrita. Fu
impossibile penetrarlo col pettine, impossibile epurarlo del
brulichio immondo che evadeva sui cenci, dei quali tre infermiere
fecero un cumulo di brandelli in terra. Il logoro corpo
completamente nudo, rossastro, flaccido, deturpato dalla ramaglia
delle vene varicose, si contorceva nei conati del vomito; e il
vomito eruppe sul piancito e sul tavolo, sopra uno dei tavoli dove
si faceva tutto: dal posarvi pettini e bacinelle di disinfettanti al
pane e ai piatti. Tuttavia la vecchia, sia pur conciata com'era,
trovò il modo di ingiuriare le infermiere che le rispondevano a
tono e ridevano a crepapelle: era per esse un diversivo allegro che
rompeva la cupa monotonia dell'ambiente. Il fetore di quel corpo
striato di vomiticcio di vino, schiumante, inacidito, mi arrivava a
zaffate corrosive. Trascinata dalle infermiere, l'ubbriaca
saltabeccava riluttante verso il bagno: nel dimenarsi a destra e a
sinistra i seni cascanti e gialli e le natiche flosce ondeggiavano
come ghirbe sciacque a dorso di ciuco. 
Dopo
poco la trassero fuori dal bagno, rapata, lustra, congestionata; la
legarono sul letto con <<manette>> e <<gambette>>
e le praticarono una buona iniezione di sonnifero. Dopo dieci
minuti, sia pure col respiro affannoso degli addormentati per forza,
russava della grossa. Le
ore passarono così fra alternative di grida e di silenzi, finché
vidi scurire pian piano la cieca parete giallognola di fronte al mio
letto e il lucore della finestra alle mie spalle si spense nella
sera. E con la sera arrivò il medico. * L'aver
trascorsi molti anni nella cura di ogni sorta di pazzi non aveva
giovato all'espressione del volto ampio, piatto, con orecchie a
ciabatta, bocca larga, irta di residuati dentoni gialli. La divisa
degli ospiti dell'astanteria gli si sarebbe adattata a pennello. Mi
accorsi in seguito che aveva il cuore grande come una casa, sia pure
affogato nella nevrastenia. Non gli era sopravanzato fra migliaia di
individui squilibrati, un pizzico di pazienza; ed era rude e gridava
per dissimulare talvolta la pena che gli facevamo quando non ci
poteva evitare di spedirci al manicomio. Mi
squadrò: il medico che mi aveva dichiarata idonea alla Astanteria
(definendomi <<pericolosa a sé e agli altri>>) aveva
scritto sui miei <<benserviti>> che ero <<allucinata>>,
che <<sentivo le voci>>, in ciò confortato dalla
diagnosi di un collega che mi dichiarava <<deficiente dalla
nascita>>. Non
potevo, dunque, illudermi. Il
Dottore, comunque, mi chiese nome e cognome, quanti anni avessi, in
che giorno, anno e mese fossi nata e vivessimo, il che valse a far
segnare sulla mia <<posizione>> che ero <<lucida,
orientata nel tempo e nello spazio>>. <<Tu
senti delle voci, vero?>>. <<No,
Dottore, non sento nessuna voce>>. <<Allora,
com'è che sei andata all'estero e poi non sapevi come
ritornare?>> <<Le
assicuro che non sono mai uscita dall'Italia>>. <<Ora,
dici così. Ma tu senti <<le voci>> che ti danno
comandi, e tu vai dove ti dicono di andare...>>. <<No,
Dottore, non ho mai sentito voci; non sono mai andata in nessun
posto che non ricordi esattamente...>> Parlavo,
sì, cercavo di dire <<quanto era vero>>. Ma,
naturalmente, il medico dava più credito a ciò che, per sciagura
mia, stava scritto sulle carte che aveva dinanzi. <<Allora,
che cos'hai?>>. Mi
era impossibile definire alcun che: <<Sto
male, Dottore, qui, nella testa...>>. Lo
sforzo, il turbamento, la consapevolezza dell'impotenza, avevano
ormai distrutto in me la facoltà di spiegarmi oltre. Non avevo più
che un enorme gomitolo di ferro spinato compresso nell'angustia del
cranio, lì lì per scoppiare. 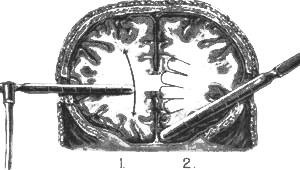
Sapevo
che il tacere equivaleva ad una condanna; ma parlare mi era
impossibile. Per salvarmi avrei dovuto, al contrario, raccontare la
mia battaglia di ogni giorno contro la forma depressiva che man mano
mi aveva portato a ricercare una forma di suicidio, avrei dovuto
narrare il lungo vagare per trovare il coraggio d'uccidermi. Il
gomitolo di ferro spinato urgeva dall'interno della fronte, mi
dilaniava con gli aculei le meningi, mi inibiva la formulazione di
una sola parola; le idee si accavallavano e mancava in me la forza
per esprimerle. Dopo mesi di inutili sforzi, era arrivata la
depressione che mi aveva impossibilitata a lavorare e, priva di
danaro, priva di assistenza, non potendo più affrontare la vita,
solo rifugio mi parve la morte. Alcuni
giorni prima di essere interrogata dal Dottore dell'Astanteria,
avevo preso il trenino per E., per le montagne che conosco, sulle
quali mi figuravo che avrei facilmente trovato il modo di lasciarmi
morire. 
Era
un vago pensiero il mio, e andai vagando per ore ed ore, verso
l'alto, nella solitudine; mentre l'istinto di conservazione lottava
per risospingermi verso la cittadina di E.. Esso ebbe, infine, il
sopravvento. Mi sentivo malissimo. Ero stremata dalla lotta
interiore e dal digiuno. Quando, tornata giù, le gambe mi portarono
in una farmacia per chiedere, mi pare, un calmante, non fui in grado
di domandarlo; mi lasciai andare su uno sgabello, appoggiai la
fronte sul refrigerio del balcone, senza proferire parola. Era un
atteggiamento preoccupante e, per giunta, m'ero imbattuta in una
farmacista esageratamente apprensiva la quale cominciò subito a
chiamare gente, come se la bottega andasse a fuoco. Qualunque
cosa si fosse fatto pro o contro di me, non avrei potuto muovere un
dito; ma la farmacista tanto urlò che due carabinieri arrivarono in
pochi minuti, mi condussero via e, issatami su di una carrozzella,
mi accompagnarono a C., in una stamberga sotterranea, dov'erano un
pancaccio, un bugliolo. Più tardi mi portarono una pagnotta. Avevano
ragione: io ero muta, ed essi avevano fatto bene a mettere una muta
sotto custodia. Chi diceva loro che io non ero una delinquente
simulatrice, che fingevo uno smarrimento mentale per nascondere le
generalità? Finchè non avessero saputo qualcosa di me, non avevano
altro luogo, si vede, dove meglio rinchiudermi, per mia e loro
tranquillità. Rimasi
lì dentro tutta la notte, sola, ranicchiata sul pancaccio, mentre
mi sfioravano e mi urtavano le scorribande degli enormi ratti delle
cantine, dagli occhi feroci. Ogni donna avrebbe urlato per lo
spavento, il ribrezzo, il raccapriccio; io non venni neppure meno:
ero annientata già, non mi importava dove fossi e ciò che
avrebbero fatto di me; mi bastava di non essere lasciata sola sui
ciottoli, sola alle prese con la vita che persisteva. Pensavo così
perché non sapevo né potevo immaginare ciò che mi sarebbe
sopravvenuto. Fui tenuta rinchiusa lì dentro (non rammento bene)
per due giorni, ma sono certa che mi passarono una ciotola di
minestra, che mangiai. Devo anche aver dormito qualche ora. Di
lì fui condotta nella locale sede della <<Protezione della
giovane>>; un paradiso in confronto della guardina. Le suore
mi posero in una stanzetta dov'era un duro divanetto rococò
rivestito diligentemente di stoffa a fiorami. Dalla finestra si
vedeva un vasto cortile quadrato sorriso di piccole dalie rosse.
Venne la Superiora e mi interrogò con molta pazienza. io la
guardavo, capivo e tacevo. Dopo
reiterati tentativi perchè io parlassi, la scoraggiata suora se ne
andò molto turbata. E me lo spiego: debbo dire anche che l'unica
cosa cui riuscissi a pensare era che quel mio silenzio mi potesse
aiutare a prolungare il mio soggiorno lì dentro. Vana speranza! Mi
ero quasi appisolata sul divanetto rococò; ma mi dovetti subito
sollevare. Le suore introducevano una fila di ragazze loro ospiti
perchè potessero rendersi conto della loro fortuna e ne
ringraziassero Dio. Le fanciulle mi guardarono con facce curiose;
qualcuna ostentava uno smorfioso spavento, altre ridevano e ve ne
erano di quelle che manifestavano unicamente la meraviglia di essere
al cospetto d'un <<fenomeno>> da baraccone. Terminò
anche quella funzione spettacolare e fui lasciata sola fino a quando
mi portarono una fitta minestra di riso in una grossa ciotola da
caffellatte. Mi commossi perchè vaporava come roba cotta sulla
legna e quest'odore rustico mi dava la nostalgia delle mie passate
gite in campagna. Più
tardi mi rifecero il letto con buone lenzuola pulite. Dopo il
pancaccio di legno insozzato dai ratti, non mi pareva vero di
allungarmi su quella freschezza candida. Oltre la sottile parete
sentii che qualcuno andava a letto per vegliare, forse, da vicino
sulle incognite della mia nottata. Io ero tranquillissima: altro non
potevo desiderare che star cheta immota in silenzio. 
Purtroppo
quel soggiorno pacifico quasi irreale, fra suorette caute, stoffe a
fiorami, annosa mobilia tarlata e un tantino ammuffita, ornata
di mazzetti di dalie e di ricorrenti Gesù dal cuore
fiammeggiante, fu troncato bruscamente il giorno dopo. Ebbero l'idea
di mettermi davanti un foglio di carta e di ordinarmi di scrivere il
mio nome, le mie generalità e la mia provenienza. Obbedii e stupii
che né io né altri ci avessimo pensato prima. Un gran fruscio di
gonne involò il fatale biglietto e in men che non si dica un agente
di pubblica sicurezza in borghese venne a prelevarmi. Dopo una breve
corsa a piedi, mi spinse in uno scompartimento ferroviario di terza
classe. Ero muta spaventata, smunta; ma avevo vent'anni, un corpo
svelto sulle gambe, vestito d'abiti leggeri. Il mio male non si
vedeva, non poteva offendere nessuno e neppure l'agente il quale,
appena fummo soli nella carrozza, tentò di allungare le mani. Non
so dove trovai la forza del mio disgusto, ma feci un tale salto e lo
guardai con tali occhi che nonostante il mutismo che avrebbe potuto
incoraggiarlo, si ritirò e non mi degnò più della sua attenzione
preferendo prendere aria dal finestrino fino al nostro arrivo a M.. 
Ero
di nuovo a M. e in quale compagnia! di nuovo a M. donde ero evasa
per evadere dalla vita. Lo sgherro mi accompagnò alla Questura
centrale, mi consegnò al commissario di servizio e sparì. Non
so quante ore stetti su di una panca in quel grande stanzone.
Accanto a me, gomito a gomito, dei <<fermati>> o degli
arrestati si susseguivano di quando in quando; poveracci
allampanati, mal vestiti, barbuti, maleodoranti, laceri, smunti di
fame e di paura. Io mi tiravo in là il più possibile cercando di
occupare il minor posto possibile. Dopo ricerche lunghissime,
riuscirono a scovare una persona che mi conosceva e le ordinarono di
venire alla mia presenza per l'identificazione. La persona mi
sbirciò, a malapena mi riconobbe e, infine dichiarò che, comunque,
non poteva dare asilo ad una pazza, né essere a ciò tenuta. <<Pazza?,
chiese il commissario, è qui da ore e ore e non ha dato nessun
segno di pazzia. Ha piuttosto bisogno di una buona
assistenza...>>. La
sua perorazione cadde nel vuoto; l'onesto funzionario concluse: <<Allora
non rimane che il manicomio. Firmi qui>>. Un
grande modulo passò dalle sue mani a quelle di chi mi respingeva.
Esso fu letto, studiato, compilato riletto e sottoscritto. Il
percorso dalla questura all'Astanteria dei pazzi, compresa la
brevissima sosta nell'ambulatorio di un medico di via Agnello
specializzato nel compilare dichiarazioni di <<pericolosità a
sé e agli altri>> (formalità di questura), non durò più di
un quarto d'ora. Era
questo che avrei dovuto raccontare al Dottor V.. Niente altro che
questo, per dimostrargli che ero in me e per smentire quanto si era
scritto sul mio conto. Poiché, invece, come ho detto, non riuscii a
rispondere, l'esame fu brevissimo. La diagnosi stesa dal medico
abitante vicino alla questura di <<ebefrenia catatonica>>
fu più tardi confermata nella sinistra <<demenza precoce>>. Il
Dottor V. chiuse la mia <<posizione>> dalla
copertina rosa, mi piantò lì, continuò il giro della corsia e
uscì dalla porta dond'era entrato. |