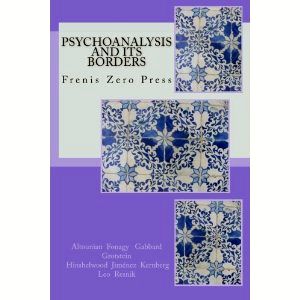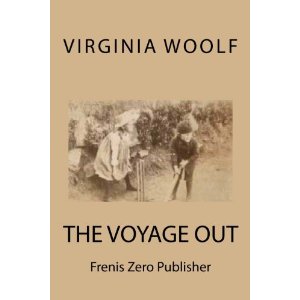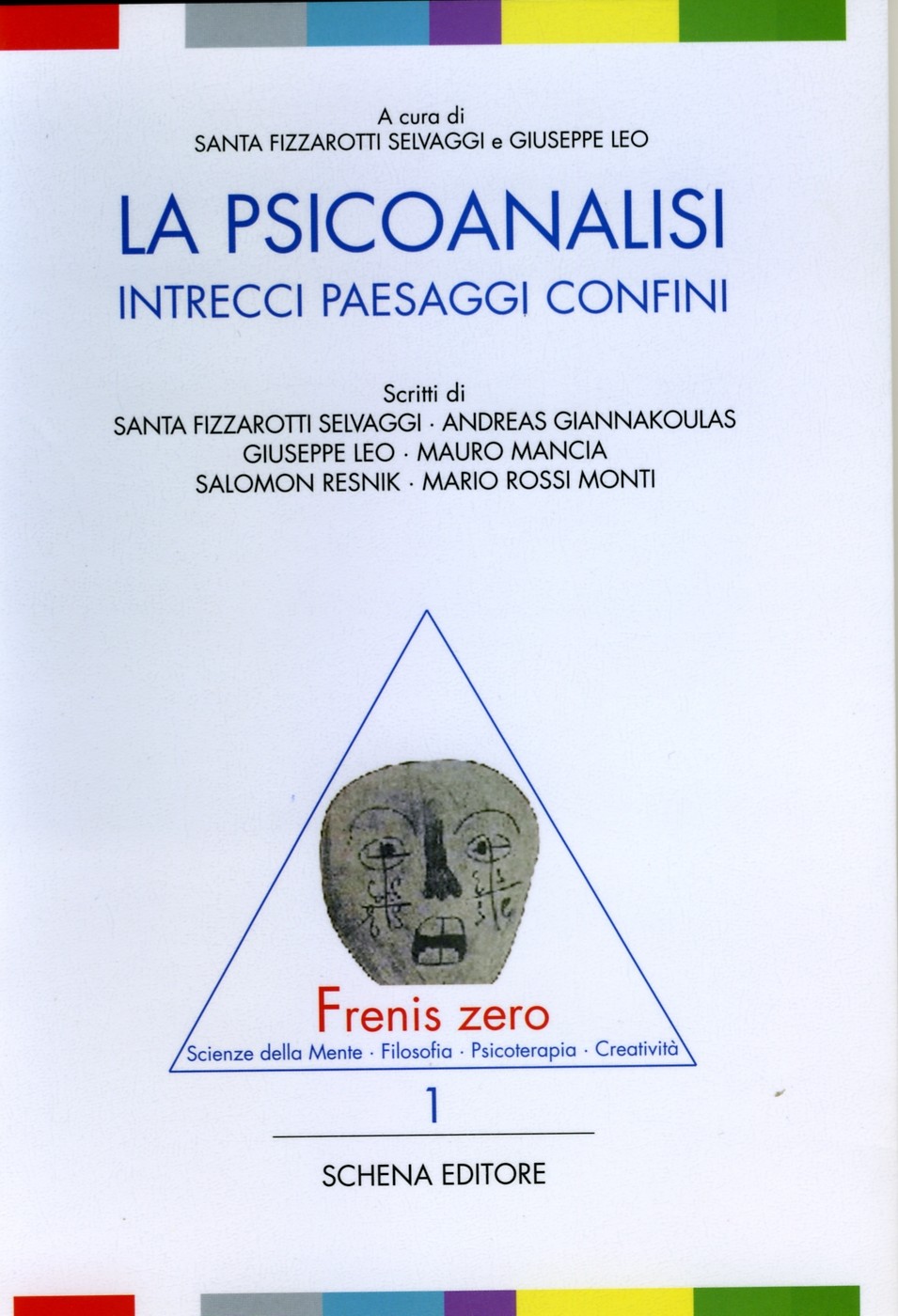|
A.S.S.E.Psi.
web site (History of Psychiatry and Psychoanalytic Psychotherapy )
A.S.S.E.Psi.NEWS
(to subscribe our monthly newsletter)
Ce.Psi.Di. (Centro di Psicoterapia
Dinamica "Mauro Mancia")
Maitres
à dispenser (Our reviews about psychoanalytic congresses)
Biblio
Reviews (Recensioni)
Congressi
ECM (in italian)
Events
(art exhibitions)
Tatiana Rosenthal
and ... other 'psycho-suiciders'
Thalassa.
Portolano of Psychoanalysis
PsychoWitz - Psychoanalysis and Humor (...per ridere un po'!)
Giuseppe Leo's
Art
Gallery
Spazio
Rosenthal (femininity and psychoanalysis)
Psicoanalisi
Europea Video
Channel
A.S.S.E.Psi. Video
Channel
Ultima uscita/New issue:
AA.VV.,
"Scrittura e memoria", a cura di R. Bolletti (Editor)

Writings by: J.
Altounian, S. Amati Sas, A. Arslan, R. Bolletti, P. De
Silvestris, M. Morello, A. Sabatini Scalmati.
Editore/Publisher: Edizioni Frenis Zero
Collana: Cordoglio e pregiudizio
Anno/Year: 2012
Pagine/Pages: 136
ISBN: 978-88-903710-7-3
Prezzo/Price: € 23,00
Click
here to order the book
AA.VV., "Lo
spazio velato. Femminile e discorso
psicoanalitico"
a cura di G. Leo e L. Montani (Editors)

Writings by: A.
Cusin, J. Kristeva, A. Loncan, S. Marino, B.
Massimilla, L. Montani, A. Nunziante Cesaro, S.
Parrello, M. Sommantico, G. Stanziano, L.
Tarantini, A. Zurolo.
Editore/Publisher: Edizioni Frenis Zero
Collana: Confini della psicoanalisi
Anno/Year: 2012
Pagine/Pages: 382
ISBN: 978-88-903710-6-6
Prezzo/Price: € 39,00
Click
here to order the book
AA.VV., Psychoanalysis
and its Borders, a cura di
G. Leo (Editor)
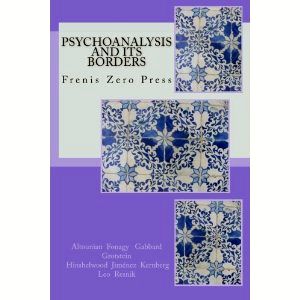
Writings by: J. Altounian, P.
Fonagy, G.O. Gabbard, J.S. Grotstein, R.D. Hinshelwood, J.P.
Jimenez, O.F. Kernberg, S. Resnik.
Editore/Publisher: Edizioni Frenis Zero
Collana/Collection: Borders of Psychoanalysis
Anno/Year: 2012
Pagine/Pages: 348
ISBN: 978-88-974790-2-4
Prezzo/Price: € 19,00
Click
here to order the book
AA.VV.,
"Psicoanalisi e luoghi della negazione", a cura di A.
Cusin e G. Leo

Writings by:J.
Altounian, S. Amati Sas, M. e M. Avakian, W. A.
Cusin, N. Janigro, G. Leo, B. E. Litowitz, S. Resnik, A.
Sabatini Scalmati, G. Schneider, M. Šebek,
F. Sironi, L. Tarantini.
Editore/Publisher: Edizioni Frenis Zero
Collana/Collection: Id-entità mediterranee
Anno/Year: 2011
Pagine/Pages: 400
ISBN: 978-88-903710-4-2
Prezzo/Price: € 38,00
Click
here to order the book
"The Voyage Out" by Virginia
Woolf
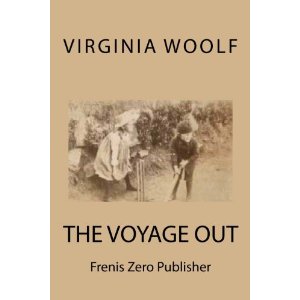
Editore/Publisher: Edizioni Frenis Zero
ISBN: 978-88-97479-01-7
Anno/Year: 2011
Pages: 672
Prezzo/Price: € 25,00
Click
here to order the book
"Psicologia
dell'antisemitismo" di Imre Hermann

Author:Imre Hermann
Editore/Publisher: Edizioni Frenis Zero
ISBN: 978-88-903710-3-5
Anno/Year: 2011
Pages: 158
Prezzo/Price: € 18,00
Click
here to order the book
"Id-entità mediterranee.
Psicoanalisi e luoghi della memoria" a cura di Giuseppe Leo
(editor)

Writings by: J.
Altounian, S. Amati Sas, M. Avakian, W. Bohleber, M. Breccia, A.
Coen, A. Cusin, G. Dana, J. Deutsch, S. Fizzarotti Selvaggi, Y.
Gampel, H. Halberstadt-Freud, N. Janigro, R. Kaës, G. Leo, M.
Maisetti, F. Mazzei, M. Ritter, C. Trono, S. Varvin e H.-J. Wirth
Editore/Publisher: Edizioni Frenis Zero
ISBN: 978-88-903710-2-8
Anno/Year: 2010
Pages: 520
Prezzo/Price: € 41,00
Click
here to have a preview
Click
here to order the book
"Vite soffiate. I vinti della
psicoanalisi" di Giuseppe Leo

Editore/Publisher: Edizioni Frenis Zero
Edizione: 2a
ISBN: 978-88-903710-5-9
Anno/Year: 2011
Prezzo/Price: € 34,00
Click
here to order the book
"La Psicoanalisi e i suoi
confini" edited by Giuseppe Leo

Writings by: J.
Altounian, P. Fonagy, G.O. Gabbard, J.S. Grotstein, R.D.
Hinshelwood, J.P. Jiménez, O.F. Kernberg, S. Resnik
Editore/Publisher: Astrolabio Ubaldini
ISBN: 978-88-340155-7-5
Anno/Year: 2009
Pages: 224
Prezzo/Price: € 20,00
"La Psicoanalisi. Intrecci Paesaggi
Confini"
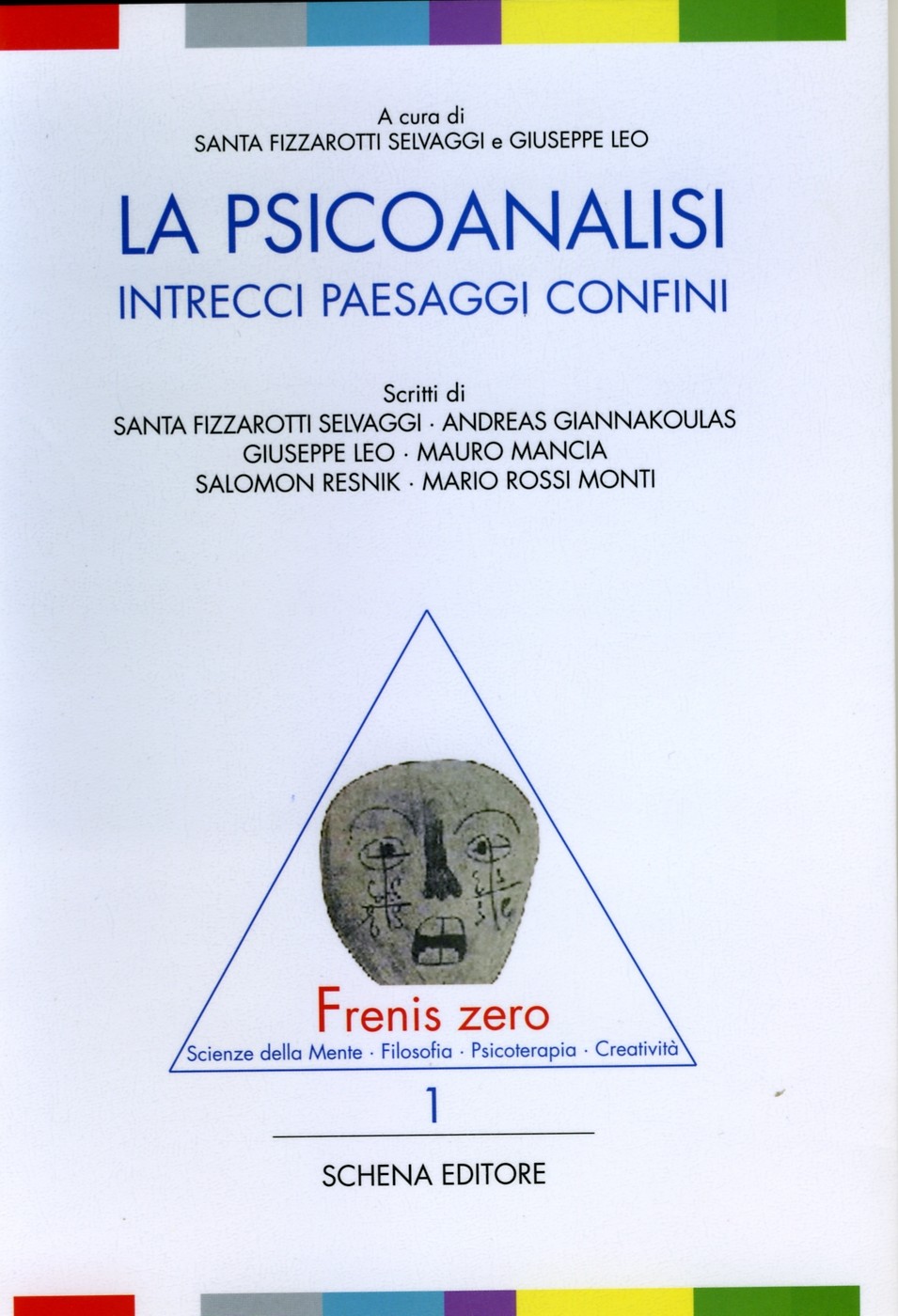
Edited by S. Fizzarotti Selvaggi, G.Leo.
Writings by: Salomon Resnik, Mauro Mancia, Andreas Giannakoulas,
Mario Rossi Monti, Santa Fizzarotti Selvaggi, Giuseppe Leo.
Publisher: Schena Editore
ISBN 88-8229-567-2
Price: € 15,00
Click here to order the
book |
Psicoanalisi
e luoghi della negazione
è un imponente volume di circa quattrocento pagine curato da Ambra
Cusin e Giuseppe Leo. Esso è in gran parte l’esito del Convegno “Id-entità mediterranee. Psicoanalisi e luoghi della negazione”
(Lecce, 30 ottobre 2010), organizzato dalla Rivista Psicoanalitica
Frenis Zero.
Non
solo di Atti si tratta, però, in quanto il volume è arricchito da
contributi di altri, che hanno aderito, con i loro scritti, al
progetto editoriale e alla collana intitolata “Id-entità
mediterranee”, in base ai quali la Psicoanalisi e la Storia del
Mediterraneo dovrebbero costituirsi come i due poli di una riflessione
‘al confine’ - come si legge nella quarta di copertina – tra
psicologia e sociologia, tra psicoterapia degli individui e dei gruppi
e clinica delle psicopatologie sociali.
“Sono
le dieci di sera di una domenica. Squilla il telefono a casa di
un’analista. A chiamare è una vecchia paziente, che ha concluso da
più di dieci anni la sua lunga analisi” (7). Questo l’incipit,
nella Prefazione di Ambra
Cusin, che precipita il lettore nel vivo del tumulto emotivo connesso
a vicende traumatiche che, per come le si esplora nelle pagine del
volume, hanno come inevitabile correlato i luoghi
della negazione. In questi luoghi non si può piangere, come
vediamo accadere a Dora, Milena e alla loro madre nel romanzo di Lia
Levi La notte dell’oblio:
“«Ha avuto il coraggio di negare?» […] «No», aveva risposto
Dora, Italo non aveva negato. Si era negato. Lui non era in grado di
dire parole perché non esisteva come essere umano, era solo un
confuso impasto di materiali di scarto” (2012, 187).
Dora,
Milena ed Elsa, la madre, non avevano potuto piangere la morte del
padre perché non avevano potuto parlarne, dal momento che farlo
obbliga a restare connessi all’inaudito, all’impensabile,
all’insopportabile.
Anche
“La generazione di armeni che è scampata al genocidio […] si è
negata il diritto di piangere, di urlare. Era un lutto troppo grande
da elaborare per cui era meglio rimuovere […] rinnegando la lingua,
rischiando quella che la glottodidattica chiama ‘morte
linguistica’, mutilando i propri cognomi togliendoci il
‘marchio’…ian (Aznavour,
Arslan), svanendo nel limbo della non-identità” (Avakian M. e M.,
242).
Ecco
perché la ‘vecchia paziente’ chiama la sua analista: ha scoperto
cose che aveva taciuto a sua stessa insaputa perché, dice, non le
poteva pensare e sente, per tale ragione, di aver fatto
“un’analisi finta” (8); riparlarne, farà comprendere a entrambe
che emergeranno nella seconda tranche d’analisi “non ricordi, ma
collegamenti tra singoli ricordi spezzettati” (ibidem).
Ad Ambra Cusin, curatrice, con Giuseppe Leo, del libro, chiedo di
spiegare perché i ‘collegamenti tra singoli ricordi
spezzettati’ non hanno valenza di ‘ricordi’ e quindi in che modo
potranno funzionare poi come strumenti di senso nei confronti delle
esperienze traumatiche vissute dalla paziente.
Cusin: <<Che bella osservazione e che bella richiesta!
Grazie… mi stai aiutando a pensare. Io scrivo molto d’impulso, le
cose mi vengono da dentro, spiegarle è successivo. La paziente
telefona all’analista anni dopo aver finito l’analisi (una
lunghissima analisi), dove mai aveva trattato il tema delle origini
ebraiche della sua famiglia. E’ vero che più volte in analisi aveva
accennato a tanti fatti, ma mai era riuscita a pensare ai
collegamenti tra questi fatti. Per esempio, il fatto che i genitori
erano andati, nel
1942, in
Alto Adige, dando per scontato che fosse stato per lavoro.
Contemporaneamente, sapeva che negli stessi anni una significativa
parte della sua famiglia (i due nonni, degli zii, alcune cugine, degli
amici di famiglia) erano scappati per nascondersi e che la bisnonna e
uno zio di sua madre erano stati deportati e mai più erano tornati.
Queste due informazioni mai si erano collegate tra loro per farle
venire il dubbio sul fatto che forse, se i genitori erano in uno
sperduto paesino di montagna, questo era avvenuto per evitare le
persecuzioni che a Trieste erano state devastanti: la comunità
ebraica vi è stata quasi distrutta…
In
quegli stessi anni la madre (e lo sapeva benissimo) era stata
costretta a battezzarsi, così come i suoi nonni materni, che, in più,
hanno fatto nel 1939 un matrimonio cattolico per “mettersi a
posto”. Aveva, mi disse, sempre conosciuto questi fatti. Mai però
si era potuta chiedere quali emozioni li impregnavano, per così dire:
farsi queste domande era impensabile, nonostante una lunghissima
analisi!
Ebbene,
più di dieci anni fa un conoscente (intellettuale triestino
molto conosciuto) le comunica che sta facendo una ricerca sui figli
dei perseguitati dal nazismo, quelli che erano bambini piccolissimi
all’epoca, per dotarli di una pensione che riconosca il danno da
loro subìto, da un lato, ma, anche, per capire cosa fosse rimasto
nella loro memoria delle violenze subite dalla famiglia. Ne discute a
lungo con lui, entrambi colpiti dal fatto che tutte queste persone
sminuiscono… non hanno particolari ricordi…, ma per dieci
anni mai, e dico mai con particolare angoscia, pensa che sua sorella
è una di quei bambini….
Solo
circa 4 anni fa comincia a pensarlo e ci vuole un anno prima che si
ricordi di parlarne con il conoscente. Ogni volta che lo incontra
questa richiesta “le sfugge di mente”.....
È
una rimozione? Una vera e propria negazione?
Comprenderemo
che è come se il ricordo di questa domanda da fare, improvvisamente,
venisse chiuso a chiave in un sottoscala, al buio e non potesse
neanche gridare per farsi sentire. E’ un pensiero che “veniva
sparito” (è l’errore grammaticale/sintattico con il quale me ne
parla): desaparecido....
Per
questo ho trovato utile la parola “nascondimento” utilizzata da
Semi.... Per dire come si possa scoprire d’aver vissuto nel
nascondimento...” un ”nascondimento” che ha coinvolto anche
l’analista, un nascondimento
estremamente potente, che rende incapaci di pensare, che interrompe i
fili logici del pensiero... e quelli emotivi. Che li scollega. E’
una sorta di obnubilamento, di stupidità. Ancora oggi la paziente non
riesce a capacitarsene: “COME NON HO POTUTO VEDERE???”.
Ci
si sente veramente stupidi, eppure si rende dolorosamente conto che è
proprio così che accade. Ne ho parlato anche con Jorge Corrente,
esperto di queste cose, e lui mi ha detto che era un bene che la
paziente non lo avesse potuto pensare, perché in tal modo in analisi
ha potuto sviluppare quelle strutture indispensabili, anni dopo, a
sostenere l’angoscia di questa presa di coscienza. Prima sarebbe
stato troppo presto. Come dire che l’analisi può dare i suoi frutti
anche dopo molti anni dalla sua conclusione.
Dei
rifugi della mente parla John Steiner (1996); li chiama
rifugi - ci dice
Mirella Curi Novelli
che lo cita ampiamente in un suo lavoro presentato al Centro Ricerche
Psicoanalisi di gruppo a Milano nel marzo 2012 - “perché forniscono
al paziente un luogo dove, attraverso la fantasia,
può stare relativamente tranquillo, protetto dalle tensioni e
per questo possono bloccare l’analisi evitando il contatto con
l’analista
che viene mantenuto
estraneo a queste aree” (sottolineatura mia).
Nel
caso seguito da Mirella lei afferma che non sono una problematica in sé,
visto che attingono alla fantasia, ma la problematicità si riferisce
alla produzione eccessiva e all’uso
difensivo che viene fatto di questi “rifugi” rispetto
a qualcosa sentito come più drammatico e difficile. Nel caso
della mia paziente non si tratta di qualcosa che attiene alla
fantasia, ma di qualcosa di reale, che però non è mai stato
veramente detto - i genitori non parlavano approfonditamente di questi
fatti, li raccontavano come si raccontano le storie ai bambini, per
questo penso che si fossero stabilizzati nella sua mente come
“fantasie”. Quello che relegava nel rifugio della mente, con il
“nascondimento”, erano i collegamenti tra questi
“racconti/fantasie”.
Così
dunque, circa quattro anni fa, comincia ad affrontare questa cosa; a
ricordare tanti piccoli fatti – di cui avevamo parlato mille volte
– che riemergono e cominciano a creare una fitta rete che dà forma
ad un ricordo significativo: la sua famiglia aveva vissuto con
paura la persecuzione nazista e aveva cercato di proteggere la propria
bambina, che porterà molti segni della memoria rimossa dai genitori
di questi fatti: l’ansia, la tendenza a somatizzare nel corpo cose
indicibili, il bisogno di prevedere ogni cosa nei minimi particolari,
la costante incertezza e il bisogno di tenere tutto sotto controllo.
Questi sono i segni caratteristici dei figli dei sopravissuti alla
persecuzione nazista. Nella paziente questi sintomi avevano bloccato
alcuni aspetti significativi della vita.
Capisci
perché quando affermo che ci sono “non ricordi, ma collegamenti tra
singoli ricordi spezzettati” intendo dire come sono i legami tra i
fatti ad essere attaccati, distrutti o resi impossibili. I ricordi
sono così come frammentati, slegati uno dall’altro, tenuti
separati, non scissi, perché lei sapeva che quelle storie avevano a
che fare con la guerra ed erano pezzi di una stessa storia, ma le
impedivano di farsi delle domande in merito, domande che scoprissero
il vero fil rouge che legava quei fatti tra loro.
Iniziò
a ricordare (ed è sconvolgente per lei) a capire, che quando la madre
la portava dalla vicina non era perché lei doveva lavorare, ma perché
aveva paura che qualcuno venisse e portasse via – deportasse – la figlioletta piccolissima mentre lei era al lavoro.
Cominciò a dare significato ad una frase che aveva sentito dire dalla
madre ma alla quale non aveva mai dato peso… (in sessant’anni!!!):
“Se qualcuno viene e le chiede di chi è questa bambina (aveva
allora un anno o poco più), dica che è una vostra parente…”.
Perché la madre aveva avuto il bisogno di chiedere questo alla vicina
di casa… tedesca e alto atesina??? Si tratta di un perché
che si può porre solo oggi. E’ questo quello che era stato nascosto
nel rifugio della mente, la paura della madre che la sua bambina
potesse essere presa dai nazisti. Una paura che non è mai stata
parlata, detta, ma era reale, dal momento che la bisnonna fu realmente
deportata. Solo in questi anni ha scoperto che è morta ad Auschwitz.
Che a più di ottant’anni ha vissuto ad Auschwitz per ben sette
giorni dopo un viaggio terribile e qualche giorno in Risiera (a
Trieste, unico campo di concentramento in Italia). Tutta la sua
famiglia aveva sempre sostenuto che era morta subito in Risiera perché
molto anziana. Invece su un libro che raccoglie tutte le informazioni
su i deportati italiani ha trovato il suo nome… Come ha vissuto quei
giorni? Quanta sofferenza ha dovuto attraversare? Solo ora la paziente
si può porre queste domande e solo ora può indossare un suo anello
che le aveva lasciato in eredità e che per anni non ha mai messo…
perché non riusciva ad indossarlo?
Dunque
per rispondere alla tua domanda, la frase “emergono non ricordi, ma
collegamenti tra singoli ricordi spezzettati” esplicita quello che
la paziente Miriam
porta all’analista nella telefonata, non è il ricordo di un fatto
specifico, ma il collegamento, il legame significativamente nuovo,
perché sdoganato da un rifugio della mente, tra due cose che erano
state già ricordate e portate in analisi, ma come fatti tra loro
separati, indipendenti, che mai avevano interpellato la paziente su un
possibile legame tra loro. Sono domande nuove che compaiono e che sono
significative. Domande che creano legami tra i ricordi.
Non è il ricordo di un fatto traumatico in sé, è il
collegamento che è traumatico e che deve essere “nascosto”. Il
collegamento per esempio tra l’essere affidata ad una vicina, la
paura della persecuzione nazista e la consapevolezza che alcuni
parenti molto vicini (i due padri della madre e del papà, cioè i
nonni della paziente) erano fuggiti per nascondersi (ed erano stati
via alcuni anni!)
Spero
di essere stata chiara in merito. Mi sono dilungata proprio per farti
comprendere, anche emotivamente, il significato importante, a mio
parere, della negazione sottostante. Una negazione così potente che
si manifesta con un “nascondimento” dei collegamenti tra i fatti
in una zona della mente dalla quale è impossibile farli uscire. Per
65 anni questa donna non ha potuto parlarne! Nonostante
l’analisi….>>.
Infatti,
nei luoghi della negazione
non si può parlare perché non si può ricordare,
o, meglio, non si possono sperimentare
emotivamente i collegamenti tra i ricordi: come ha mostrato Bion
(1959), sono i legami tra i significati ad essere attaccati quando non
se può reggere l’urto. Si tratta del “disinnesco” del
dispositivo di “legame” emozionale (cfr. Britton, 1989, 121).
Mi
è stato raccontato alcuni anni fa, da una collega, che a Savona, la
città in cui vive, ogni giorno, alle 18.00, al rintocco di alcune
campane, per un minuto l’intera città si ferma. Si tratta del suono
di campane speciali, fuse con il bronzo delle armi usate nel corso
della seconda guerra mondiale. Non monumenti ai caduti, ma qualcosa di
vivo – l’intera città che osserva un minuto di pausa e silenzio -
che interagisce quotidianamente con una realtà viva, in continuo
cambiamento, ma sa, ricorda. Un segno vivente alimenta una memoria
viva in funzione di più identità: quella dei caduti, da un lato,
quella dei viventi, dall’altro.
A
proposito della damnatio memoriae (Bodei,
2009), dell’impossibilità di dimenticare per non poter ricordare,
penso al lavoro di una giovane laureata in Psicologia, Paola Garbarini
(2008), che per la stesura della sua tesi è andata a Buenos Aires per
incontrare l’Associazione delle
Abuelas de Plaza de Mayo e quella dei figli dei desaparecidos, la Agrupación
H.I.J.O.S., con le quali ha lavorato per sei mesi intervistandoli.
Il dramma degli H.I.J.O.S.
è stato quello di non sapere la verità sul fatto che gli assassini
dei loro genitori, militari, membri del regime e poliziotti, li
avevano adottati trattandoli però come propri figli biologici.
Garbarini ha esaminato la letteratura raccolta da psicologi e
psicoanalisti in Argentina sui danni provocati dal fatto di non aver
potuto capire ‘macchie cieche’ della propria storia in tali
giovani, sui dilemmi identitari causati da tale damnatio
memoriae. Infatti, contro l’obbligo all’oblio la Agrupación H.I.J.O.S. fa delle gran feste intorno alle case dove
abitano gli omicidi coperti dall’anonimato, in modo che tutti
sappiano che lì abita qualcuno che ha nei confronti del paese delle
responsabilità pesanti: solo musica, balli, teatro di strada perché
nessuno sfugga alle proprie responsabilità. A me pare questo un
invito etico perché non basato su catene vendicative ma nemmeno su un
oblio mortifero, dal momento che non consente di cancellare la memoria
con un’operazione di diniego ma neppure di restare incollati a una
memoria che non può cambiare, come nelle tragiche catene vendicative
di stampo mafioso: “Restituire [i figli dei desaparecidos alle loro radici] non rappresenta solo un loro diritto
ma un dovere etico […]: il regime, attraverso l’appropriazione di minori, voleva ottenere la pulizia ideologica,
voleva che la desaparición
si perpetrasse più in là della desaparición
stessa dato che gli appropriatori
rubando questi bambini e iscrivendoli come propri, attuarono
un’altra forma di sterminio, un assassinio della memoria” (Garbarini,
2008, 83).
È
noto come “Negli stati totalitari […] non può esistere sfera
pubblica [e è imposta] la cancellazione delle memorie individuali”
(Turnaturi, 2005, 45).
Altounian,
a tale proposito, evoca il “dovere che ci viene dettato da Paul
Ricoeur: «dove passa la linea di demarcazione tra l’amnistia e
l’amnesia»“ (211).
Si
possono evocare a tale proposito gli studi di Bruna Bianchi (2005),
che si è occupata del lavoro obbligatorio della dimenticanza imposto
dai regimi dittatoriali. Esemplare il caso di Redipuglia. La storica
(2005) ricorda che, prima dell’avvento del fascismo, in Italia
“l’Inchiesta sui fatti di Caporetto (Relazione,
1919) aveva mosso accuse pesanti alle gerarchie militari sul modo di
conduzione della guerra. Nel 1925, anno di inizio della dittatura
fascista, […] il generale Badoglio pose fine a ogni discussione
sulla conduzione del conflitto. «Questo non è più tempo di storia,
ma di miti», rispose Mussolini ad Angelo Gatti, ex ufficiale del
comando supremo, quando gli manifestò l’intenzione di scrivere
un’opera su Caporetto. […] Possiamo individuare un analogo
processo di costruzione del mito nei monumenti e nei cimiteri di
guerra degli anni trenta. Il 24 maggio 1923 si era inaugurato a
Redipuglia, sul Carso, il ‘cimitero degli invitti della III
Armata’. [Sulle tombe di ciascun soldato] numerose epigrafi tratte
dalle grandi opere della letteratura italiana. [Le tombe] erano state
disposte in grandi cerchi, come i gironi dell’inferno. […]
Prevaleva l’aspetto privato del lutto. Nel 1936 il cimitero fu
smantellato, i corpi di 30.000 soldati riesumati per essere trasferiti
al sacrario di Redipuglia. Al posto delle epigrafi [con i nomi],
centinaia di iscrizioni si ripetevano, tutte uguali («presente!»),
su una bianca gradinata, simbolo dell’ascesa mistica al regno
dell’immortalità (Todero, 2002)” (Bianchi, 2005, 114-115). In
Italia, “A partire dagli anni ottanta, la storia ha incontrato la
memoria” (Bianchi, 115).
“Questa
riflessione sul futuro contenuto nel passato […] ha delle importanti
conseguenze epistemologiche, in quanto spezza il determinismo storico
per cui « gli eventi accaduti procedono sempre nella direzione che
comunque e inevitabilmente avrebbero dovuto prendere» (Bodei, 2004,
XIII) e fornisce un’interessante chiave di lettura per meglio
comprendere la costruzione delle memorie ufficiali” (Turnaturi,
2005, 48). Non a caso il già citato contributo di Manuela e Mary
Avakian a Psicoanalisi
e luoghi della negazione
titola Dalla rimozione al
negazionismo. Dove scrivono, riferendosi agli adulti nei quali ai
bambini armeni scampati al massacro era impossibile identificarsi:
“E tutti parlavano sottovoce, e bisbigliavano parole misteriose
[…] e invocavano il silenzio con sguardi severi scambiasti tra di
loro non appena entrava in stanza un piccolo” (242). Ma il regime
del silenzio ammutolisce la domanda, scrive Silvia Vegetti Finzi
(2005) nel rammentare la propria esperienza di bambina ebrea di sette
anni alla fine della guerra e delle sue atrocità delle quali
“nessuno mi aveva parlato: […] profughi in fuga, improvvise
sparizioni. Per noi bambini non c’erano né parole né ascolto […]
solo immagini sporadiche, frammenti di suoni, rumori… Difficili da
decifrare, impossibili da comprendere. […] Dalla cucina, il locale
in cui i miei si radunavano la sera per ascoltare «Radio Londra» i
più piccoli erano bruscamente spediti fuori […]”. Il ritornello
[…] era “Ragazzi, uscite, che noi dobbiamo parlare”. Né lei, né
il fratellino osavano domande su parenti scomparsi […] Traumi
“senza parole, incistati nel corpo, come elementi beta non
alfabetizzati. D’altra parte nessuno pensa e parla da solo: il
pensiero è sempre un dialogo e, se non ci sono interlocutori, si
ripiega su se stesso e si chiude nel vuoto e nel silenzio. […] Al
termine del suo scavo analitico Freud ha trovato, come sedimento
ultimo, irraggiungibile, irrecuperabile, l’angoscia, traccia estrema
del non detto, del non dicibile. […] In fondo l’angoscia - un
sentimento che non inganna – è la memoria del silenzio, la sua
verità. […] Come nel peccato originale, l’umanità soffre anche
di quel che non sa” (Vegetti Finzi, 2005).
Mi
chiedo se in tal senso “incontrare la memoria” – nel trattamento
psicoanalitico tanto quanto a livello sociale -
non permetta di situare il passato in una prospettiva di
profondità: “rifletterlo”.
È la domanda che rivolgo a Giuseppe Leo, che prego di
rispondere anche alla luce degli approfondimenti metapsicologici che
ha condotto per il capitolo da lui scritto nel volume che sono qui a
presentare.
Leo: <<Nel libro Psicoanalisi
e luoghi della negazione, e ancora più nel libro in preparazione Psicoanalisi
e luoghi della riabilitazione (a cura di G. Leo & G. Riefolo,
Edizioni Frenis Zero, Lecce, in press), memoria e negazione sono posti
come i due poli dialettici e antitetici di un nuovo paradigma della
psicoanalisi, che affianca gli altri due
tradizionali, quello basato sul conflitto e quello basato sulla
carenza (si veda Amadei G., Come
si ammala
la mente, Il Mulino, 2005). Psicoanalisi intersoggettiva ed
evidenze provenienti dall’Infant research e dalle neuroscienze
convergono nell’evidenziare l’importanza del riconoscimento come
processo alla base della memoria. Ma “riconoscere” in molte lingue
ha un duplice significato: è sia “ri-identificare” qualcosa o
qualcuno, sia “accordare/concedere un determinato status” a
qualcosa o qualcuno. L’attuale psicoanalisi intersoggettiva accorda
un posto centrale al riconoscimento, soprattutto nel secondo
significato. Per Sander nell’Infant
Observation l’individualità emerge dentro un sistema
evolutivo in cui esiste una complementarietà specifica e
sincronizzata tra gli stati interni del bambino e la capacità materna
di riconoscerli. Punti di non riconoscimento nel percorso evolutivo
del bambino in termini di mancanza di regolazione affettiva (Schore) o
di sintonizzazione affettiva (Stern) possono costituire altrettanti
punti di ancoraggio di dis-sintonie e dis-conoscimenti (corrispondenti
ai concetti di negazione e diniego della psicoanalisi classica) che,
se protratti nel tempo e reiterati in “loops” amplificantisi,
porterebbero a disfunzioni e disregolazioni in molteplici sistemi
motivazionali (Lichtenberg), in primis in quello
dell’intersoggettività, con possibili prodromi psicopatologici>>.
Come
ricorda Hannah Arendt, invece, “Il male […] non possiede profondità.
Questa è la sua ‘banalità’: si espande come un fungo.” (1986,
227, in Rossi-Doria, 2005, 91). Rimando, a tale proposito,
all’importante rivisitazione della ‘banalità del male’
effettuata da Roberta Guarnieri (2006) a partire dagli scritti di
Sebald.
Come
nota Ambra Cusin nella Prefazione,
è interessante notare che nel volume da lei curato con Giuseppe Leo,
“molti autori, che hanno contribuito a questo libro, citino
esperienze personali: Amati, Altounian, Avakian, Cusin, Janigro,
Resnik, Šebek, Tarantini. Quasi che questa tematica della negazione
abbia così bisogno di declinarsi nella verità” (12).
A
tale proposito, trovo esemplare il seguente episodio, dove è la
curda Leyla Zana a dare prova di una creatività capace di paradossare
gli eventi e i loro protagonisti per mezzo dell’ironia, come nel
caso poco sopra ricordato dell’Agrupación
H.I.J.O.S, che solo con musica,
balli e teatro di strada denunciano gli assassini dei loro genitori e
combattono l’oblio perché nessuno sfugga alle proprie responsabilità.
Leyla Zana, essendo
stata eletta in Parlamento e dovendo giurare fedeltà alla
Costituzione turca che nega i diritti kurdi (mentre nei poligoni di
tiro della polizia e delle unità speciali turche la sua foto è usata
come bersaglio in quanto ‘incarnazione del nemico da abbattere’),
in Aula dichiarerà solennemente: “Sono stata obbligata ad
adempiere la formalità richiesta. Io lotto per la fraterna convivenza
dei due popoli in un quadro democratico” (2001). Una
dichiarazione che lei sottoscrive paradossandola e rendendola materia:
intreccia tra i capelli tre nastri con i colori della bandiera kurda:
giallo, rosso, verde. L’immagine fu così materica che, pur essendo
stato il suo discorso liquidato come ‘incomprensibile’,
suscitò un dibattito politico sull’opportunità di cambiare i
colori dei semafori, per non ribadire ad ogni crocicchio l’identità
nazionale kurda da Leyla evocata con tanta sapiente e burlesca
maestria.
Psicoanalisi
e luoghi della negazione
è una ricca, coerente per quanto caleidoscopica, preziosa occasione
di incontro con molti fatti di una certa importanza.
●In
primo luogo, con vicende ‘ora
faro ora mare’ (Beckett), come ad esempio nel caso della parola
‘nascondimento’, nella Prefazione,
che, considerabile ‘un luogo
della negazione’ (11), che ‘rimanda
a qualcosa di segreto’ (13), può però funzionare anche, come
è stato per Cusin, come una ‘parola concava’, come un contenitore
che protegge (17), come è stato per il piccolo protagonista del
romanzo In fuga di Anne
Michaels (1998), Jacob Beer, che emerge dalla palude che l’ha
‘nascosto’ e quindi protetto, per settimane, dopo la strage della
sua famiglia ad opera dei nazisti. Jacob è costretto per un lungo
periodo a sopravvivere in balia di una solitudine assoluta, e si sa
che il fatto di non poter “mettere in parole” e condividere con
qualcuno il peso di ricordi traumatici fa sì che si resti come
“impregnati delle tracce dell’orrore” vissuto (Varvin, 1999,
804).
Come
mostrano tutti gli autori di Psicoanalisi
e luoghi della negazione, ciò
che rende un trauma più traumatico è il carattere di “violenta
interruzione del processo di sviluppo normale, attraverso la rottura
del legame con l’altro, inteso come presenza empatica e
significativa” (Varvin, 1999, 800). Come nota l’autore, ciò che
va in frantumi in guerra è “anche l’assunzione di base che il
mondo sia un luogo sicuro e ordinato” (Varvin, 1999, 801 ).
A Sverre Varvin chiedo se può dirci in che modo il
trattamento psicoanalitico contribuisce anche in funzione del
setting a rifare del mondo, nella percezione del soggetto
traumatizzato, un ‘luogo sicuro e ordinato’.
Varvin:
<<Si tratta di una domanda molto importante, alla quale è
difficile rispondere in breve. Approssimativamente, direi che i
soggetti traumatizzati, in particolare coloro che hanno subito traumi
estremi, come la tortura o altre forme severe di atrocità,
sperimentano nella vita una insicurezza di base (basic), una
esperienza di frammentazione, un senso del tempo disturbato e la paura
che in qualunque momento possa capitare qualcosa di terribile. La
Psicoanalisi è caratterizzata da un setting e da una cornice
all’interno dei quali gli incontri sono regolari e avvengono nello
stesso luogo: un luogo prevedibile, caratterizzato da continuità,
stabile. L’analista stesso è una persona
stabile,
emotivamente
disponibile
nei confronti del paziente, empatico, teso a capirne
e ad accettarne lo stato mentale.
Il paziente può far proprio, prendere in sé (take in) e
interiorizzare l’insieme di fattori descritti (che possiamo
intendere come il setting), e ciò gli fornisce gradualmente un
vissuto (feeling) di sicurezza di base, che per molti, dalla
traumatizzazione in poi, è quasi totalmente assente>>.
Traumi
terribili generano infatti modi anomali di organizzare l’esperienza,
modi che allontanano l’individuo dal mondo condiviso, mancando un
modello di “ragione ospitale” (Bodei, 2001) da interiorizzare e
umani significativi di cui fidarsi. Un bel lavoro di Jole Oberti
(1999) si intitola proprio “Please, believe me”, a indicare come risulti difficile, per le
vittime e i sopravvissuti, credere di poter essere creduti.
●
E qui è introdotto un altro dei temi importanti affrontati dal questa
raccolta di saggi. Di quanto conti in analisi l’importanza di essere
creduti e che l’analista si configuri come un reale ‘testimone’
dicono molti bei contributi, per ragioni di spazio ne cito uno a caso,
quello di Altounian, che sottolinea quanto per l’erede dei
sopravvissuti sia importante la presenza di “un altro suscettibile
di intendere la verità sulla sua storia. […] perché la storia dei
miei antenati sterminati trovi spazio nella storia del mondo, ho
bisogno di incontrare un’istanza politico-culturale esterna alla mia
storia la quale, trovando essa stessa un qualche interesse proprio da
intendere, le offra una camera di risonanza e si costituisca come
mediatore per ‘raccontarla/tradurla’ agli altri. Ora, questo
incontro diviene possibile in quanto l’esperienza politica presenta
di fatto un punto di giunzione con l’esperienza analitica di un tale
individuo che cerca di liberarsi dall’influenza che il diniego della
sua esistenza, della sua autonomia o della sua storia esercitano su di
lui” (218-219).
Si
tratta di un essere porta-parola
dell’analista al servizio di aspetti del paziente scissi e rimossi
che, dall’esilio cui erano stati confinati, possono tornare a essere
parte attiva in un più democratico parlamento interno. Con Chianese
(2010), anch’io penso che “Si costruisce su ‘tracce’ portate
dal paziente che possono riattualizzarsi in un determinato contesto
(associativo e/o relazionale)”. Ho scritto (2003) come spesso,
soprattutto con alcuni pazienti (traumatizzati, borderline, psicotici)
“non si possa parlare di ricordi,
tanto meno immediatamente
suscettibili di diventare coscienti, quanto, piuttosto, di tracce,
che necessitano di un lavoro di costruzione
(Freud S., 1937; Chianese D., 1997)
e di co-narrazione
(Ferro A., 1999; 2002) per arrivare a un significato
mentale condiviso”. Dicevo (ibidem) che, “Se si tien conto del
fatto che la costruzione della mente è in continua formazione nel
corso della vita, tali tracce diventano pensabili come Fiori
Cinesi (nota 1) grumi accartocciati di insensatezza orbitanti
intorno al Sé, testimonianza di esperienze originarie, primitive, che
non hanno trovato ancora accesso alla mentalizz-azione
e, quindi, al significato
condiviso, non potendo di conseguenza accordarsi
né con ciò che nel frattempo il soggetto è diventato né con le
persone del contesto in cui egli vive”.
Scrive
Bion: “quello che un musicista potrebbe descrivere come
un’incapacità di ‘sentire’ o di ‘accordarsi’
rispetto a quanto è stato detto, in modo tale che l’asserzione
enunciata non può essere ‘sentita’ a meno che non sia esattamente
e precisamente sintonizzata al ricettore […] un bersaglio mancato
soltanto di pochissimo è comunque mancato del tutto” (1996). Con
altre parole, il soggetto non può che “continuare a cercare
quell’evento del suo passato di cui non ha potuto ancora fare
esperienza. Questa ricerca assume la forma di una attesa dell’evento
nel futuro.” (Winnicott, 1974).
Il
problema allora è come recuperare
al senso tali frammenti, permettendo loro di trovare un posto
nella possibilità di autodefinizione del soggetto.
Altrimenti, restano grumi
insensati, perturbanti portatori di non senso, come nel caso dei
bambini adottati descritti da Janigro in Psicoanalisi
e luoghi della negazione. Brenman afferma: “E’ mia opinione
che la conoscenza delle proprie origini fornisca senso di continuità
e significato. Solo se ha un senso di appartenenza l’individuo può
raggiungere una propria identità. La ricostruzione ha valore in
quanto mezzo per riscoprire le radici, gli oggetti del passato e le
parti del sé perdute”. (1980, 35) (nota 2).
Come
ha mostrato spesso Silvia Amati Sas, è vero quanto afferma Chianese
(2010), e cioè che “I
nostri racconti hanno anche un valore di testimonianza, se non di
riscatto”.
Come
nota ancora Varvin (1999), “ciò che il sopravvissuto vive, in
misura più o meno intensa, è una estrema alienazione da se stesso,
dalla sua storia e dall’altro, in cui è compresa l’esperienza di
essere al di fuori della comunità umana normale” (802 segg). In tal
modo, come mostra Silvia Amati Sas, si crea nei soggetti uno stato di
indifferenza e di accettazione, in cui i valori e i principi della
morale condivisa sono messi fuori gioco.
●È
questo un altro dei temi molto importanti affrontati in Psicoanalisi
e luoghi della negazione, poiché si rivela in grado di
condizionare l’esito dei trattamenti psicoterapici, che possono
risultare inficiati quando effettuati in un contesto che nella realtà
dei fatti si dimostra ostile al soggetto ‘ospite’. Si pensi, ad
esempio, alla “legittimazione museale” riservata a Washington
all’Enola Gay, il Boeing B-29 che il 6 agosto del 1945 ha sganciato
l’atomica su Hiroshima. Legittimazione effettuata, nota nel suo
contributo (nota 3) Sabatini Scalmati, “Con arrogante negazione di
ogni forma di riparazione, con un abuso politico della memoria”
(259). È qui evocato uno stato mentale che non consente più di
discriminare, di conservare una “bussola” psichica, poiché
risulta difficile individuare una forma particolare di
‘neutralizzazione’ dell’alterità, che si esprime in un
apparente accordo e in un’accoglienza di superficie che, in realtà,
sono nella sostanza tesi a impedire un contatto - e un ‘contagio’
- autentici. A mio parere, si tratta di misure difensive in azione in
modo pervasivo (e poco identificabile perché ambiguo (nota 4) in un
momento storico particolarmente caratterizzato dall’incertezza.
Poiché pervasivi e poco identificabili, tali meccanismi difensivi
finiscono per ‘impregnare’ le mentalità, non consentendo a chi vi
ricorre di esserne consapevole, come se si agisse, in base allo Zeitgeist,
in “assenza di coscienza”.
Inoltre,
“Uno dei primi effetti che la società globalizzata produce
sull’individuo è la connotazione di estraneità. [...] la mobilità
del post-moderno genera repulsione e ribrezzo per tutto ciò che è
altro ed estraneo” (Menatti, Bonesio, 2004). Assistiamo di
conseguenza o alla presa di derive totalitarie o “alla planetaria
affermazione dell’homo
democraticus” (Cacciari, 1997, 123), entrambe - le
une esplicitamente, l’altra mediante l’apparente e
superficiale eliminazione delle differenze - cancellando nei fatti la
‘realtà’ dello straniero (nota 5). Si tratta di una sorta di
“metodologia immunitaria” (Esposito, 2002; Menatti, Bonesio,
2004), che diviene la chiave interpretativa del rapporto interattivo
tra noi e l’altro. “Il tentativo, vano, di creare un vaccino
contro la diversità […] Distrugge lo statuto ontologico del
soggetto. Roberto Esposito ha affermato che non è più possibile
procedere sulla via del monoteismo immunitario, ma che occorre pensare
tale forma nel suo rovescio comunitario, praticando il mondo come unità
di differenze. L’esempio più importante non viene dal corpus
delle dottrine politiche del passato, ma dal nostro stesso corpo,
umano e materno. Nel corpo della madre che nutre il feto, è il
sistema immunitario a diventare canale per l’accoglienza del
nascituro. [...] E, cosa
rara, quanto più il DNA del feto è estraneo a quello materno, tanto
più questo attecchisce nel corpo della madre. Importante metafora,
questa di Esposito (2002a) (nota 6)per evidenziare un possibile modo di essere politico fondato
sulla differenza degli elementi che lo formano. Questa prospettiva
dovrebbe, a nostro avviso, essere tenuta in considerazione quando la
politica elabora una praxis
comunitaria. Possibilità alternativa ai numerosi fenomeni difensivi
che la società elabora contro la domanda ontologica dell’alterità”
(Menatti, Bonesio, 2004).
Evoco
a tale proposito un’osservazione di Francesconi (2010), che notava
come si sia affermato l’uso del termine ‘migranti’; perso lo
statuto definitivo garantito dal tempo ‘fermo’ del participio
passato, ci si riferisce a chi arriva come al migrante, a proposito
dei quali Ambra Cusin (2012, 184) si interroga sulla loro difficoltà
a progettarsi a causa di un’angoscia sconosciuta.
Certo,
può essere, ma mi pare molto pertinente anche interrogarsi, con
Francesconi, decentrandosi dal soggetto e ponendo l’accento sul
contesto che non vuole/può garantire ospitalità stabile: come si può
far casa del paese ospitante
che ti giudica ‘di passaggio’, transeunte, ‘migrante’ appunto,
oltre che ‘extracomunitario’? Si tratta della “metodologia
immunitaria” di cui parlano Esposito (2002) e Menatti, Bonesio
(2004) contro gli S.D.F. (‘senza domicilio fisso’) di cui parla
Altounian (209)?
D’altronde,
“la negazione dell’umanità dell’altro che viene sterminato –
e i diversi mezzi utilizzati per raggiungere questo scopo, possono
mettere in luce alcuni dei meccanismi nascosti sottesi alla malignità
umana” (Heritier, 1996, 14-15)”; “per i gruppi primitivi,
l’umanità finisce alle frontiere della famiglia, della banda o
dell’etnia; il nome che danno a se stessi significa sempre
semplicemente «gli uomini»“ (Heritier, 1996, 18-19). Problema più
che mai attuale oggi, data quella che Ogilivie (1994) chiama la produzione
dell’uomo usa e getta, cioè la presenza di milioni di uomini
superflui, privi di utilità e di utilizzazione, nei cui confronti,
nota Balibar (1996), “si profilano prospettive di eliminazione e di
sterminio che non sono soltanto violente, ma particolarmente
crudeli” (58) al cui servizio, dice, è utile la funzione di cassa
di risonanza svolta dai mass media nel consentirne l’esibizione,
parte della crudeltà stessa: “…è alla fin fine strano che ci
si stupisca tanto dell’estrema crudeltà dell’epurazione etnica in
un universo culturale in cui, nonostante la pace e il suo comfort, una
crescente produzione di scritti e di immagini privilegia l’uso
sadico della sessualità nelle rappresentazioni estetiche” (Nahoum-Grappe,
1996, 190).
Ai curatori del volume chiedo un loro parere sul fatto che in
effetti si assiste a “una crescente produzione di scritti e di
immagini [che] privilegia l’uso sadico della sessualità nelle
rappresentazioni estetiche”.
Cusin: <<“Tu poni questa domanda portando una
citazione presa da Nahoum-Grappe (autore che non conosco).
Personalmente mi sono interpellata su questa affermazione che
tu fai seguire ad una citazione di
Varvin (1999), “ciò che il sopravvissuto vive, in misura più
o meno intensa, è una estrema alienazione da se stesso, dalla sua
storia e dall’altro, in cui è compresa l’esperienza di essere al
di fuori della comunità umana normale” (802 segg). In tal modo,
come mostra
Silvia Amati Sas
, “si crea nei soggetti uno stato di indifferenza e di accettazione,
in cui i valori e i principi della morale condivisa sono messi fuori
gioco”.Come dice Marco Francesconi, bisogna “decentrarsi dal
soggetto e porre l’accento sul contesto”. Credo infatti che nel
nostro contesto sociale attuale questo aspetto, che viene notato, di
un privilegio dell’uso sadico della sessualità nelle
rappresentazioni estetiche, serva a mascherare (o forse proprio
“negare”), in maniera quasi “orrorifica” una incapacità a
vivere in maniera vitale la sessualità, non solo in senso
procreativo, ma per l’aspetto “germinativo” della medesima. La
sessualità coincide con
la conoscenza. Sto
curando con Leo un libro su questo tema grazie agli studi di un mio
zio che sta analizzando il rapporto tra cabbalà, pensiero di Bion e
la coincidenza tra l’eros e
la conoscenza. In
esso la sessualità viene intesa come forza vitale di cui credo
abbiamo veramente paura, oggi più di ieri, più che al tempo di Freud,
perché la sessualità implica un entrare in una relazione molto
intima, coinvolgente comunque, anche se “si fa solo sesso” –
come si usa dire oggi, pensando di esorcizzare l’emozione che
inevitabilmente viene messa in scena. Il sadismo espresso nei racconti
o soprattutto nelle immagini (penso semplicemente a tante fotografie
che hanno uno sfondo di sadismo e che appaiono anche sui giornali di
moda femminile e maschile) avrebbe secondo me lo scopo di mettere una
distanza con la vitalità implicita nel rapporto sessuale. La
sessualità è intrisa di vitalità e distruttività (mi pare che sia
Marco Francesconi l’esperto sui temi della distruttività, ricordo
un suo lavoro portato qualche anno fa al gruppo di lavoro sulla
violenza, coordinato a Bologna da Maria Chiara Risoldi e Patrizia
Brunori, al quale lui, tu ed io partecipiamo). Che significato ha oggi
esibire modelli emaciati, fotografati in fabbriche dismesse, con abiti
sicuramente firmati e di valore che però sono indossati come fossero
stracci? Oppure immagini di donne dagli atteggiamenti violenti o
aggressivi abbinate ad automobili di lusso, sfavillanti. Centinaia di
romanzi e film dove vengono descritti, con dovizia di particolari,
aspetti profondamente perversi (tra essi penso all’interessante The
Cell, un film in cui viene ben descritta la mente perversa di un
sadico serial killer). Ha ragione Silvia Amati Sas: tutto questo ci
porta ad uno stato mentale protettivo di indifferenza e di
accettazione acritica, con l’illusione di evitare il moralismo, che
invece contribuisce a dar vita a una realtà che vede svilupparsi
lentamente e inesorabilmente una incapacità di critica, una
impossibilità di indignazione e l’accettazione passiva di qualunque
atteggiamento de-umanizzante.
Forse
mi allargo troppo, ma a volte penso che tanto disagio nei bambini e
negli adolescenti (tanti loro gesti violenti gravi) stiano a segnalare
la totale incapacità degli adulti a contenere le spinte – le
pulsioni sessuali vitali e al contempo distruttive - dove il
contenimento ha anche lo
scopo di differenziarle tra di loro. E’ come se l’adulto
negasse al proprio figlio lo sviluppo della capacità di vivere il
conflitto con i propri aspetti ambivalenti e ambigui. Conflitto che a
mio parere è indispensabile per la crescita mentale.
Quanto
questo contesto sociale fondato sulla negazione del conflitto (che
eventualmente viene unicamente agito) potrebbe condizionare l’esito
dei trattamenti psicoterapici e analitici (e tu accenni a questo nel
tuo scritto) e potrebbe essere nelle fondamenta della crisi attuale
della psicoanalisi?
Quanto
l’immagine sadica, rappresentata esteticamente, compare nei nostri
studi attraverso pericolose seduzioni messe in atto dai pazienti, che
non seducono più con la sessualità implicita negli innamoramenti
transferali, ma lo fanno con agiti anche violenti, miranti a
distruggere la coppia terapeutica che tenta di produrre pensieri
nuovi, che vorrebbe essere “germinativa” e “generativa”?
Stiamo
agendo un sadismo distruttivo. Il fatto che compaia nelle immagini e
negli scritti è segno che ci stiamo nutrendo di questa mentalità che
non riusciamo a mettere in discussione, perché ci siamo immersi, la
respiriamo: è inodore e incolore… perciò non la “sentiamo”, ne
neghiamo l’esistenza e ci illudiamo che sia “arte” e con ciò
giustifichiamo tutto. Qualsiasi schifezza!
Pochi
sembrano avere il coraggio di dire “il re è nudo”….>>
Leo: <<Colgo la domanda soprattutto in relazione al
cinema, in particolare laddove questo si occupa di psicoanalisi, ed in
particolar luogo di “psicoanalisi al femminile”. Il film di David
Cronenberg “A dangerous method” (2011) è emblematico in tal
senso: l’uso di scene sado-maso tra Jung e la Spielrein ha lo scopo
di banalizzare questioni serissime quali quelle dello sconfinamento
del setting o
dell’amore in psicoterapia. L’accanimento voyeuristico di
certe produzioni estetiche raggiunge poi le sue vette quando il
personaggio centrale è una donna, ed una pioniera della psicoanalisi
per giunta, come Sabina Spielrein. Il film non ci lascia nulla di
costei, dei suoi lasciti umani e professionali : l’interesse per la
dimensione spirituale della vita umana, per i conflitti etici nel
rapporto di cura. Il film lascia nello spettatore unicamente un
interesse pettegolo che dal buco della serratura, al posto dei dilemmi
della psicoanalisi, si occupa di scudisciate sulle natiche della
povera Spielrein. La storia della psicoanalisi al femminile viene
spesso letta da “pseudo-studiosi” con una lente distorta fatta,
nel peggior dei casi, di “pruderie” e voyeurismo e, nel migliore
dei casi, come agiografie di analiste-vestali che rimangono per tutta
la vita fedeli divulgatrici delle idee dei loro maestri-maschi.
All’uscita del film io e Laura Montani, psicoanalista della SPI e
curatrice dello “Spazio Rosenthal”, fingemmo, in un gioco
letterario a due, di immaginare come si sarebbe sentita Sabina a
essere trattata in questo modo da Cronenberg. “Cara Sabina ti
scrivo” è accessibile su internet nello “Spazio Rosenthal”>>.
●
Un’altra preziosa occasione di riflessione ha a che fare con la
bugia, che, come nota Resnik (171), può rivelarsi in terapia una
“forma di verità mascherata”, laddove compito dell’analisi
consiste nel permettere “d’introdurre i non-detti (l’anonimato o
il principio di omertà) in modo adeguato” (ibidem).
Altrimenti,
si tende “ad ‘agire’ il nascosto o a ‘metterlo in scena’, ma
in modo ben diverso da una sua rappresentazione manifesta, magari di
tipo isterico, che, teatralizzando il sintomo, lo rende, per quanto
ignoto al soggetto, quasi trasparente per l’osservatore, oppure sta
probabilmente affermandosi la tendenza a far convivere parti
disconnesse, lasciandole, come in Alice nel Paese delle Meraviglie, tutte
vincitrici e meritevoli di un premio (Per gli addetti ai lavori
occorrerebbe parlare di processi di dis-integrazione,
che alcuni hanno indicato come frattura dell’oggetto
interno). Oggi forse
ha perso significatività la relazione bioculare figura/sfondo
che, ponendo in risalto
una configurazione identitaria, un funzionamento, eventualmente anche
una problematica, lasciava in secondo piano un aspetto complementare
che, così rimosso, per quanto apparentemente assente, era in
realtà substrato di aspetti trasformati o, appunto, sublimati,
a favore della socialità e della civiltà” (Francesconi, 2006).
L’autore, in tal senso, si chiede se “sia possibile parlare di una
nuova forma di paura dell’inconscio (nel doppio senso di
paura che possiamo avere di ciò che è inconscio, ma anche di
paura provata dall’inconscio) che ricorre all’immobilizzazione
o alla distruzione piuttosto che ai meccanismi di scissione/proiezione
(nel solco del pensiero di Pichon Riviere e di Bleger), contribuendo a
mettere in scacco quella capacità di fare legami fra gli oggetti
psichici, costituendo così le basi di quel che indichiamo (non sempre
a proposito) come ‘umano’” (ivi).
A Salomon Resnik chiedo di spiegare cosa intenda con
l’affermazione che la bugia può rivelarsi in terapia una ‘forma
di verità mascherata’.
Resnik: <<Antonin Artaud, il grande poeta e attore
francese, diceva del sogno che si tratta di una serie di menzogne
“vere”. Questo significa che il sogno è una verità mascherata,
quindi un’apparente menzogna vera per quello che è capace di
“svelare” (aretè nel
pensiero greco). Socrate aveva la capacità di svelare la verità
intrinseca di quello che viene mascherato nell’apparire.
In
un capitolo del mio libro Biografie
dell’inconscio, dico metaforicamente ma anche veramente che
l’inconscio è visivo ma che viene mascherato o velato dalle
proiezioni inconsce del soggetto. Dopo una buona interpretazione
spesso il paziente dirà: “è vero, come mai non l’ho visto
prima?”. Quello che Freud chiama “sogno manifesto” è
l’espressione realistica ma al tempo stesso mascherata da quelle
menzogne vere di Artaud, che sono lo svelamento e il contatto con il
contenuto latente che si avvicina alla “verità” del messaggio. Io
ho messo verità tra virgolette perché credo che mai sia assoluta: se
la si considera tale, sarebbe una “vera menzogna” che non
chiede di essere smascherata. Questo si trova nelle persone ossessive
o troppo rigide che non tollerano il minimo di ambiguità riflessiva
(vedere il dubbio categorico in Cartesio o piuttosto l’ambiguità
pre-riflessiva con i termini del grande filosofo francese M.
Merleau-Ponty). Quando un bambino dice una menzogna formale alla mamma
o al papà è perché ha paura di dire le cose direttamente e ha
bisogno di un’alternativa indiretta che sarebbe la maschera
dell’apparente non verità che è anche la sua verità.
Non
voglio dilungarmi oltre perché il tema della menzogna e della verità
appare in diversi saggi e lavori miei. E’ il tema che mi appassiona
di più rispetto ad ogni tipo di ricerca su tutto quello che è
sottostante o sostanziale in ogni discorso metafisico o quotidiano>>.
Un’altra questione che chiedo a Resnik di approfondire
riguarda la ragione per la quale intende con ‘non-detti’
l’anonimato o il principio di omertà. Inoltre,
gli chiederei di spiegare perché distingue nel testo
l’‘anonimato’ dal ‘principio di omertà’, concetti che
infatti separa con una ‘o’.
Resnik: <<Con anonimato intendiamo una realtà o una
certa “verità”, che non ha nome, o il cui nome o autore è
ignoto. Bion parla del “nameless dread”, cioè di un’esperienza
di paura, di panico o di scoperta impattante, che provoca una paura
senza nome, una sensazione paurosa senza nome o che è priva di
espressione diretta di un’esperienza impattante e quasi impossibile
da esprimere. Nel principio di omertà, c’è un nome dietro a ciò
che manifestamente è nascosto o mascherato, ma che non deve essere
pronunciato perché potrebbe scatenare uno scandalo, un terrore
innominabile, e soprattutto un tradimento alla cosiddetta
“famiglia” o clan che si protegge con l’omertà>>.
●
Non c’è qui lo spazio per rendere il dovuto merito ai due tanto
poderosi quanto preziosi contributi di Leo e Litowitz, che possono a
ben vedere essere definiti tra le ricapitolazioni più efficaci ed
esaustive dell’evoluzione e delle possibili declinazioni dei
concetti di negazione, diniego,
disconoscimento, rigetto.
Ricapitolazioni
non solo nell’opera di Freud ma, anche, nel pensiero a lui
successivo, con le diramazioni nel pensiero di Anna Freud (nota 7), di
Melanie Klein, di Wilfred Bion (ad esempio tratteggiando
l’evoluzione dalla “negazione della realtà e dell’inibizione
della fantasia” della Klein [1929, 227] all’attacco al legame -
cioè al pensiero - descritto da Bion); nominando l’eredità
problematica per gli allievi della Klein derivante dal fatto che
l’autrice usa “termini diversi – repudiation, denial, negation
– per intendere il diniego della realtà esterna, nel senso della Verleugnung
freudiana” (Leo, 51); descrivendo la rivoluzione compiuta dalla
Klein (1935) rispetto a Freud quando fa del “diniego della realtà
psichica” una della “primissime difese”, “riferendo in modo più
aderente al mondo interno questa ‘scotomizzazione’, unicamente
dalla quale può derivare il diniego del mondo esterno di cui Freud si
era maggiormente occupato” (Leo, 53). Nel contributo di Leo,
importante anche la disamina della negazione nei gruppi terapeutici ed
istituzionali; in queste pagine, prezioso il riferimento (73)
all’“Assunto di base di Omertà” proposto da Riccardo Romano
(2006) e molto utile la descrizione del destino dei temi del diniego e
della negazione nella psicoanalisi istituzionale francese (82 e segg)
e quella della negazione nell’Infant Research (89 segg) e nelle
neuroscienze. Mi piace invitare l’autore ad approfondire tale
questione anche nel ricco materiale messo ai nostri giorni a
disposizione dall’Infant Observation, metodo che in Italia ha avuto,
grazie al pensiero di Lina Generali Clements, Dina Vallino, Suzanne
Maiello, Gina Ferrara Mori ed altri che non posso nominare per ragioni
di spazio, una declinazione particolare oltre che particolarmente
fertile. In rapporto alle neuroscienze, ho gradito l’ammonimento di
Leo rispetto al “rischio di errori epistemologici che possono
nascere dall’’unificare’ il campo della psicoanalisi con quello
delle neuroscienze, o forse meglio sarebbe dire dall’’annettere’
la psicoanalisi al dominio delle neuroscienze” (96).
Litowitz
non è da meno. Per dire del suo contributo, preferisco affidarmi a
quanto lui stesso scrive nella Conclusione del suo lavoro: “Ho
cercato di mostrare che i dati provenienti dalla psicolinguistica
dello sviluppo forniscono una spiegazione che è coerente con gli
stadi di sviluppo secondo Freud, ma che anche li espande. Questo
articolo tenta un riesame della negazione alla luce di questi dati
successivi, ed esplora le distinzioni provenienti dalla filosofia del
linguaggio per suggerire i modi in cui la negazione performativa entra
negli scambi psicoanalitici. La mia conclusione è che una linea
ampliata di sviluppo per la negazione – comprendente il rigetto (rejection
), il rifiuto così come la negazione (denial) – fornisce modalità
aggiuntive di ascolto e di lettura delle variegate e mutevoli
posizioni difensive incontrate nelle interazioni cliniche” (140). In
effetti, Litowitz prosegue ed approfondisce quello che era
probabilmente l’intento originario di Freud quando scrisse il lavoro
sulla negazione: “esplorarla come un tipo di difesa” (138).
Interessanti in tal senso i preziosi riferimenti clinici contenuti nel
testo, in particolare quello concernente un (bioniano) capovolgimento
di prospettiva inerente il setting analitico, che permette
all’autore di mostrare come il rifiuto di una paziente di Novick
(1990, pp.335-349) di usare a un certo punto del trattamento il
lettino possa essere interpretato non solo nel modo proposto da Novick
stesso (1990, p.346), ma, anche, come “un passo avanti nello
sviluppo, reso possibile dal lavoro analitico precedente” (127).
Infatti, Litowitz propone di pensare al setting analitico come a un
contenitore delle “introiezioni materne maligne che sono state
rigettate, sputate via” (127); questa espressione potrebbe evocare
il concetto di J. Kristeva di “abiezione” (1980).
●
Proprio a proposito del setting e delle sue necessarie ‘rivisitazioni’,
molto significative le riflessioni di Tarantini sui tempi e i modi dei
suoi incontri con pazienti da lei seguiti nel 2002 a Tunisi su
richiesta dell’IAAP (International Association of Analytic
Psychology) allo scopo di formare un primo nucleo di analisti
junghiani tunisini: “tre giorni ogni mese, durante i quali li
incontravo due o tre volte di seguito” (381). Osserva l’autrice:
“Diventavo, durante quel quasi-mese di separazione, una figura
assente-presente […] una figura di morte con cui credo ogni analisi,
anche la più ortodossa, debba abituarci a convivere. Altrimenti il
rischio è di diventare interminabile” (382).
●
Sulla valenza imprevedibilmente e paradossalmente ‘positiva’ del
diniego interessantissimo il contributo di Šebek, che obbliga a
decentrarsi dalla sicurezza dei nostri studi occidentali, per
immaginare (e mi chiedo quanto davvero riescano simili operazioni di
immedesimazione) di lavorare in clandestinità, come nella
Cecoslovacchia degli anni dal 1939 al 1989…. In clandestinità il
diniego del pericolo esterno, da un lato, quanto quello del
totalitarismo, dall’altro (come, in balia di oggetti totalitari,
permettersi libere associazioni?), si è rivelato un valido supporto
della psicoanalisi. Ne conseguono ulteriori significative riflessioni
su quello che l’autore chiama l’’oggetto totalitario’
nella sua relazione con la ‘situazione totalitaria’, nella
quale “Un certo grado di sfiducia e di paranoia […] è parte”
(301). Interessante in quest’area il riferimento alle esperienze
dell’analista iraniana Gohar Homayounpour (2012) e dell’analista
tedesca Annette Simon (2008).
●
Significativo anche l’invito ad approfondire il rischio, presente
nel trattamento di pazienti gravemente traumatizzati, per i quali,
come fa osservare Schneider, il cambiamento ottenuto nella cura può
costituirsi come “una catastrofe mortale” (311). L’autore
infatti si concentra sui rischi connessi alla rimozione di una
scissione, “che può essere parte di una cura, ma può anche
ritorcersi come un pericolo, e persino una minaccia mortale. Come
diceva Freud: «la guarigione stessa è trattata dall’Io alla
stregua di un nuovo pericolo» (Freud, 1937, 521)” (310).
Innumerevoli
le altre occasioni di riflessione offerte dal volume: le osservazioni
sulle traduzioni, sia sul piano metapsicologico - sul versante del
modo in cui possono addirittura inficiare il contenuto di un modello
(Leo, 61); su quello per cui i traduttori possono creare dei
‘bias’ in grado di condizionare pesantemente la teorizzazione
(Leo, 43) -, sia su quello clinico, come nel caso di quel paziente
“che poteva piangere sul divano solo nella sua lingua originaria.
[…] Il paziente sentiva che c’erano alcune parti della sua
esperienza traumatica che non era possibile tradurre” (Šebek, 304).
A
tale proposito, mi chiedo quanto il francese, la lingua scelta da
Tarantini per comunicare con i suoi pazienti tunisini, fosse
realmente, come lei dice, “una lingua straniera per entrambi, […]
una specie di terra di nessuno […] una terra neutra” (374-375)
nell’accezione positiva che in questo specifico caso l’autrice dà
a questo termine, dal momento che la Tunisia fu colonia francese dal
1830… A tale proposito, interessante il confronto con l’esperienza
narrata da Assia Djebar (2002) e l’evocazione di ciò di cui parla
Elisabeth Bing in …Ho nuotato
fino alla riga, ponendo in esergo
queste parole di Beckett: “Follia,
dover parlare e non potere, tranne che di cose che non mi
riguardano… di cui mi hanno ingozzato per impedirmi di dire chi
sono, dove sono, di fare quel che devo fare – io sono nelle parole,
sono fatto delle parole di altri […] E io le lascio dire, le mie
parole, che non sono mie… […] Ecco la parola che mi hanno dato”
(Beckett, in Bing, 1976, 39).
Per
concludere: un libro da leggere e rileggere; da meditare; da
utilizzare per ascoltare chi si rivolge alla psicoanalisi dopo aver
vissuto esperienze estreme; da utilizzare nei corsi di laurea e nelle
specializzazioni in Psicologia, in Neuropsichiatria Infantile, in
Psichiatria e nelle Scuole di formazione psicoterapeutica.
|