Nel borgo di Badolato, divenuto
più laborioso e più vitalista dopo il consolidamento delle forme moderne e libere del
possesso fondiario, il dogma e la liturgia traboccavano da ogni parte: la religione,
rinvigorita dalla teologia posttridentina (C. Giacon, La seconda
scolastica, Milano 1944-1950, tre volumi), dalla riforma episcopale, dalle
associazioni mariane, dalla costituzione "Dei Filius" che oppose al materialismo
moderno la rivelazione e la fede, dal rinnovamento della letteratura
spirituale, vi permeava ogni cosa in forme effusive e sentimentali,
emozionali ed estetiche; e la secolare tradizione del Sabato Santo, che attirava
molto popolo di devoti, era veramente fervore e festa, austerità e letizia espansiva,
convinzione e apparenza, fede e folclore, spettacolo ricco e vitale.
 Nella Badolato attuale, secolarizzata e consumistica, dove
sempre più sconsolante s'impone il senso della vacuità e della nullità del mondo,
ha ancora un grande rilievo, anche per offrire motivi d'attrazione alla folla e ai
visitatori solitamente tanto avidi di novità e di pittoresco, l'apoteosica e monumentale
processione del Sabato Santo, i cui ingredienti di base sono la caratteristica
configurazione naturale e urbana del borgo medioevale (la ridente floridezza degli
orti e della campagna in gran parte merito del faticoso lavoro dell'uomo che sulle cime
dei colli educò l'olivo e la vigna, i labirintici tracciati dei vicoli e delle Viuzze, le
linee serene e tranquille dei palazzi e dell'edilizia minore così care e familiari alle
generazioni dei tempi passati, inducono qui all'effusione e al delirio), la
benignità del clima, la luminosità del sole che esalta potentemente i colori e profila
nettamente le forme. Nella Badolato attuale, secolarizzata e consumistica, dove
sempre più sconsolante s'impone il senso della vacuità e della nullità del mondo,
ha ancora un grande rilievo, anche per offrire motivi d'attrazione alla folla e ai
visitatori solitamente tanto avidi di novità e di pittoresco, l'apoteosica e monumentale
processione del Sabato Santo, i cui ingredienti di base sono la caratteristica
configurazione naturale e urbana del borgo medioevale (la ridente floridezza degli
orti e della campagna in gran parte merito del faticoso lavoro dell'uomo che sulle cime
dei colli educò l'olivo e la vigna, i labirintici tracciati dei vicoli e delle Viuzze, le
linee serene e tranquille dei palazzi e dell'edilizia minore così care e familiari alle
generazioni dei tempi passati, inducono qui all'effusione e al delirio), la
benignità del clima, la luminosità del sole che esalta potentemente i colori e profila
nettamente le forme.
La processione del Sabato Santo esce alle 13 dalla Chiesa
dell'Immacolata Concezione: per afflato drammatico e per splendore ambientale, è uno
spettacolo unico e senza pari tra le manifestazioni religiose calabresi, a
mio giudizio collegabile in qualche modo alla celebre Settimana Santa di Siviglia dove,
nel 1975, mi commossi al passaggio del paso della Confraternita del Porvenir,
raffigurante Maria Santissima de la Paz, e del paso del Cristo de la Salud della
Confraternita di San Bernardo (fondata nel 1748), avendo letto il libro di F. Gonsàles de
Leòn, Historia critica y descriptiva de las Cofradìas fundadas en la ciudad de
Sevilla, ivi 1852, e quello di J. Bermeio, Glorias religiosas de Sevilla, ivi
1882. Essa s'identifica con le concezioni mentali e psicologiche dei
badolatesi, e con la loro enfasi estroversa, con la loro atavica concezione esistenziale
provvidenzialista. 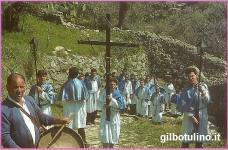 Apre la sfilata la
Croce processionale (altezza cm 137, Cristo scolpito e dipinto cm 39), in legno intagliato
da uno scultore provinciale del secolo decimonono, portata da un Confratello, e scortata
da ben otto cantori, tra cui Salvatore Papaleo detto "Brundu", nato il 2 marzo
1950. Per devozione o per gusto estetico, questi personaggi eseguono coralmente, con molto
compiacimento dei devoti, mestissimi canti "narrativi", i quali, forse
derivati da alcune orazioni umbro-abruzzesi, studiate da Paolo Toschi, Poesia e vita di
popolo, Venezia 1946, pp. 96-110, o da canti del secolo decimottavo, composti e
diffusi da Missionari Gesuiti ripetutamente inviati in Calabria a rievangelizzare le plebi
rurali, rappresentano drammaticamente la passione di Gesù e il dolore di Maria con
andamento epico-lirico, e talora con microvarianti addebitabili al singolo cantore non
interessato al contenuto del testo. Nonostante i profondi mutamenti socio-economici,
questi canti di Passione, con cui la cultura di tradizione orale e le possibilità
espressive delle classi subalterne si esplicano, sono ancora molto in voga, certo non come nel 1711, quando a Morano Calabro fu rappresentata per volontà
del Principe di Scalca la Passione di Gesù Cristo del P. Veneziano Barbastefano
Cappuccino, o nel 1813-1817, allorché a Badolato fu rappresentato, nella Chiesa del
Convento Domenicano, Il Martorio ossia la Passione, e Morte di Nostro Signore Gesù
Cristo, del Sacerdote D. Niccolò Gallelli (+ 16 luglio 1739), Utroque jure Doctor
(U.J.D.), ed essi vanno considerati, per la loro complessità formale e per la loro
evoluzione diacronica, molto utili all'analisi antropologica, genetico-tipologica e
contenutistico-sociale, alla dialettologia, e financo all'etnomusicologia. Apre la sfilata la
Croce processionale (altezza cm 137, Cristo scolpito e dipinto cm 39), in legno intagliato
da uno scultore provinciale del secolo decimonono, portata da un Confratello, e scortata
da ben otto cantori, tra cui Salvatore Papaleo detto "Brundu", nato il 2 marzo
1950. Per devozione o per gusto estetico, questi personaggi eseguono coralmente, con molto
compiacimento dei devoti, mestissimi canti "narrativi", i quali, forse
derivati da alcune orazioni umbro-abruzzesi, studiate da Paolo Toschi, Poesia e vita di
popolo, Venezia 1946, pp. 96-110, o da canti del secolo decimottavo, composti e
diffusi da Missionari Gesuiti ripetutamente inviati in Calabria a rievangelizzare le plebi
rurali, rappresentano drammaticamente la passione di Gesù e il dolore di Maria con
andamento epico-lirico, e talora con microvarianti addebitabili al singolo cantore non
interessato al contenuto del testo. Nonostante i profondi mutamenti socio-economici,
questi canti di Passione, con cui la cultura di tradizione orale e le possibilità
espressive delle classi subalterne si esplicano, sono ancora molto in voga, certo non come nel 1711, quando a Morano Calabro fu rappresentata per volontà
del Principe di Scalca la Passione di Gesù Cristo del P. Veneziano Barbastefano
Cappuccino, o nel 1813-1817, allorché a Badolato fu rappresentato, nella Chiesa del
Convento Domenicano, Il Martorio ossia la Passione, e Morte di Nostro Signore Gesù
Cristo, del Sacerdote D. Niccolò Gallelli (+ 16 luglio 1739), Utroque jure Doctor
(U.J.D.), ed essi vanno considerati, per la loro complessità formale e per la loro
evoluzione diacronica, molto utili all'analisi antropologica, genetico-tipologica e
contenutistico-sociale, alla dialettologia, e financo all'etnomusicologia.
 Malinconico è lo spettacolo quando s'avanza Cristo vivo,
impersonato nel 1934 da 'U Zoppu du Mortu, che abitava nel rione San Gianni: ha la
tunica di velluto viola, stretta ai fianchi da un cingolo, e strascina, fatto di natura
drammatica ed escatologica, una pesante Croce penitenziale lignea, tra otto
"giudei" scalzi, i quali assieme col sottocapo pronunziano, con sentimento
incontenibilmente euforico, ingiurie o bestemmie d'impronta popolaresca e incomprensibili.
Di tanto in tanto, il loro capo, prima del 1970 rappresentato da Saverio Cundò e dal 1983
da Peppino Cossari "Còccari", con tutta la sua serietà gli punzecchia la testa
col gladio e gli flagella il corpo con una sferza sonante. Nel marzo 1944, si ebbe
addirittura un episodio di violenza: il capo dei "giudei", Ferdinando Feudale
(1898- 1978), che figura nel poemetto dialettale A Santa missioni
("Ferdinandu, cu na mbrema, / chi parìa nu generala, / chiju jornu era e serviziu, /
chi facìa lu nchjacca cana"), composto in quarantotto quartine variamente rimate da
un anonimo durante le Missioni dell'aprile 1940, poiché le autorità non gli
permisero di strascinare Cristo, impersonato da Fortunato Fiorenza "Tabanu",
dentro la Matrice per cinque volte (le consuete tre più le due che avanzava dall'anno
precedente), si vendicò immediatamente dell'affronto patito, rinfacciando ogni specie di
corruzioni e indegnità, minacciando di dare bastonate, tenendo in sospeso
gli animi del pubblico. A Badolato, vissero parecchi "perfidi"
giudei o ebrei aschenaziti, affiliati all'antispagnola Rosa-Croce, oppure seguaci del Gran
Maestro della tradizione cabbalistico-alchemica Hyim Vitale Calabrese (G.G. Scholem, Le
grandi correnti della mistica ebraica), dell'esponente della Cabbala
estatico-profetica Abraham Abulafia (1483), di Guglielmo Raimondo di Moncada (1484), cui
si deve l'edizione reggina dell'Heptaplus, e di Jarchi bar Isaac (1488), che fece
stampare a Reggio il suo commento ai primi cinque libri della Bibbia (1475). Malinconico è lo spettacolo quando s'avanza Cristo vivo,
impersonato nel 1934 da 'U Zoppu du Mortu, che abitava nel rione San Gianni: ha la
tunica di velluto viola, stretta ai fianchi da un cingolo, e strascina, fatto di natura
drammatica ed escatologica, una pesante Croce penitenziale lignea, tra otto
"giudei" scalzi, i quali assieme col sottocapo pronunziano, con sentimento
incontenibilmente euforico, ingiurie o bestemmie d'impronta popolaresca e incomprensibili.
Di tanto in tanto, il loro capo, prima del 1970 rappresentato da Saverio Cundò e dal 1983
da Peppino Cossari "Còccari", con tutta la sua serietà gli punzecchia la testa
col gladio e gli flagella il corpo con una sferza sonante. Nel marzo 1944, si ebbe
addirittura un episodio di violenza: il capo dei "giudei", Ferdinando Feudale
(1898- 1978), che figura nel poemetto dialettale A Santa missioni
("Ferdinandu, cu na mbrema, / chi parìa nu generala, / chiju jornu era e serviziu, /
chi facìa lu nchjacca cana"), composto in quarantotto quartine variamente rimate da
un anonimo durante le Missioni dell'aprile 1940, poiché le autorità non gli
permisero di strascinare Cristo, impersonato da Fortunato Fiorenza "Tabanu",
dentro la Matrice per cinque volte (le consuete tre più le due che avanzava dall'anno
precedente), si vendicò immediatamente dell'affronto patito, rinfacciando ogni specie di
corruzioni e indegnità, minacciando di dare bastonate, tenendo in sospeso
gli animi del pubblico. A Badolato, vissero parecchi "perfidi"
giudei o ebrei aschenaziti, affiliati all'antispagnola Rosa-Croce, oppure seguaci del Gran
Maestro della tradizione cabbalistico-alchemica Hyim Vitale Calabrese (G.G. Scholem, Le
grandi correnti della mistica ebraica), dell'esponente della Cabbala
estatico-profetica Abraham Abulafia (1483), di Guglielmo Raimondo di Moncada (1484), cui
si deve l'edizione reggina dell'Heptaplus, e di Jarchi bar Isaac (1488), che fece
stampare a Reggio il suo commento ai primi cinque libri della Bibbia (1475).
 Perfetto dal punto di vista anatomico, il sacro corpo sanguinante
di Cristo morto, simbolo supremo della Settimana Santa, col volto secco e arido,
rappresentazione realistica ed essenziale del dolore umano, giace dolcemente su candide
lenzuola nella Varetta (attorniata da giovani portatori di caratteristici lampioni), opera
dall'originale disegno (rivaleggia in bellezza con la Varetta del Maestro ebanista Peppino
Caporale, nella Chiesa del Convento Domenicano) forse del Maestro falegname-intagliatore
Peppino Loyero (congiunto del Maestro falegname Antonio Loyero, Priore della Confraternita
di Santa Caterina), di fattura eccellente, eseguita verso il 1930 per sostituire quella
più antica, la quale ubbidiva alla più pura ispirazione dell'estetica religiosa
universale. Perfetto dal punto di vista anatomico, il sacro corpo sanguinante
di Cristo morto, simbolo supremo della Settimana Santa, col volto secco e arido,
rappresentazione realistica ed essenziale del dolore umano, giace dolcemente su candide
lenzuola nella Varetta (attorniata da giovani portatori di caratteristici lampioni), opera
dall'originale disegno (rivaleggia in bellezza con la Varetta del Maestro ebanista Peppino
Caporale, nella Chiesa del Convento Domenicano) forse del Maestro falegname-intagliatore
Peppino Loyero (congiunto del Maestro falegname Antonio Loyero, Priore della Confraternita
di Santa Caterina), di fattura eccellente, eseguita verso il 1930 per sostituire quella
più antica, la quale ubbidiva alla più pura ispirazione dell'estetica religiosa
universale.
 I penitenti , come gli hermanos mayores
della sivigliana Confraternita di San Gonzalo, sono coperti interamente dalla
tunica, stretta alla vita da una corda a modo di cintura, e dal cappuccio con due fori per
gli occhi (la tradizionale costumanza di coprirsi il volto col cappuccio
risale al secolo decimoquarto, quando ad Avignone il Pontefice Clemente VI vietò ogni
forma di mortificazione pubblica) : essi vestono in bianco, hanno attorno al capo
una corona di spine, si battono la schiena con le discipline (erano eseguite dai Maestri
fabbri Peppino Argirò "'e Roccu" che abitava nel Destro, Giuseppe Caporale
"Jaci", Pasquale Caporale con forgia in via Vittorio Emanuele III, Andrea
Fiorenza "Muzzu", Domenico Guarna "Varirharu", Domenico Paparo
"Cciperda"), secondo la tendenza barocca di esteriorizzare enfaticamente i
sentimenti religiosi, e vanno su due file parallele con gusto retorico ottocentesco. Il rito dell'autoflagellazione richiama le Compagnie di penitenza, create nel
Medioevo dai predicatori popolari. Nel 1262, il Comune di Firenze, allora ghibellino, fece
mettere in fuga, presso Signa, dai suoi cavalieri, e dalla milizia cittadina, una schiera
di flagellanti. Alla fine del Dugento, Fra Giordano aveva fondato a Pisa una Confraternita
di disciplinati sotto il nome di "Società di San Salvatore" (Cronaca di
Santa Caterina, Archivio Storico Italiano, VI, tomo VI, Istorie Pisane, I, p.
451 e sg.), sorta con lo scopo d'opporsi al disordinato vagare dei flagellanti, i quali,
nel 1315, dall'Alta Italia si erano diffusi verso il Mezzogiorno, seguendo uno stendardo
con Cristo flagellato. Nel 1304, a Napoli venne fondata una Congregazione di battenti che
usavano flagellarsi il Giovedì e il Venerdì Santi: ne fecero parte Carlo II d'Angiò, e
taluni Baroni. Nel 1335, il Domenicano Fra Venturino da Bergamo apparve a Firenze alla
testa di molte migliaia di flagellanti, vestiti di bianche tonache con mantelli neri e
azzurri. Nella Biblioteca Nazionale di Firenze vidi i Capitoli della Compagnia dei
Disciplinati della città di Firenze, edizione Ferrato, fondata il l° gennaio 1334
(1335): lo statuto nel quale ne è menzionata la fondazione al l° gennaio 1334 (1335) fu
redatto nel luglio 1354, con modificazione del 1374. Nel maggio del 1361, fu affidata agli
Arcivescovi di Napoli, Benevento e Salerno una inchiesta sulla vita e sugli usi dei
flagellanti nel Regno (Regesto Vaticano per la Calabria, n. 7585). Nella Bolla
concessa dal Vescovo di Squillace, Francesco Arciero, celebre Giureconsulto, carissimo al
Principe di Rossano Francesco Marzano, alla Confraternita di Santa Caterina di Guardavalle
leggesi che le Congreghe dei disciplinati si trovavano "in multis Regni
partibus". Tra il 1480 e il 1520, a Cropani e a Roccella ionica esistevano
Confraternite di battenti (M. Pretto, La pietà popolare in Calabria, Cosenza
1988). Un olio su tela di Pieter Van Laer detto "Bamboccio", eseguito nel 1628,
custodito nell'Alte Pinakothek di Monaco, rappresenta due uomini incappucciati e scalzi
che si percuotono con le discipline. Il Martedì Santo, a Siviglia, il Libro delle
regole della Confraternita di San Esteban (di origini molto antiche, ma di recente
ristrutturazione), nel quale sono riportati i precetti, gli obblighi dei membri, le
disposizioni amministrative ed economiche che ne regolano l'esistenza, è portato in
processione da un penitente incappucciato. Nel 1971, ricercando in Francia i registri
dell'officialità di Cerisy (1314-1457, 1474-1486) e di quella arcidiaconale di Parigi nel
Rinascimento, appresi che la plurisecolare politica delle Missioni religiose parrocchiali
contribuì alla lenta trasformazione dei riti di autoflagellazione nell'Europa
occidentale. Cfr. G. Arlandi, Missioni parrocchiali e drammatica popolare, 1974. I penitenti , come gli hermanos mayores
della sivigliana Confraternita di San Gonzalo, sono coperti interamente dalla
tunica, stretta alla vita da una corda a modo di cintura, e dal cappuccio con due fori per
gli occhi (la tradizionale costumanza di coprirsi il volto col cappuccio
risale al secolo decimoquarto, quando ad Avignone il Pontefice Clemente VI vietò ogni
forma di mortificazione pubblica) : essi vestono in bianco, hanno attorno al capo
una corona di spine, si battono la schiena con le discipline (erano eseguite dai Maestri
fabbri Peppino Argirò "'e Roccu" che abitava nel Destro, Giuseppe Caporale
"Jaci", Pasquale Caporale con forgia in via Vittorio Emanuele III, Andrea
Fiorenza "Muzzu", Domenico Guarna "Varirharu", Domenico Paparo
"Cciperda"), secondo la tendenza barocca di esteriorizzare enfaticamente i
sentimenti religiosi, e vanno su due file parallele con gusto retorico ottocentesco. Il rito dell'autoflagellazione richiama le Compagnie di penitenza, create nel
Medioevo dai predicatori popolari. Nel 1262, il Comune di Firenze, allora ghibellino, fece
mettere in fuga, presso Signa, dai suoi cavalieri, e dalla milizia cittadina, una schiera
di flagellanti. Alla fine del Dugento, Fra Giordano aveva fondato a Pisa una Confraternita
di disciplinati sotto il nome di "Società di San Salvatore" (Cronaca di
Santa Caterina, Archivio Storico Italiano, VI, tomo VI, Istorie Pisane, I, p.
451 e sg.), sorta con lo scopo d'opporsi al disordinato vagare dei flagellanti, i quali,
nel 1315, dall'Alta Italia si erano diffusi verso il Mezzogiorno, seguendo uno stendardo
con Cristo flagellato. Nel 1304, a Napoli venne fondata una Congregazione di battenti che
usavano flagellarsi il Giovedì e il Venerdì Santi: ne fecero parte Carlo II d'Angiò, e
taluni Baroni. Nel 1335, il Domenicano Fra Venturino da Bergamo apparve a Firenze alla
testa di molte migliaia di flagellanti, vestiti di bianche tonache con mantelli neri e
azzurri. Nella Biblioteca Nazionale di Firenze vidi i Capitoli della Compagnia dei
Disciplinati della città di Firenze, edizione Ferrato, fondata il l° gennaio 1334
(1335): lo statuto nel quale ne è menzionata la fondazione al l° gennaio 1334 (1335) fu
redatto nel luglio 1354, con modificazione del 1374. Nel maggio del 1361, fu affidata agli
Arcivescovi di Napoli, Benevento e Salerno una inchiesta sulla vita e sugli usi dei
flagellanti nel Regno (Regesto Vaticano per la Calabria, n. 7585). Nella Bolla
concessa dal Vescovo di Squillace, Francesco Arciero, celebre Giureconsulto, carissimo al
Principe di Rossano Francesco Marzano, alla Confraternita di Santa Caterina di Guardavalle
leggesi che le Congreghe dei disciplinati si trovavano "in multis Regni
partibus". Tra il 1480 e il 1520, a Cropani e a Roccella ionica esistevano
Confraternite di battenti (M. Pretto, La pietà popolare in Calabria, Cosenza
1988). Un olio su tela di Pieter Van Laer detto "Bamboccio", eseguito nel 1628,
custodito nell'Alte Pinakothek di Monaco, rappresenta due uomini incappucciati e scalzi
che si percuotono con le discipline. Il Martedì Santo, a Siviglia, il Libro delle
regole della Confraternita di San Esteban (di origini molto antiche, ma di recente
ristrutturazione), nel quale sono riportati i precetti, gli obblighi dei membri, le
disposizioni amministrative ed economiche che ne regolano l'esistenza, è portato in
processione da un penitente incappucciato. Nel 1971, ricercando in Francia i registri
dell'officialità di Cerisy (1314-1457, 1474-1486) e di quella arcidiaconale di Parigi nel
Rinascimento, appresi che la plurisecolare politica delle Missioni religiose parrocchiali
contribuì alla lenta trasformazione dei riti di autoflagellazione nell'Europa
occidentale. Cfr. G. Arlandi, Missioni parrocchiali e drammatica popolare, 1974.
 Gli alabardieri, armati d'alabarda e scudo di legno, procedono in
modo teatrale, mentre luccica al sole la lorica al petto, fatta di lamine di zinco
ben tagliate, e svolazza alle spalle un tappeto infiorato che funge da mantiglia: invece,
davanti, giù dalla lorica fa bella mostra una sottana femminile ricamata, con mutande a
balza, ornate anch'esse di un ricco merletto; la mano è inguantata, e dal polso destro
pende con grazia un fazzoletto di pizzo profumato. Essi rassomigliano ai
soldati reggini (flagellatori di Cristo), certamente d'origine bruzia, secondo un
frammento, confermato da Festo Pompeo (II secolo d.C.), autore di un compendio dell'opera
lessicale di M. Verrio Flacco De Verborum significatione, del grammatico Aulo
Gellio (115 a.C.), il quale, nelle sue Notti Attiche, scrive: "Poiché nessuno
chieda dei Bruziani, significa questo: essendo il cartaginese Annibale in Italia e avendo
combattuto alcune battaglie sfavorevoli per il popolo romano, primi di tutta Italia i
Bruzi passarono ad Annibale... Poiché erano tratti dai Bruzi, sono stati detti
Bruziani". Con "Italia", Aulo Gellio intende, evidentemente, la Calabria: i
Bruzi comparvero in Calabria, misteriosamente, nel secolo quinto a.C. In Reggio, i cui
abitanti, dall'89 a.C., divennero cittadini romani, durante la guerra tra Ottaviano e
Sesto Pompeo (42-36 a.C.) era di stanza la Legio X Fretensis (stanziatasi pure a
Palmizia in Siria e a Gerasa dove Gesù liberò dai demoni i "Geraseni
ossessi"), comandata da Salvidieno Rufo (poi da Sesto Pompeo, un autentico pirata, un
sacrilego, che non risparmiò il tempio di Hera Lacinia a Crotone), costituita anche da
reggini (F. Costabile, La città e il mare, Reggio Calabria 1988), e da elementi
bruzi che presero parte alla Passione e Morte di Gesù. In N.G. Marchese, Calabria
dimenticata, Napoli 1982, pp. 90-91, leggiamo, a proposito dei primi collegamenti dei
Bruzi coi Cristiani: "Se dovessimo attenerci unicamente ai risultati
dell'interpretazione letterale dei testi sacri e fosse legittimo trarre conclusioni
definitive circa gli antichi avvenimenti dall'analisi lessicale delle parole ivi usate,
allora saremmo indotti ad avanzare l'ipotesi che il centurione Cornelio e tutta la sua
famiglia, che per primo venne convertito dalle parole di Pietro, fosse di origine
calabrese" ("Calabria Sconosciuta", a. XIII, n. 46, gennaio-marzo 1990, Erano
Bruzi di Reggio i soldati che crocifissero Gesù?, di Domenico Rotundo, pp. 29-34). Gli alabardieri, armati d'alabarda e scudo di legno, procedono in
modo teatrale, mentre luccica al sole la lorica al petto, fatta di lamine di zinco
ben tagliate, e svolazza alle spalle un tappeto infiorato che funge da mantiglia: invece,
davanti, giù dalla lorica fa bella mostra una sottana femminile ricamata, con mutande a
balza, ornate anch'esse di un ricco merletto; la mano è inguantata, e dal polso destro
pende con grazia un fazzoletto di pizzo profumato. Essi rassomigliano ai
soldati reggini (flagellatori di Cristo), certamente d'origine bruzia, secondo un
frammento, confermato da Festo Pompeo (II secolo d.C.), autore di un compendio dell'opera
lessicale di M. Verrio Flacco De Verborum significatione, del grammatico Aulo
Gellio (115 a.C.), il quale, nelle sue Notti Attiche, scrive: "Poiché nessuno
chieda dei Bruziani, significa questo: essendo il cartaginese Annibale in Italia e avendo
combattuto alcune battaglie sfavorevoli per il popolo romano, primi di tutta Italia i
Bruzi passarono ad Annibale... Poiché erano tratti dai Bruzi, sono stati detti
Bruziani". Con "Italia", Aulo Gellio intende, evidentemente, la Calabria: i
Bruzi comparvero in Calabria, misteriosamente, nel secolo quinto a.C. In Reggio, i cui
abitanti, dall'89 a.C., divennero cittadini romani, durante la guerra tra Ottaviano e
Sesto Pompeo (42-36 a.C.) era di stanza la Legio X Fretensis (stanziatasi pure a
Palmizia in Siria e a Gerasa dove Gesù liberò dai demoni i "Geraseni
ossessi"), comandata da Salvidieno Rufo (poi da Sesto Pompeo, un autentico pirata, un
sacrilego, che non risparmiò il tempio di Hera Lacinia a Crotone), costituita anche da
reggini (F. Costabile, La città e il mare, Reggio Calabria 1988), e da elementi
bruzi che presero parte alla Passione e Morte di Gesù. In N.G. Marchese, Calabria
dimenticata, Napoli 1982, pp. 90-91, leggiamo, a proposito dei primi collegamenti dei
Bruzi coi Cristiani: "Se dovessimo attenerci unicamente ai risultati
dell'interpretazione letterale dei testi sacri e fosse legittimo trarre conclusioni
definitive circa gli antichi avvenimenti dall'analisi lessicale delle parole ivi usate,
allora saremmo indotti ad avanzare l'ipotesi che il centurione Cornelio e tutta la sua
famiglia, che per primo venne convertito dalle parole di Pietro, fosse di origine
calabrese" ("Calabria Sconosciuta", a. XIII, n. 46, gennaio-marzo 1990, Erano
Bruzi di Reggio i soldati che crocifissero Gesù?, di Domenico Rotundo, pp. 29-34).
Cinque o sei cantori laici, tra i quali Pasquale, Battaglia
"Vàrvara" (nato il 23 maggio 1914), Andrea Bressi "Rizzo" (n. 1931),
Bruno Caporale "Capitano" (n. 1936), Vincenzo Carnuccio "Crijapòpoli"
(al tempo della floridezza del borgo, Bruno Battaglia "Mìnica 'a Rrea",
Francesco Cossari "Cciccu 'e Purdirhu", Giuseppe Procopio "Mutilatu",
e numerosi altri), dinanzi alla Madonna dell'Addolorata intonano coralmente e
lamentevolmente con animo angosciato e commosso, un antico repertorio di canti religiosi , epistemologicamente ispirati al gregoriano Alma Redemptoris Mater, allo
Stabet Mater di Jacopo de' Benedetti da Todi, al noto Laudario di Cortona
del secolo decimoterzo (Colangeli-Fraschetti, W Maria, Roma 1982, e C. Molinari Del
Chiaro, Canti popolari napoletani, Napoli 1985), e somiglianti nel contenuto al
canto U lamento, per quella invocazione iterativa "Figlio... Figlio...
Figlio", uguale a quella del mirabile Lamento della Madonna di Jacopone
("Che morte ha figlio e mate / in dura morte afferrate / trovasse abbracciate mate e
figlio ad un cruciato ... "), una Lauda dialogata il cui confronto coi drammi sacri
delle Confraternite mostra l'abisso intercedente tra la lirica personale e tutta interiore
di Jacopone e la letteratura popolareggiante dei Laudesi (le loro più
rinomate Compagnie erano, a Firenze, quelle di Orsanmichele, di Santo Spirito, di Santa
Maria del Carmine, della Santissima Annunziata, di Santa Reparata, di San Lorenzo, di
Sant'Egidio e di San Marco, su cui vedi proficuamente la deliberazione del Consilium
capitani et populi 1329, 30 marzo) .
Il passaggio della Madonna Addolorata, al cui seguito, nel secolo
decimonono, c'era tutto il clero parrocchiale, oggi ridotto a un solo Consigliere
Spirituale, suscita molto entusiasmo popolare: le persone anziane, segnatamente, escono
dalle file degli spettatori, assiepati ai lati delle strade, per fissarne da vicino il
volto pieno di serenità, bellissimo nella sua espressione dolce e dolente, simile a quello dell'Immacolata Concezione di Bartolomé Esteban Murillo
(1617-1682), scolaro di Francisco de Zurbaran (1597-1664), o della statua di Nostra
Signora della Concezione di Juan de Segura, custodite nella Sala Capitolare,
fabbricata nel 1530 da Riano e Ganza, e nella Sagrestia maggiore della Cattedrale di
Siviglia. Mi piace rammentare i versi del poema dedicato alla Vergine dal sivigliano
Miguel del Cid: "Tutto il mondo in generale / a gran voce, eletta Regina, / dica
che foste concepita / senza peccato originale". Avanti la Madonna
Addolorata, una banda musicale (per lo più quella di Guardavalle, che si
pregia di un repertorio che spazia dalle sinfonie alle opere, dalla rivista d'arte al
canzoniere antico e moderno, giacché la banda di "giro" di Badolato, la cui
prestazione era ridotta al semplice servizio processionale e a qualche modesta attività
concertistica, si sciolse un trentennio fa a seguito di difficoltà finanziarie e
organizzative, e per lo smembramento della formazione), con trombe, tromboni, oboe,
piatti e tamburi, accompagna la sfilata, interpretando inni e canti emotivi che toccano il
cuore. Su talune bande musicali, oltre che su quella di Radicena (venne a
Badolato tra il 1882 e il 1919, diretta dal Maestro Sorrento, concertatore, suonatore
d'organo e di pianoforte, menzionato dalla "Gazzetta di Messina e delle
Calabrie" del 26 agosto 1896, e dal Maestro Tommaso Ferrante, che esordì con la
banda Giovane Calabria, classificatasi seconda al Raduno Bandistico di Ferrara nel
luglio 1920), si vedano V. Alami, Breve storia dei complessi bandistici di Taurianova,
in "Questacittà", a. II, n. 5, novembre 1985, pp. 12-14, e ISMEZ, Le bande
musicali in Calabria 1800-1985, Reggio Calabria 1985, e anche G. Russo, Le bande
musicali di Radicena e Jatrinoli nell'Ottocento, in "Questacittà", a. III,
n. 14, ottobre-novembre 1987, pp. 8-9. Infine, chiudono la processione dei Misteri
Dolorosi innumerabili devoti, per lo più uomini e donne, le quali intonano le preghiere
contenute nelle Massime eterne (1931) e nei libricini di Sant'Alfonso de' Liquori
(1936), di San Leonardo da Porto Maurizio (1938), dei Padri Redentoristi (1946) e delle
Missioni (1948), sui quali vedi: Canti popolari della Settimana Santa, a cura delle
Confraternite unite di Badolato, ivi dicembre 1990, pp. 66 (cm 12,5x8,5).
Il gran corteo, immerso nei solenni suoni dei tamburi, e delle marce
processionali (la musica ha un ruolo di primo piano, ritma il procedere e crea
un'atmosfera patetica e trionfale insieme), si ferma circa ogni cento metri lungo il
percorso: al "Calvario" dell'Immacolata, ai Pezzi (vicino Mastro Giorgio
Saraco), alla curva del Girone, sopra il ponte Granele, alla prima "petta" della
petrosa salita (fu costruita, nel 1841, coi duecento ducati offerti dai
Francescani, e con l'obolo della popolazione) , a San Rocco, nella navata e nel
coro della Chiesa del Convento di Santa Maria degli Angeli (il Vescovo
Fabrizio Sirleto ne emanò il 30 luglio 1605 la
Bolla di fondazione, a seguito della supplica del Custode Provinciale, Padre Benedetto da
Gerace) , dove giunge dopo più di tre ore. I popolani svuotano, colà, le
damigiane col vino della Vite e del Paglìo, i canestri ricolmi di cuzzùpe
con le uova, e bevono la pura e fresca acqua di Pascasìa: i fanciulli sfilano
frementi la ciambella di pane appesa al braccio, ornata dalla mamma con un uovo o più, ma
in numero dispari, e bevono gioiosamente il vino contenuto nella bottiglietta.  Più tardi, la processione discende, s'arresta esattamente a metà del ponte
Granele: qui avviene, giusta l'antica consuetudine, la consegna (un tempo causa di
violente risse) della Madonna Addolorata ai membri della Confraternita di Santa Caterina (il colore rosso, come il sangue, del loro stendardo e dei loro rocchetti è
segnale di vita, ha il potere di scacciare il male, rinvia al richiamo sulla forza
simbolica del sangue implicito nel fatto che il vestito dell"'Ecce Homo" sia di
colore rosso) , insigne per la sua storia plurisecolare. Il corteo, nel continuare
a compiere il percorso obbligatorio, si ferma altre otto volte: poco dopo le due fontane
di Granele, alla Portella, nella Chiesa di Santa Caterina, presso il frantoio del
"Castellano", al Fosso, al palazzo Menniti, nella Chiesa del Convento Domenicano
(fondato nel 1558, previo consenso di D. Luca Pucci, Vicario Generale
della Diocesi Vacante di Squillace) per visitare i Santi Sepolcri (ornati di
piattellini di grano e d'orzo, di fresco seminati e spuntati per effimera germinazione),
avanti alla Chiesa della Santissima Annunziata, e termina, verso le otto, nella Matrice
Arcipretale, nella quale confluisce la folla per assistere alla celebrazione di un
servizio divino molto ricco. In Luca, 23, 44-46, leggiamo: Era già
quasi l'ora sesta quando ci fu tenebra su tutta la terra, fino all'ora nona, per essersi
eclissato il sole. Allora il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a
gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito". E, detto
questo, spirò. Più tardi, la processione discende, s'arresta esattamente a metà del ponte
Granele: qui avviene, giusta l'antica consuetudine, la consegna (un tempo causa di
violente risse) della Madonna Addolorata ai membri della Confraternita di Santa Caterina (il colore rosso, come il sangue, del loro stendardo e dei loro rocchetti è
segnale di vita, ha il potere di scacciare il male, rinvia al richiamo sulla forza
simbolica del sangue implicito nel fatto che il vestito dell"'Ecce Homo" sia di
colore rosso) , insigne per la sua storia plurisecolare. Il corteo, nel continuare
a compiere il percorso obbligatorio, si ferma altre otto volte: poco dopo le due fontane
di Granele, alla Portella, nella Chiesa di Santa Caterina, presso il frantoio del
"Castellano", al Fosso, al palazzo Menniti, nella Chiesa del Convento Domenicano
(fondato nel 1558, previo consenso di D. Luca Pucci, Vicario Generale
della Diocesi Vacante di Squillace) per visitare i Santi Sepolcri (ornati di
piattellini di grano e d'orzo, di fresco seminati e spuntati per effimera germinazione),
avanti alla Chiesa della Santissima Annunziata, e termina, verso le otto, nella Matrice
Arcipretale, nella quale confluisce la folla per assistere alla celebrazione di un
servizio divino molto ricco. In Luca, 23, 44-46, leggiamo: Era già
quasi l'ora sesta quando ci fu tenebra su tutta la terra, fino all'ora nona, per essersi
eclissato il sole. Allora il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a
gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito". E, detto
questo, spirò. |