Il giunto cardanico è uno dei sistemi atti a trasmettere il moto tra due alberi rotanti i cui assi sono inclinati tra di loro. Nella configurazione con due giunti, l’albero conduttore e quello condotto possono anche essere disassati.
Gli svantaggi connessi con la natura stessa del meccanismo non ne hanno impedito l'affermazione nell’autotrazione e persino nel più raffinato mondo motociclistico. E’ a quest’ultimo, in particolare alle moto BMW, che sono rivolte le note che seguono.
Il Paralever è un particolare schema di sospensione posteriore, se non erro brevetto BMW, la cui adozione sulle moto è resa possibile dal doppio giunto cardanico. Il Paralever è adottato ormai da tutte le moto BMW moderne con trazione ad albero.
Gli appunti che seguono non pretendono di esaurire la trattazione del giunto cardanico e delle sue applicazioni né, tantomeno, del Paralever. Lo scopo è di spiegare in modo semplice, ma non semplicistico, alcuni aspetti a mio avviso importanti dei due meccanismi e della loro applicazione in campo motociclistico. Nel caso in cui non fossi riuscito nell’intento, sarò ben lieto di ricevere suggerimenti.
Non sono voluto entrare nel merito di filosofie o scelte progettuali, che sono il risultato di lunghi studi e sperimentazioni finalizzati ad ottenere il miglior comportamento possibile della moto in base alla sua destinazione d’uso.
Nonostante le buone intenzioni, posso aver commesso degli errori. Sarò grato a chi me li vorrà segnalare.
Desidero infine scusarmi per la grossolanità di alcuni schizzi, ma la realizzazione di queste brevi note è stata, come già sottolineato, piuttosto "casereccia". L’importante è che siano comprensibili e con un po’ d'immaginazione...
3.1 Il giunto singolo
Il giunto cardanico consente di trasmettere il moto tra due alberi rotanti (un conduttore ed un condotto) i cui assi possono essere inclinati fra loro. Uno dei limiti di questo giunto è che in condizioni di funzionamento continuativo il massimo angolo ottenibile tra gli alberi è piuttosto ridotto (10-15 gradi). Istantaneamente, si possono però raggiungere anche i 30 gradi.
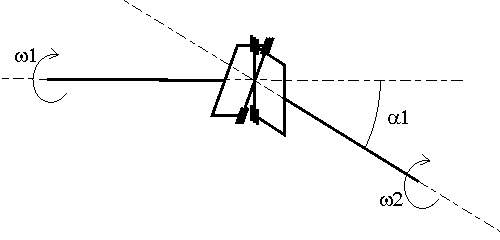
Un altro limite del giunto cardanico è che, fatta costante la velocità angolare
w1 dell’albero conduttore, la velocità angolare w2 dell’albero condotto è funzione dell’angolo a1 sotteso dagli assi dei due alberi e dell’angolo q1 di rotazione dell’albero conduttore.La relazione che lega
w1 ed w2 è la seguente:| w2 =w1*cos(a1)/(1-sen(a1)^2*sen(q1)^2) |
Si ha inoltre:
| w2 min = w1*cosa1 |
| w2 max = w1/cosa1 |
Nel grafico mostrato nel paragrafo successivo, è illustrato il variare di
w2 in funzione dell’angolo di rotazione q1 dell’albero conduttore, assumendo:w
1 = 60 g/m ovvero 6.2832 rad/sa1 =
10° ovvero 0.1745 rad
3.2 Il doppio giunto
Per ovviare ai due limiti del giunto cardanico, l’oscillazione della velocità angolare dell’albero condotto e il limitato angolo
a consentito, si ricorre spesso al doppio giunto.
Questa soluzione permette angoli maggiori tra gli alberi condotto e conduttore, il loro disassamento e, se sono soddisfatte le due condizioni che vedremo, una velocità costante dell’albero condotto. E’ facile dimostrare, infatti, che se i due angoli
a1 ed a2 sono uguali e se le forcelle che si trovano agli estremi dell’albero intermedio giacciono sullo stesso piano la velocità angolare w3 dell’albero condotto è, in ogni istante, uguale a quella w1 dell’albero conduttore.Il grafico seguente mostra come la velocità angolare
w3 dell’albero condotto sia costante, se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, e come varia la w2 dell’albero intermedio (o condotto nel caso di un giunto).
4.1 Giunto singolo
In campo motociclistico, il giunto cardanico ha trovato pronta applicazione nei casi in cui la scelta del tipo di trasmissione finale sia caduta su quella ad albero. Scelta che è praticamente obbligatoria quando si opti per una disposizione longitudinale del motore, come nel caso delle BMW e delle Moto Guzzi. Difficile, almeno per me, dire se sia venuta prima la scelta relativa al motore o quella relativa alla trasmissione. Probabilmente tutte e due le cose insieme. Considerando, infatti, che per le due marche citate si tratta di una soluzione le cui radici affondano nel tempo e che sia BMW che Guzzi hanno sempre puntato sul motociclismo a largo raggio e sull'affidabilità, il motore longitudinale e la trasmissione ad albero presentavano grossi vantaggi, specialmente alla luce dello sviluppo tecnico dell'epoca:
- migliore raffreddamento del motore
- migliore accessibilità meccanica
- frizione di tipo automobilistico, più robusta
- cambio separato con lubrificazione propria
- trasmissione finale robusta e con manutenzione ridotta
Gli svantaggi del giunto cardanico visti prima, variabilità della w2 e limitato angolo tra i due alberi, hanno alcuni effetti pratici:
- diminuzione del comfort di marcia (sulla mia R100RT, comunque, non me ne sono mai accorto: l’angolo è ridotto e l’escursione della sospensione è limitata)
- sollecitazioni sugli organi della trasmissione indotte dai momenti d’inerzia conseguenti la variabilità di w2
- il giunto singolo mal si presta ad essere adottato su moto che necessitano di un’ampia escursione della sospensione posteriore o che siano equipaggiate con sospensioni progressive.
I problemi, se di problemi si può parlare, sono ovviamente tanto più importanti quanto più a1 è grande. Tanto per divagare un pò, la variabilità della velocità angolare è tenuta molto in considerazione nel caso di veicoli pesanti e con angoli pronunciati, come può essere, ad esempio, un fuoristrada con sospensioni rialzate per affrontare particolari tipi di terreni.
C’è, infine, un curioso effetto dovuto all’accoppiamento pignone-corona. La forza esercitata dal pignone sulla corona può essere ricondotta ad un momento M
M (momento motore) attorno all’asse della ruota stessa. Ad MM corrisponde un momento di reazione MR uguale e contrario che viene trasmesso attraverso l’albero di trasmissione al complessivo scatola di trasmissione-forcellone, provocandone la rotazione attorno all’asse della ruota. Ad MR corrisponde una forza FR applicata dal forcellone al telaio che causa il sollevamento di quest’ultimo. In altre parole, il pignone tende ad "arrampicarsi" sulla corona facendo ruotare il forcellone attorno all’asse della ruota e, quindi, sollevando il posteriore della moto (vedi figura). Questo effetto è maggiormente avvertibile in accelerazione ed è diventato uno dei segni distintivi delle classiche (perdonatemi, non riesco a definirle vecchie) BMW 2V.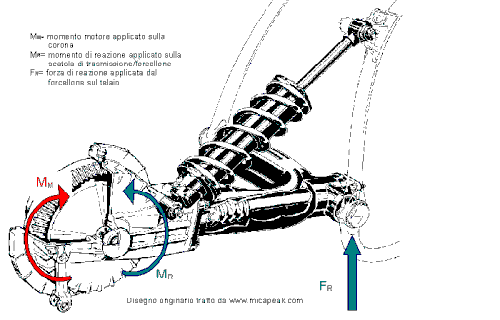
4.2 Doppio giunto
Abbiamo visto che, dal punto di vista puramente meccanico, l’adozione del doppio giunto consente di:
- ridurre o, sotto certe condizioni, eliminare totalmente la variabilità della velocità angolare dell’albero condotto rispetto a quella dell’albero conduttore;
- disallineare maggiormente gli alberi o addirittura disassarli.
Nell’applicazione pratica, però, dalle due caratteristiche appena viste derivano alcuni vantaggi tutt’altro che secondari e che nel processo di definizione del progetto di una motocicletta ritengo possano assumere carattere di "causa" e non di "effetto" della scelta di adottare il doppio giunto:
- maggiore escursione delle sospensioni
- maggiore libertà nel progettare la disposizione degli organi meccanica e della trasmissione in particolare
- possibilità di adottare per la sospensione posteriore delle geometrie altrimenti non realizzabili, allo scopo di rendere più omogeneo e sicuro il comportamento della moto. Ad esempio, il Paralever.
5.1 Cenni generali
Mi limiterò a fare qualche considerazione generale su questo meccanismo, con un piccolo approfondimento di un solo aspetto: l’effetto di arrampicamento del pignone sulla corona.
Fedele alle premesse fatte nel paragrafo 2, farò delle considerazioni qualitative piuttosto che quantitative. Infatti, non conoscendo le quote della sospensione realizzata dalla BMW e non disponendo di un programma di simulazione, sarebbe piuttosto complesso, oltreché presuntuoso da parte mia, cercare di sviscerarne il comportamento. Una trattazione di questo tipo, inoltre, andrebbe ben oltre gli scopi di queste note.
Lo schema Paralever altro non è che un quadrilatero articolato i cui membri minori sono costituiti uno dal telaio (o insieme telaio-motore) e l’altro (quello opposto) dalla scatola della trasmissione sulla ruota posteriore; il braccio superiore, che contiene l’albero di trasmissione, e quello inferiore sono invece i due membri maggiori (vedi disegno seguente).
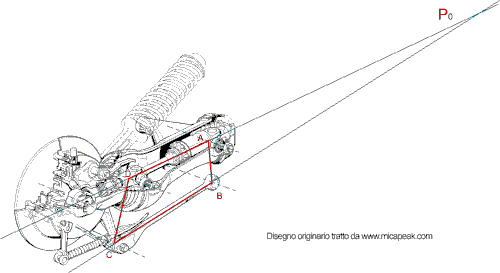
Il punto Po, intersezione del prolungamento dei due membri maggiori, rappresentati dal monobraccio e dall’asta del Paralever, è il centro d’istantanea rotazione (C.I.R.) della scatola della trasmissione. Da un punto di vista cinematico,  quindi, è come se la moto fosse dotata di un forcellone tradizionale di lunghezza pari ad E-Po. L'angolo tra il vettore della risultante delle forze applicate al complesso ruota-forcellone e la retta che unisce il punto di contatto ruota/suolo con C.I.R. determina la tendenza del forcellone ad "aprirsi" o a "chiudersi" in seguito all'applicazione del momento motore (vedi disegno accanto; www.caduser.com). Questa tendenza è particolarmente importante nei transitori: apertura o chiusura del gas, perdita e riacquisto di aderenza, ecc. Simulazioni effettuate con analisi di tipo Multi-body hanno evidenziato inoltre come lo spostamento in avanti del C.I.R. comporti una decisa riduzione della tendenza della moto ad impennare (vedi www.caduser.com, simulazione effettuata dalla Facoltà di Ingegneria Meccanica dell'Università di Padova).
quindi, è come se la moto fosse dotata di un forcellone tradizionale di lunghezza pari ad E-Po. L'angolo tra il vettore della risultante delle forze applicate al complesso ruota-forcellone e la retta che unisce il punto di contatto ruota/suolo con C.I.R. determina la tendenza del forcellone ad "aprirsi" o a "chiudersi" in seguito all'applicazione del momento motore (vedi disegno accanto; www.caduser.com). Questa tendenza è particolarmente importante nei transitori: apertura o chiusura del gas, perdita e riacquisto di aderenza, ecc. Simulazioni effettuate con analisi di tipo Multi-body hanno evidenziato inoltre come lo spostamento in avanti del C.I.R. comporti una decisa riduzione della tendenza della moto ad impennare (vedi www.caduser.com, simulazione effettuata dalla Facoltà di Ingegneria Meccanica dell'Università di Padova).
Un eccellente approfondimento di questo ed altri temi relativi al comportamento della moto può essere trovato all’indirizzo www.dinamoto.it.
Da notare che il C.I.R. si sposta a seconda dell’orientamento dei due membri maggiori e, quindi, della posizione relativa della ruota rispetto al telaio. Si comprende allora l’importanza che riveste il corretto dimensionamento degli elementi che compongono il quadrilatero, dato che questi determinano sia la legge con cui si muoverà la ruota rispetto al telaio che la posizione e la traiettoria del C.I.R. e, di conseguenza, l’assetto della moto. In realtà, parlare di corretto dimensionamento non è esatto: come tutte le cose, infatti, anche la scelta della geometria della sospensione è frutto, come già osservato, di quello che i progettisti, loro si con titolo per farlo, hanno individuato come miglior compromesso in base all’uso prevalente cui la moto è destinata. Il dimensionamento sarebbe senz’altro diverso se la moto fosse destinata alle competizioni in pista, ai tornanti dello Stelvio od alle gare di accelerazione. In effetti, ma non ne ho il riscontro, delle differenze dovrebbero notarsi, rimanendo in casa BMW, tra il GS, la S, la R e la RT.
Si comprende quindi come certe rappresentazioni grafiche che mostrano la risultante delle forze applicate alla ruota passare esattamente per il centro d’istantanea rotazione abbiano un valore puramente indicativo.
5.2 Un altro beneficio del Paralever
Credo sia interessante fare qualche riflessione sul comportamento del Paralever rispetto alla tendenza del pignone a risalire la corona.
Per isolare bene il fenomeno, nello schema raffigurato ho eliminato ammortizzatore e ruota, in modo da rendere il più chiaro possibile il comportamento del Paralever in seguito all’applicazione di un momento M. Il momento M è quello di reazione generato dall’azione della corona sul pignone.

Una volta "liberato" dall’ammortizzatore, il Paralever diventa una struttura reticolare caricata ai nodi (le cerniere che collegano i bracci superiore ed inferiore a telaio e scatola di trasmissione), i cui membri (i bracci superiore ed inferiore) sono sollecitati esclusivamente a trazione o a compressione. Le cerniere, infatti non possono trasmettere momenti. Questo significa che, come indicato nello schema, le reazioni del braccio superiore e della barra inferiore all’applicazione del momento M sono in asse con essi, ovvero passano per il C.I.R. Facendo l’equilibrio dei momenti rispetto al CI.R., si vede come il momento M non sia equilibrato da alcuna reazione del telaio: il complessivo della sospensione tende a muoversi.
A questo punto, possiamo "rimontare" l’ammortizzatore, che, chiamato in causa dal movimento della sospensione, ne frenerà la corsa introducendo nella reazione opposta dal braccio superiore una componente ortogonale al braccio stesso. Nel caso del forcellone tradizionale, invece, abbiamo visto come il momento M sia contrastato dalla reazione sul telaio (uguale ed opposta alla FR dello schema del par. 4.1) e dall'estensione dell'ammortizzatore.
Quello appena descritto è un altro importante vantaggio del Paralever, che è stato giustamente pubblicizzato dalla BMW: separare la funzione di trasmissione della potenza da quella di molleggiamento. La tendenza della sospensione a spostarsi a causa del momento M è tanto più limitata quanto minore è l’angolo tra il braccio superiore e la barra inferiore, ovvero quanto più lontano è il C.I.R. (di nuovo lui…).
Approfondimenti
Ulteriori approfondimenti sul comportamento dinamico della motocicletta possono essere trovati all'indirizzo: www.dinamoto.it