|
|
La
Baronia di Posada (1431-1869)
La segnalazione di errori,
imprecisioni, omissioni, commenti ci sara' davvero
gradita e volentieri vi leggeremo a questo recapito
di posta elettronica
LA BARONIA NEL
SETTECENTO
Mentre a Posada si seppelliva il Seicento,
senza del resto troppa consapevolezza di aver vissuto il
tempo barocco, Don Giuseppe Efisio Masones,
nipote di Giovanni Stefano, era il titolare del feudo e
nel Continente impazzava la guerra di successione
spagnola.
Contando di aver puntato sul cavallo giusto,
il nostro Barone si  schiero' dalla parte di Filippo
V di Spagna ed il riconoscente sovrano lo nomino'
infatti nel 1710 marchese dell'Isola
Rossa. schiero' dalla parte di Filippo
V di Spagna ed il riconoscente sovrano lo nomino'
infatti nel 1710 marchese dell'Isola
Rossa.
Purtroppo pero' le avverse fortune di Filippo V portarono
gli austriaci in Sardegna (1708) ed il
Masones, gia' ben compromesso, dovette riparare in Spagna
dove trovo' forse piu' soffice consolazione sposandosi
con una Lima Sotomayor, erede dell'omonimo
ducato.
La famiglia dei Masones si articolo' allora
di parentele intrecciate, sul feudo di Posada si
aggiunsero altri titoli accessori e il casato crebbe in
importanza, a livello sardo, nella fazione che sosteneva
Filippo V nelle sue rivendicazioni contro l'antagonista Carlo
III, arciduca d'Austria.
La Sardegna nobile o feudale si era infatti divisa in due
partiti.
E tra i filo-borbonici i Mazones si distinguevano per la
partecipazione di alcuni personaggi di questo casato,
tanto che la loro venne anche chiamata la "factione
de los Mazones": il conte di
Montalbo ed il duca di Sotomayor,
figlio di Giuseppe Masones, ne erano fra i piu' noti
esponenti.
Nel 1717 il cardinale Giulio
Alberoni, ministro di Filippo V, rioccupo' la
Sardegna forte anche dell'aiuto a distanza del Masones,
che continuava a risiedere nella piu' igienica Spagna.
E' facile immaginare che dalla rocca posadina molti
indigeni dovettero essere chiamati in armi, poiche' in
cio' consisteva appunto il lato pratico dell'appoggio
politico.
Successivamente con il trattato di Londra del
1718 il Regno di Sardegna venne ceduto ai duchi di Savoia,
principi di Piemonte.
E qui inizia una storia italiana che forse conosciamo
meglio.

I Piemontesi, nella persona di Vittorio
Amedeo II, barattavano in quella occasione il
Regno di Sicilia acquisito col trattato di
Utrecht nel 1713, a seguito
delle paci di Londra e dell'Aja del 1720,
e decidevano di dare finalmente corpo all'invenzione
diplomatica del Papa Bonifacio VIII, rendendo concreto
quel Regnum Sardiniae che mai era stato vivo, ma
non si sprecarono a dare immediata attenzione a questa
scomoda "pertinenza" (che pero' valeva bene per
loro, duchi, la dignita' ed il trono di Regno), anzi 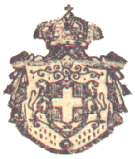 passarono anni prima che si
decidessero a inviare almeno dei ricognitori per fare...
l'inventario del magazzino. passarono anni prima che si
decidessero a inviare almeno dei ricognitori per fare...
l'inventario del magazzino.
L'accoglienza di questi nuovi padroni, del
tutto ignoti, non deve poi essere stata delle piu'
calorose. I pochi resoconti degli "esploratori"
dell'epoca sono infatti costantemente venati di un
accidioso e snobistico disprezzo che rende difficile
valutare con precisione l'effettiva condizione dei luoghi,
che pure di lati negativi avrebbero dovuto mostrarne per
loro conto.
Del resto i Piemontesi fecero di tutto per farsi
benvolere: le prime riforme al sistema amministrativo
dell'Isola demolirono una dopo l'altra tutte le
costituite autonomie, a partire da quelle del Vicere',
ridotto a mero esecutore delle direttive di un apposito
ministero creato ad hoc.
I Sardi, sennores e vassallos, subito
si mostrarono proporzionalmente entusiasti di tanta
fiducia.
I rapporti con i nuovi venuti sicuramente ne risentirono.
In tutta l'Isola nobilta' e clero
osteggiarono la nuova dominazione sin quando nel 1726
l'astuto cardinale di Seneghe, Agostino Pipia,
ispiro' un concordato col Papa che fece affievolire le
nostalgie spagnole; il rimpianto per il precedente regime
non fu mai in realta' completamente sopito.
Va detto che i Savoia effettivamente condussero regie
politiche di indiscussa modernita' ed illuminata
avanguardia, ma le riforme altrove applicate, fra le
quali l'editto
della perequazione (mediante il quale si acquisivano al
Demanio dello Stato i beni illegalmente detenuti dagli
ecclesiastici e dai nobili), furono del tutto ignorate in
Sardegna.
Carlo Emanuele III successe
al padre Vittorio Amedeo (del quale in zona si ricordo'
la privatizzazione delle miniere, fra le quali le pur
esigue miniere d'oro di Torpe') e doto' l'Isola di un
servizio di collegamento con la terraferma, oltre a
dotare le coste di una squadriglia di fregate, di cui una
o forse due di pattuglia al largo di Posada, per
contrastare le non eliminate scorrerie piratesche.
 Il noto vicere' Marchese di
Rivarolo, fra il 1735 ed il 1738,
volendo contrastare l'incresciosa piaga del banditismo,
impose tre anni di pressione poliziesca che fra l'altro
proibi' ai Sardi di portare la tradizionale lunga barba,
provocando risentimenti di pesantissima portata. Il noto vicere' Marchese di
Rivarolo, fra il 1735 ed il 1738,
volendo contrastare l'incresciosa piaga del banditismo,
impose tre anni di pressione poliziesca che fra l'altro
proibi' ai Sardi di portare la tradizionale lunga barba,
provocando risentimenti di pesantissima portata.
Inoltre incoraggio' il massiccio ricorso al guidatico,
un istituto giuridico spagnolo che garantiva l'immunita'
a chi avesse consegnato alle autorita' un bandito: le
delazioni vi furono, ma ovviamente risultavano
estremamente pericolose nelle comunita' dei villaggi,
dove infatti tra sospetti ed effettivi "tradimenti"
nacquero le prime faide.
"Divide et impera".
La considerazione dell'Isola sviluppata dai
primi savoiardi era decisamente negativa. Anche se le
analisi effettuate erano vergognosamente superficiali.
Le conseguenze di queste considerazioni furono, per
logico effetto, estremamente perniciose.
Leggiamo infatti dallo stesso Marchese di Rivarolo che i
delinquenti della Gallura e del Bittese "per
avversione alla coltura della terra si affezionano alla
vita errabonda del pastore, dell'ozio con la complicita'
della campagna originano furti, inimicizie, vendette".
Certamente, pare declamare il Rivarolo, il fatto che la
terra sia proprieta' comune e dunque vi sia incertezza
della proprieta', causa la delinquenza. Ergo, stabilire
forzosamente o normativamente la proprieta' della terra (come
poi avvenne con l'Editto delle Chiudende),
eliminera' la delinquenza.
 Ma la fraintesa questione della gestione
della terra, nell'uso millenario che si era sviluppato in
Sardegna, non era cosi' semplice da liquidare, ne' per
editto, ne' tantomeno a livello di concezione economica. Ma la fraintesa questione della gestione
della terra, nell'uso millenario che si era sviluppato in
Sardegna, non era cosi' semplice da liquidare, ne' per
editto, ne' tantomeno a livello di concezione economica.
Non e' oggetto di queste pagine, ma sintetizzeremo che l'uso
sardo coinvolgeva tutta la popolazione nella gestione dei
terreni, che si alternavano per annate a vidazzone
e paberile (presto ne parleremo qui ad
Ottiolu.net). Forse ci voleva qualche mente meno leggera
per analizzare la questione e proporre soluzioni.
Erano, e' vero, tempi nei quali non si
poneva una grande pazienza ne' un accurato scrupolo nell'analizzare
i fenomeni sociali, soprattutto per zone, come l'Isola,
di non primaria importanza; collateralmente, nella
mentalita' prevalente si preparava la strada al successo
di teorie criminologiche come quelle niceforiane o
lombrosiane, basate su collegamenti etico-somatici.
La pure troppo facile equazione, pastore=criminale,
come sappiamo non e' piu' tramontata, ed anche oggi
offende la categoria.
Cio' che riesce difficile escludere e' che potessero
esservi, nell'elaborazione dei giudizi espressi da parte
dei funzionari sabaudi, interessi vergognosamente
personalistici e irrisori (non ultimo il disagio del
viaggio) capaci di provocare ai sardi disagio e lutti per
l'unta comodita' dei burocrati. Come vedremo piu' avanti,
Mazzini ne parlera' con cruda vivezza.
Nel 1737, comunque, il
primo vicere' sabaudo venne in visita nell'Isola, ben 17
anni dopo la sua acquisizione.
Una relazione del 1746,
dell'intendente savoiardo De Viry,
descrive la Baronia di Posada come ancora infeudata a don
Felice Masones, gia' ormai del tutto madrileno,
e formata da "quattro miserabili villaggi";
Posada aveva, secondo questo scritto, un "pessimo
porto".
Nella relazione troviamo pero' notizia dell'avvenuto
ripopolamento di Torpe'.
Delle poche notizie che si hanno sulla
Baronia del Settecento, si sa che nel 1752
Anna Maria Masones va in sposa ad un tal
Nin Zatrillas presunto conte di
Castillo; alla morte di Anna Maria, il figlio don
Ignazio divenne Conte di Posada e duca
di Sotomayor.
Le definizioni nobiliari oscillano, come si vede, con
costante spirito di innovazione; naturalmente cio' si
deve anche all'autonomia familiare nella creazione di
titoli e giurisdizioni accessorie.
Nel 1760 la nota relazione
dell'Intendente generale Bogino (o
Bongino), appena da un anno insediato al Ministero per
gli Affari della Sardegna, indica le spiagge di Posada e
Siniscola come luoghi infestati da un invincibile
contrabbando marinaro. Il problema deve avere avuto una
rilevanza non secondaria se molto lavoro di burocrazia
venne compiuto per contrastare il fenomeno.
Ce ne restano relazioni e rapporti militari che spesso
alludono (a leggerli con malizia odierna) ad una diffusa
connivenza popolare e ad un'altrettanto festosa
corruttela.
Dieci anni piu' tardi la visita al feudo del vicere' Vittorio
Lodovico d'Hallot Des Hayes venne annullata all'ultimo
momento per ragioni ignote, quando la delegazione era gia'
giunta sino a Dorgali. Alcuni parlarono del timore di
inoltrarsi in una zona non sufficientemente sicura, altri
pensarono ad un piu' pratico interesse a non affrontare
un problema di gestione politica e sociale che una volta
in loco non avrebbe potuto facilmente essere scansato.
Per tornare ai fatti, da questi mari infidi
ed ormai fuori del controllo governativo, fra il 1762
e il 1765 si ebbero sanguinosi assalti
pirateschi. Per la maggior parte respinti, provocarono
comunque perdite e danni.
Venne dunque un periodo di calma relativa. Poi, nel 1788
approdarono al porto de La Caletta alcune imbarcazioni di
corallari, che furono sospettate di potenziale contagio
di malattie epidemiche (peste?) e poste in quarantena.
Il provvedimento pero' non era stato tempestivo e qualche
contatto con la popolazione poteva aver avuto luogo. L'intera
Baronia fu percio' posta sotto isolamento, cosa che
certamente consentiva anche di rendere piu' difficoltoso
il traffico dei contrabbandieri, e sebbene sia stato un
secolo davvero intenso per l'Isola, questa e' fra le
ultime notizie di cronaca che riguardano la Baronia del
Settecento.

SEGUE
sponsor

|
|
|
|
|
Gianfranco
Buttu per

|
|
