
 |
L'Età Antica |
Come molte città etrusche, Monterano fu costruita alla sommità di un'altura, difesa in maniera straordinaria e inespugnabile. I pendii sono alti circa cento metri, sono ripidissimi e talora a picco sul fondovalle, rendendo estremamente difficoltoso l'accesso alla sommità. L'opera degli etruschi ha reso, nel corso dei secoli, l'abitato ancora più difendibile attraverso, tra le altre cose, strade scavate nel tufo, assai facilmente controllabili, e opere murarie a complemento essenziale di quanto fornito naturalmente dalla morfologia del luogo. Le genti che verosimilmente popolavano la campagna e le valli monteranesi trovarono nel pianoro il luogo ideale dove concentrarsi per fondere il più munito agglomerato urbano della zona.
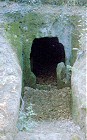 L'aspetto
esteriore, la struttura e i monumenti di Monterano etrusca sono quasi del tutto
sconosciuti per la mancanza di ricerche archeologiche sistematiche, per la deperibilità
del materiale usato nelle costruzioni e per la sovrapposizione nello stesso
luogo di insediamenti successivi. Le tecniche edilizie etrusche non hanno
permesso di lasciare resti consistenti nel corso dei secoli, poiché per
le abitazioni e i templi venivano impiegati legno e argilla, mentre
la pietra era usata solo per le cinte murarie, le porte e le tombe.
L'aspetto
esteriore, la struttura e i monumenti di Monterano etrusca sono quasi del tutto
sconosciuti per la mancanza di ricerche archeologiche sistematiche, per la deperibilità
del materiale usato nelle costruzioni e per la sovrapposizione nello stesso
luogo di insediamenti successivi. Le tecniche edilizie etrusche non hanno
permesso di lasciare resti consistenti nel corso dei secoli, poiché per
le abitazioni e i templi venivano impiegati legno e argilla, mentre
la pietra era usata solo per le cinte murarie, le porte e le tombe.
Allo stato attuale, dunque, l'aspetto della città etrusca può
essere solo immaginato, facendo riferimento alle conoscenze generali su questa
civiltà. Gli edifici di abitazione dovevano essere bassi e affiancati,
poggiavano sulla roccia viva o su fondamenta di pietra. Le pareti erano costruite
in mattoni crudi o con intelaiature di pali, canne e rami ricoperti da strati
di argilla. Il focolare era addossato al muro o al centro della stanza.
Nel pianoro non esistevano sorgenti, l'acqua era trasportata con un ingegnoso
acquedotto dall'altopiano di Oriolo e conservata in cisterne scavate
nella roccia.
 Appena fuori dall'abitato si iniziava a estendere la vasta necropoli,
che rappresenta ciò che di più significativo rimane dell'insediamento
etrusco. Le tombe più antiche sono quelle più prossime all'abitato,
mentre quelle del periodo medio, coincidente con la massima prosperità,
sono quelle più lontane. Infine le tombe dell'ultimo periodo etrusco
si trovano nuovamente nelle vicinanze del perimetro urbano.
Appena fuori dall'abitato si iniziava a estendere la vasta necropoli,
che rappresenta ciò che di più significativo rimane dell'insediamento
etrusco. Le tombe più antiche sono quelle più prossime all'abitato,
mentre quelle del periodo medio, coincidente con la massima prosperità,
sono quelle più lontane. Infine le tombe dell'ultimo periodo etrusco
si trovano nuovamente nelle vicinanze del perimetro urbano.
Sull'altopiano della Palombara si scorgono i resti di una seconda serie
di tombe che iniziando dallo stesso pianoro monteranese seguono il tracciato
di un'antica via etrusca e arrivano fino alla località Pozzo Tufo.
La necropoli più ricca, tuttavia, è quella che si estende sul
colle della Bandita. Alle due tombe più conosciute, utilizzate
nei secoli da pastori e agricoltori quale rifugio, è stato dato dalla
tradizione popolare il nome Grottino della Bandita e Grotta di Tabacco.
Per
raggiungere le rovine di Monterano attualmente occorre percorrere sentieri impervi,
ma la situazione era ben diversa nel periodo etrusco, quando una fitta rete
viaria carrabile collegava il fiorente abitato con altre città e con
le campagne circostanti. La strada più importante era diretta a Caere,
l'attuale Cerveteri, capoluogo della regione. Appena fuori dell'abitato la via
scendeva per il Cavone, in una gola scavata nella roccia, fino alla valle
del Bicione. Superato il torrente, risaliva il colle della Madonella
nella strettoia del Canalicchio e, dopo aver attraversato per una ventina
di chilometri gli attuali territori di Manziana e Castel Giuliano,
giungeva a destinazione.
Una seconda strada si dirigeva verso un'altra grande metropoli dell'Etruria,
Tarquinia. Scendeva il colle scavata nel tufo e attraversava il torrente
Mignone con un ponte di legno, non molto dissimile da quello usato qualche
decennio fa, e proseguiva poi sulla riva destra del torrente in direzione della
città.
 Si
può tentare una descrizione della vita economica e sociale
della Monterano etrusca in base alla storiografia antica e alle pubblicazioni
sulle scoperte archeologiche locali.
Si
può tentare una descrizione della vita economica e sociale
della Monterano etrusca in base alla storiografia antica e alle pubblicazioni
sulle scoperte archeologiche locali.
Le principali risorse economiche della città erano legate alla produzione
agricola (frumento, vino, olio), all'allevamento, al taglio dei
boschi e allo sfruttamento delle risorse minerarie (ferro). Non doveva
mancare una certa attività artigianale, come la lavorazione dei
metalli, del legno, del cuoio, della ceramica nonché la tessitura della
lana. Di tali prodotti si faceva un significativo commercio, in prevalenza con
Caere, la città egemone alla quale Monterano rimase legata sia nell'espansione,
sia nella decadenza.
Il miglioramento dell'agricoltura e dell'artigianato, rispetto ai precedenti
insediamenti primitivi, introdussero una maggiore divisione del lavoro che accentuò
le differenze sociali. L'adozione della scrittura, appannaggio di pochi,
e l'organizzazione religiosa costituirono due potenti strumenti di controllo
sulle classi più deboli: la ricchezza andò concentrandosi in poche
mani, e gli aristocratici, in cambio di protezione, dominavano sui ceti medi
e inferiori, mentre i servi e gli schiavi erano praticamente privi di diritti
civili. Dopo la conquista, i Romani cancellarono rapidamente la struttura
sociale etrusca sostituendola con la loro, meno rigida, dove trovavano spazio
i ceti intermedi dei ricchi artigiani e commercianti.
Il territorio di Stigliano è particolarmente ricco di memorie
archeologiche, fin dai tempi della preistoria. Gli Etruschi vi fondarono un
villaggio, come testimoniano le necropoli e gli oggetti antichi ivi ritrovati.
L'abitato etrusco, localizzato probabilmente nel bosco a nord dell'attuale stabilimento
termale, era sorto in corrispondenza della via di comunicazione che congiungeva
Caere a Tarquinia attraverso Castel Giuliano, le Pietrische e la media
valle del Mignone.
La presenza delle acque salutari e la passione dei Romani per le terme
salvarono Stigliano dalla decadenza in cui erano precipitati i centri etruschi
dell'entroterra dopo la conquista romana. Mentre Monterano si andava spopolando,
Stigliano entrava nel periodo più felice della sua storia. La fioritura
economica e culturale del centro romano è testimoniata principalmente
dai resti di una strada selciata, la Selciatella, e dai ruderi delle
terme e del tempio, dedicati al dio Apollo, guaritore delle malattie.
Il nome del villaggio romano era infatti Acquae Apollinares.
La Selciatella collegava le terme di Stigliano con l'importante via Clodia. Lungo questa antichissima strada, colpiscono i resti di un'imponente opera di edilizia stradale, che permetteva all Selciatella di attraversare un fosso e la relativa valle, il Ponte del Diavolo. Il viadotto è lungo circa 90 metri, largo 6 e alto 9 e supera il fosso con un'unica arcata, la cui luce è di quasi 7 metri. E' costruito in grandi blocchi di peperino che raggiungono fino a 2 metri di lunghezza, incastrati tra loro a secco senza malta di collegamento. La datazione del monumento non è conosciuta. Con ogni probabilità, da un primo esame delle tecniche di costruzione che rivelano tra l'altro chiare influenze etrusche, il ponte risale alla fine del periodo repubblicano, nel I secolo a.C.
Dopo la conquista i Romani organizzarono il territorio dello Stato di Caere secondo gli interessi politici, economici e commerciali di Roma. La regione dei monti Sabatini fu interessata da una nuova corrente di traffico che seguiva il tracciato della via Clodia, la strada che collegava Roma con il lago di Bracciano e passava per gli attuali teritori di Manziana e di Oriolo. Il territorio monteranese, tagliato fuori dalla nuova strada, rimase legato alla rete viaria romana solo in parte, attraverso la Selciatella che raggiungeva le terme di Stigliano. A partire dal II secolo a.C., la regione fu oggetto di un'intensa colonizzazione romana. Col crescere degli insediamenti fu avvertita l'esigenza di fornire di un centro urbano adeguatamente attrezzato i piccoli villaggi rurali e i casali sparsi nella campagna. Prese così importanza l'abitato sorto lungo la via Clodia verso la collina di San Liberato, sul lago di Bracciano, cui venne dato il nome di Forum Clodii.
tratto da "Monterano - Appunti sul territorio e la storia" di Francesco Stefani
 |
Associazione Pro Loco Canale
Monterano E-mail: proloco@monterano.it Sito a carattere non periodico realizzato e curato dall'Atlantis Group |