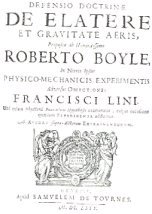 Boyle Robert (Lismore, Irlanda 1627 - Londra 1691). Chimico, fisico e filosofo irlandese, educato ad Eton, completo la sua formazione con viaggi in Francia, in Svizzera ed in Italia dove conobbe le opere del Galilei. Nel 1644 rientro in Inghilterra, avendo ereditato dalla madre il castello di Staibridge nel Dorset e si dedico completamente agli studi. In Inghilterra si occupò di chimica, ma durante un soggiorno in Irlanda (1652-53) prese ad interessarsi anche di anatomia. Nel 1654 creava ad Oxford un laboratorio intorno al quale raccolse una piccola società scientifica. Assistito da Robert Hooke costruì una pompa pneumatica che gli permise di effettuare sperimenti sui gas. Intanto in un suo scritto, fondamentale per la nascita della moderna chimica, attaccava la teoria aristotelica dei quattro elementi e affermava la concezione atomistica della materia. In altri scritti e relazioni espose varie scoperte, frutto delle sue ricerche di laboratorio, come la preparazione dell'idrogeno e del fosforo, la costruzione di termometri ermetici, l'uso di misture congelanti, ecc. Un'edizione completa delle sue opere venne pubilicata nel 1744.
Boyle Robert (Lismore, Irlanda 1627 - Londra 1691). Chimico, fisico e filosofo irlandese, educato ad Eton, completo la sua formazione con viaggi in Francia, in Svizzera ed in Italia dove conobbe le opere del Galilei. Nel 1644 rientro in Inghilterra, avendo ereditato dalla madre il castello di Staibridge nel Dorset e si dedico completamente agli studi. In Inghilterra si occupò di chimica, ma durante un soggiorno in Irlanda (1652-53) prese ad interessarsi anche di anatomia. Nel 1654 creava ad Oxford un laboratorio intorno al quale raccolse una piccola società scientifica. Assistito da Robert Hooke costruì una pompa pneumatica che gli permise di effettuare sperimenti sui gas. Intanto in un suo scritto, fondamentale per la nascita della moderna chimica, attaccava la teoria aristotelica dei quattro elementi e affermava la concezione atomistica della materia. In altri scritti e relazioni espose varie scoperte, frutto delle sue ricerche di laboratorio, come la preparazione dell'idrogeno e del fosforo, la costruzione di termometri ermetici, l'uso di misture congelanti, ecc. Un'edizione completa delle sue opere venne pubilicata nel 1744. Carnot Nicolas-Leonard-Sadi (Parigi 1796-1832). Fisico francese.
Figlio di Lazare-Nicolas, il « gran Carnot », fu studente all'École
Polytechnique e alla scuola d'applicazione di Metz, quindi
seguì la carriera militare che interruppe per dedicarsi completamente
alla scienza. La sua opera fondamentale è Riflessioni sulla potenza
motrice del fuoco e sulle macchine atte a sviluppare tale potenza,
una breve relazione data alle stampe nel 1824, che gli procurò celebrità
internazionale e lo pone tra gli iniziatori della moderna termodinamica.
Fino ad allora i problemi connessi all'energia erano stati
trattati in modo confuso e contraddittorio. C. ne diede invece le
prime enunciazioni chiave. Nelle Riflessioni egli elabora il principio
secondo cui, ogni qualvolta si ha una differenza di temperatura, si
può avere una produzione di energia, la cui quantità è determinata
dalle differenze di temperatura dei corpi fra i quali avviene il trasporto
di calore, inteso da C. come forma di movimento. Vi enuncia quindi i due
famosi principi per il calcolo del lavoro compiuto da una macchina termica.
Carnot Nicolas-Leonard-Sadi (Parigi 1796-1832). Fisico francese.
Figlio di Lazare-Nicolas, il « gran Carnot », fu studente all'École
Polytechnique e alla scuola d'applicazione di Metz, quindi
seguì la carriera militare che interruppe per dedicarsi completamente
alla scienza. La sua opera fondamentale è Riflessioni sulla potenza
motrice del fuoco e sulle macchine atte a sviluppare tale potenza,
una breve relazione data alle stampe nel 1824, che gli procurò celebrità
internazionale e lo pone tra gli iniziatori della moderna termodinamica.
Fino ad allora i problemi connessi all'energia erano stati
trattati in modo confuso e contraddittorio. C. ne diede invece le
prime enunciazioni chiave. Nelle Riflessioni egli elabora il principio
secondo cui, ogni qualvolta si ha una differenza di temperatura, si
può avere una produzione di energia, la cui quantità è determinata
dalle differenze di temperatura dei corpi fra i quali avviene il trasporto
di calore, inteso da C. come forma di movimento. Vi enuncia quindi i due
famosi principi per il calcolo del lavoro compiuto da una macchina termica.Charles Jacques-Alexandre-César (Beaugency, Orléans 1746 -Parigi 1823). Pioniere francese dell'aeronautica, ideatore del pallone aerostatico di tipo moderno a involucro impermeabile, gonfiamento a idrogeno, valvola superiore e inferiore e zavorra. Docente di fisica alla Sorbona, applicò all'aerostato strumenti per lo studio dell'atmosfera. Nel 1783 toccò i 3000 m di quota. Eseguì inoltre ricerche sulla dilatazione termica dei gas.
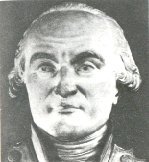 Coulomb Charles-Augustm, de (Angouléme 1736 - Parigi 1806).
Scienziato francese. Compì ricerche sul magnetismo e sull'elettricità
e inventò uno strumento per misurare la forza dell'attrazione
magnetica e elettrica. Da C. ha preso il nome l'unità pratica della
quantità di energia elettrica. La sua maggiore opera è Théorie des
machines simples, premiata all'Accademia di Francia nel 1779.
Coulomb Charles-Augustm, de (Angouléme 1736 - Parigi 1806).
Scienziato francese. Compì ricerche sul magnetismo e sull'elettricità
e inventò uno strumento per misurare la forza dell'attrazione
magnetica e elettrica. Da C. ha preso il nome l'unità pratica della
quantità di energia elettrica. La sua maggiore opera è Théorie des
machines simples, premiata all'Accademia di Francia nel 1779.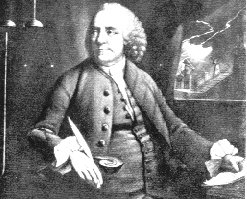 Franklin Benjamin (Boston 1706 - Filadelfia 1790). Statista, editore,
inventore, scrittore, diplomatico, filosofo e uomo di scienza
nord-americano. Nato nella Nuova Inghilterra puritana da genitori
credenti, lavorò alle dipendenze del fratello per il giornale radicale
« New England Courant ». Nello stesso tempo, oltre ai tradizionali
Essays to do good di Cotton Mather, leggeva Locke, Bunyan, Plutarco,
Addison, Defoe. A 17 anni partì per Filadelfia, dove lavorò
come tipografo. .Col tempo si mise in proprio, allargando pazientemente
la sua attività. Nel 1748, quando si ritirò cedendo la tipografia
ad un suo socio, oltre ad aver aperto una libreria (come facevano
molti tipografi dell'epoca) aveva anche fondato un'accademia
scientifica (che divenne l'università di Pennsylvania), una biblioteca
pubblica, una società interna'/ionale scientifica e un corpo di polizia
comunale.
Franklin Benjamin (Boston 1706 - Filadelfia 1790). Statista, editore,
inventore, scrittore, diplomatico, filosofo e uomo di scienza
nord-americano. Nato nella Nuova Inghilterra puritana da genitori
credenti, lavorò alle dipendenze del fratello per il giornale radicale
« New England Courant ». Nello stesso tempo, oltre ai tradizionali
Essays to do good di Cotton Mather, leggeva Locke, Bunyan, Plutarco,
Addison, Defoe. A 17 anni partì per Filadelfia, dove lavorò
come tipografo. .Col tempo si mise in proprio, allargando pazientemente
la sua attività. Nel 1748, quando si ritirò cedendo la tipografia
ad un suo socio, oltre ad aver aperto una libreria (come facevano
molti tipografi dell'epoca) aveva anche fondato un'accademia
scientifica (che divenne l'università di Pennsylvania), una biblioteca
pubblica, una società interna'/ionale scientifica e un corpo di polizia
comunale.I suoi studi ed esperimenti scientifici (è noto l'episodio dell'aquilone nel mezzo del temporale) gli permisero di fare importanti scoperte e invenzioni: la stufa F., il parafulmine, il caminetto antifumo, le lenti bifocali, ecc. Oltre ai suoi trattati scientifici, anche le sue satire sulla politica colonialista britannica, paragonabili a quelle di Swift o Voltaire, furono lette e applaudite sia in America che in Europa. Era in comunicazione epistolare con gli uomini più importanti e più noti dell'epoca come Lord Kames, Joseph Priestley e David Hartiey. Nello stesso tempo lavorava anche come statista. Il suo cosiddetto i Patto di unione » di Albany (1754), sebbene non venisse accettato dalle colonie, gettò la base per la futura federazione. Nel 1755-56 aiutò a organizzare la difesa della frontiera della Pennsylvania. Nel 1757 andò a Londra per presentare le lamentele delle colonie per la lunga questione delle tasse. Fu in parte merito suo se l'odiato «: Stamp Act » venne abrogato nel 1766. Nel 1770 discusse davanti alla Camera a Londra le questioni che dividevano le colonie dalla Corona, ma le divergenze non erano tali da essere sanate colle parole, nemmeno quelle ponderate del saggio F. Il 4 luglio 1776 la Dichiarazione dell'Indipendenza, alla cui redazione contribuì largamente F., affermò di fronte al mondò quello che solo 5 anni di lotta armata avrebbero potuto tramutare in realtà. Nello stesso anno F. fu mandato a Parigi come primo diplomatico americano ad una corte straniera, e si diede a raccogliere con grande successo dalla nobiltà francese i fondi necessari per finanziare la disperata guerra di Indipendenza. Ma non era tanto come statista che F. fu accolto e riconosciuto dall'Europa quanto come filosofo e scienziato. Era probabilmente l'uomo più conosciuto della sua epoca. Apparteneva a tutte le più note società di cultura europee. Tré edizioni delle sue opere erano già state pubblicate a Parigi. Ovunque si vendeva il suo ritratto, nonché medaglioni e busti con la sua immagine. Nel 1778, a guerra conclusa, firmò per gli Stati Uniti un trattato di alleanza e uno di amicizia e commercio colla Francia. In seguito ottenne dei prestiti e stipulò trattati commerciali colla Prussia e la Svezia.
L'autobiografia di F., pur incompiuta com'è, resta un capolavoro del suo genere. Si può essere in certa misura d'accordo con D. H. Lawrence quando critica la compiaciuta falsità pseudo-moralistica con cui F. elenca schematicamente le virtù (frugalità, industria, sincerità, castità, igiene personale, ecc.) dandosi un voto settimanale accanto a ciascuna col proposito di diventare in tal modo entro breve tempo un uomo perfetto o quasi; però bisogna tener presente che il vecchio F. ricordando quelle cose rideva lui stesso mentre le scriveva.
Nella personalità di F. due ideologie, il puritanesimo e il deismo razionalistico, apparentemente contrastanti, trovano una sintesi pratica. Poiché Dio per lui non è altro che il principio scientifico che governa il mondo, egli cerca la punizione o premiazione dell'uomo sulla terra, non nell'aldilà. F. segna un momento di transizione dalla vecchia mentalità puritana, colla sua enfasi sulla virtù, alla mentalità capitalista del XX sec., che considera la ricchezza fine a se stessa e 1'apparenza della virtù importante quale « immagine pubblica ». Bisogna però dire che F. pur nel suo pragmatismo ebbe una visione ottimistica del mondo, fatta soprattutto di speranza e di umana simpatia.
Gay-Lussac Louis (St. Léonard, Haute-Vienne 1778 - Parigi 1850). Allievo e poi assistente di Berthollet all'École Polytechnique, dove successivamente insegnò, fu in seguito professore di chimica generale al Jardin des plantes di Parigi. Nel 1804 compì insieme con il Biot un'ascensione in pallone, durante la quale raggiunse i 6000 m, per accertare se il magnetismo terrestre cessava allontanandosi dalla superficie della Terra. In una seconda ascensione compiuta da solo potè osservare la regolare diminuzione della pressione e della temperatura e il grado di umidità. Nel 1804 in esperimenti svolti in collaborazione con Humboldt fece la scoperta fondamentale della composizione dell'acqua (ossigeno e idrogeno nella misura di 1:2). Nel 1808, nello scritto Mémoires sur la combination des substances gazeuses entre elles pubblicato nei « Mémoires de la Société d'Arcuei! », riportava la sua legge sui volumi dei gas che ebbe enorme importanza per lo sviluppo della teoria atomica. Nel 1811 col Thénard studiò la preparazione del potassio, nel 1813 pubblicò una nota sullo iodio, scoperto da Courtois, e nel 1824 scoprì l'acido fulminico. In vita G.-Lussac pubblicò Recherches physicochimiques sur la pile, sur les alcoois, sur les acides, sur l'analyse vegetale et animale, ecc., 1811), mentre postume uscirono le letture dei corsi tenuti nel 1827 e nel 1828. Leggi di Gay-Lussac: Si tratta di due leggi che regolano il variare della pressione e del volume di un gas (alcuni testi danno la paternità ad una di queste due leggi a [v.] Charles Jacques-Alexandre-César). quando si fa variare la temperatura dello stesso. La prima legge afferma che, a volume costante, la pressione di un gas varia con il variare della temperatura di 1/273 del valore iniziale per ogni grado di variazione della temperatura; la seconda da la stessa variazione per il volume con il variare della temperatura, mantenendo costante la pressione.
Gilbert William (Colchester ca. 1540 - Londra 1603). Scienziato inglese. Esercitò l'arte medica a Londra e alla corte di Elisabetta. Fu tra i primi studiosi del magnetismo, che compendiò in De magnete magneticisque corporibus et de magno magnete tellure, Physiologia nova (1600), opera nella quale definì per primo l'asse magnetico di un magnete ed espose tutti i principali fenomeni della materia.
 Newton Isaac (1642-1727). Matematico e fisico inglese, considerato
per le sue scoperte nel campo elei calcolo differenziale e delle
proprietà della luce e soprattutto per la teoria della gravitazione
universale uno dei più grandi e rivoluzionari esponenti della moderna
scienza. I principi da lui enunciati distrussero la concezione
classica dell'universo e permisero di delineare una nuova teoria della
meccanica celeste e della materia, rimasta fondamentale fino ai primi
anni del XX sec. Nacque il 25 dicembre 1642, l'anno della morte
di Galilei, nella contea di Lincoln, a WooIsthorpe-by-Colsterworth.
Suo padre, un piccolo proprietario di terra, morì poco prima della
sua nascita. N. ebbe un'infanzia angustiata dalle ristrettezze economiche
in cui versava la famiglia e potè a stento compiere studi
regolari, che segui alla King's School di drantham e al Trinity
College di Cambridge. Nel periodo universitario si rivelò la sua
formidabile attitudine per le scienze esatte. Nel 1665 ottenne il
titolo di baccelliere delle arti (bachelor of arts). Subito dopo la
peste lo costrinse a lasciare la città, ma a quel tempo era già la
più acuta mente matematica esistente in Inghilterra. Conosceva a
fondo la geometria di Cartesio e aveva proprie originali intuizioni
sui principali problemi della matematica e della fisica. Tra il 1665
e il 1667 scoprì infatti il teorema binomiale, il metodo delle tangenti
e il calcolo delle flussioni. Giunse a tale ultimo risultato attraverso
una generalizzazione dei massimi algebristi inglesi e ne fece
un'esposizione in uno scritto che venne conosciuto da pochissime
persone. Fu così che più tardi Leibniz potè contestargli la priorità
della scoperta, provocando una violenta polemica. Nel 1666, secondo
Voltaire, mentre seduto sotto un albero del modesto campo
lasciategli dal padre pensava al moto della luna, la caduta d'una
mela gli fece improvvisamente intuire la gravitazione universale.
Nel 1669 gli fu data, al Trinity College, la cattedra "lucasiana"
di matematica, già occupata da Isaac Barrow, un matematico suo
professore che per primo aveva intuito le grandi possibilità di N.
Tré anni dopo era ammesso alla Royal Society, il primo istituto
veramente scientifico sorto in Europa, con uno scritto sul moto (De
motu). In tale lavoro sono già in parte contenute le teorie che poi
N. sviluppò nella sua maggiore opera, divenuta un classico della
scienza, f hilosofhiae naturalis principia mathematica (Principi matematici
della filosofia naturale), scritto tra il 1685 e il 1686. Nel
1689 fu eletto come rappresentante della sua università alla Convenzione.
Nel 1604, dopo aver superato un periodo di esaurimento
fisico e psichico, secondo alcuni dovuto ad un incendio scoppiato
incidentalmente nella sua biblioteca-laboratorio, ebbe il posto di tesoriere
della Zecca, di cui poi tré anni dopo divenne direttore. In
questo periodo N. subì un profondo cambiamento. Cominciò ad
amare la vita mondana e si dedicò con minore ardore alle indagini
teoretiche. Pu deputato e dal 1703 presidente della Royal Society.
Nel 1704 apparve la sua Ottica, un'altra opera fondamentale; l'anno
successivo riceveva dalla regina il titolo di cavaliere (che gli permetteva
di farsi chiamare Sir). Ancora in vita il suo genio ebbe
tutti i riconoscimenti; fu onorato da sovrani e conteso dagli uomini
di ingegno. Morì a Kensington il 20 marzo del 1727 e venne sepolto
a Westm.in.ster, presso l'entrata al coro.
Newton Isaac (1642-1727). Matematico e fisico inglese, considerato
per le sue scoperte nel campo elei calcolo differenziale e delle
proprietà della luce e soprattutto per la teoria della gravitazione
universale uno dei più grandi e rivoluzionari esponenti della moderna
scienza. I principi da lui enunciati distrussero la concezione
classica dell'universo e permisero di delineare una nuova teoria della
meccanica celeste e della materia, rimasta fondamentale fino ai primi
anni del XX sec. Nacque il 25 dicembre 1642, l'anno della morte
di Galilei, nella contea di Lincoln, a WooIsthorpe-by-Colsterworth.
Suo padre, un piccolo proprietario di terra, morì poco prima della
sua nascita. N. ebbe un'infanzia angustiata dalle ristrettezze economiche
in cui versava la famiglia e potè a stento compiere studi
regolari, che segui alla King's School di drantham e al Trinity
College di Cambridge. Nel periodo universitario si rivelò la sua
formidabile attitudine per le scienze esatte. Nel 1665 ottenne il
titolo di baccelliere delle arti (bachelor of arts). Subito dopo la
peste lo costrinse a lasciare la città, ma a quel tempo era già la
più acuta mente matematica esistente in Inghilterra. Conosceva a
fondo la geometria di Cartesio e aveva proprie originali intuizioni
sui principali problemi della matematica e della fisica. Tra il 1665
e il 1667 scoprì infatti il teorema binomiale, il metodo delle tangenti
e il calcolo delle flussioni. Giunse a tale ultimo risultato attraverso
una generalizzazione dei massimi algebristi inglesi e ne fece
un'esposizione in uno scritto che venne conosciuto da pochissime
persone. Fu così che più tardi Leibniz potè contestargli la priorità
della scoperta, provocando una violenta polemica. Nel 1666, secondo
Voltaire, mentre seduto sotto un albero del modesto campo
lasciategli dal padre pensava al moto della luna, la caduta d'una
mela gli fece improvvisamente intuire la gravitazione universale.
Nel 1669 gli fu data, al Trinity College, la cattedra "lucasiana"
di matematica, già occupata da Isaac Barrow, un matematico suo
professore che per primo aveva intuito le grandi possibilità di N.
Tré anni dopo era ammesso alla Royal Society, il primo istituto
veramente scientifico sorto in Europa, con uno scritto sul moto (De
motu). In tale lavoro sono già in parte contenute le teorie che poi
N. sviluppò nella sua maggiore opera, divenuta un classico della
scienza, f hilosofhiae naturalis principia mathematica (Principi matematici
della filosofia naturale), scritto tra il 1685 e il 1686. Nel
1689 fu eletto come rappresentante della sua università alla Convenzione.
Nel 1604, dopo aver superato un periodo di esaurimento
fisico e psichico, secondo alcuni dovuto ad un incendio scoppiato
incidentalmente nella sua biblioteca-laboratorio, ebbe il posto di tesoriere
della Zecca, di cui poi tré anni dopo divenne direttore. In
questo periodo N. subì un profondo cambiamento. Cominciò ad
amare la vita mondana e si dedicò con minore ardore alle indagini
teoretiche. Pu deputato e dal 1703 presidente della Royal Society.
Nel 1704 apparve la sua Ottica, un'altra opera fondamentale; l'anno
successivo riceveva dalla regina il titolo di cavaliere (che gli permetteva
di farsi chiamare Sir). Ancora in vita il suo genio ebbe
tutti i riconoscimenti; fu onorato da sovrani e conteso dagli uomini
di ingegno. Morì a Kensington il 20 marzo del 1727 e venne sepolto
a Westm.in.ster, presso l'entrata al coro.N. confutò sia il sistema cartesiano del mondo basato sul principio dei pianeti sostenuti da vortici, sia la statica concezione tolemaica. Dalla sua teoria sulla gravita potè stabilire una serie di conseguenze relative al moto e alla posizione dei corpi celesti. Tutto l'universo venne da lui concepito in termini matematici e in base al suo sistema fu possibile compiere alcune verifiche sperimentali. Così Halley potè prevedere il ritorno della cometa che porta il suo nome. Lo studio della luce, in particolare di alcuni problemi concernenti la natura della rifrazione, aveva già avuto inizio da qualche secolo. Nei primi anni del sec. XVII si era cominciato a considerare l'ottica come una parte della geometria, ma in realtà non si riusciva a costruire telescopi matematicamente perfetti e l'osservazione stellare era ostacolata dagli aloni luminosi. N. costruì un telescopio riflettente che risolveva la difficoltà delle immagini colorate, quindi dimostrò che i colori osservati nella rifrazione della luce attraverso un prisma non erano dovuti al prisma, ma appartenevano alla normale luce bianca. Inoltre dallo studio di altri colori, diversi da quelli dell'arcobaleno, intuì la natura « granulare » della luce, fornendo un primo preciso indizio sulla composizione atomica della materia.
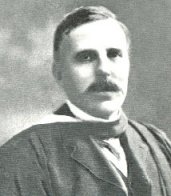 Rutherford Ernest (Nelson 1871 - Cambridge 1937). Fisico neozelandese,
considerato il padre della teoria nucleare. Studiò in patria,
a Wellington, e in seguito si trasferì in Inghilterra, dove compì
ricerche presso il laboratorio di Cavendish dell'Università di Cambridge.
Successivamente fu docente nel Canada e in Inghilterra, tra
l'altro a Cambridge e alla Royal Institution di Londra. Dedicatesi
allo studio della radioattività dell'uranio, R. giunse via via ad una
serie di scoperte di enorme importanza per lo sviluppo di quella
che poi sarebbe stata l'attuale fìsica nucleare. Tra l'altro definì la
natura nucleare delle particelle alfa e ne determinò il numero esistente
in un'unità di volume di gas. Nel 1911 spiegò l'atomo come
un microscopico sistema solare, stabilendone la natura nucleare, e
definì la struttura nucleare della materia. Nel 1919, infine, delineò
una teoria sulla trasmutazione degli elementi, la quale più tardi
fu alla base degli studi che resero possibile la costruzione della
prima bomba atomica. Nel 1908 gli venne dato il premio Nobel
per la chimica e nel 1931 ebbe il titolo di pari. Dei suoi scritti
ricordiamo Radioattività (1904), Trasformazioni radioattive (1906),
Le sostanze radioattive e le loro radiazioni (1912), La più recente
alchimia (1937).
Rutherford Ernest (Nelson 1871 - Cambridge 1937). Fisico neozelandese,
considerato il padre della teoria nucleare. Studiò in patria,
a Wellington, e in seguito si trasferì in Inghilterra, dove compì
ricerche presso il laboratorio di Cavendish dell'Università di Cambridge.
Successivamente fu docente nel Canada e in Inghilterra, tra
l'altro a Cambridge e alla Royal Institution di Londra. Dedicatesi
allo studio della radioattività dell'uranio, R. giunse via via ad una
serie di scoperte di enorme importanza per lo sviluppo di quella
che poi sarebbe stata l'attuale fìsica nucleare. Tra l'altro definì la
natura nucleare delle particelle alfa e ne determinò il numero esistente
in un'unità di volume di gas. Nel 1911 spiegò l'atomo come
un microscopico sistema solare, stabilendone la natura nucleare, e
definì la struttura nucleare della materia. Nel 1919, infine, delineò
una teoria sulla trasmutazione degli elementi, la quale più tardi
fu alla base degli studi che resero possibile la costruzione della
prima bomba atomica. Nel 1908 gli venne dato il premio Nobel
per la chimica e nel 1931 ebbe il titolo di pari. Dei suoi scritti
ricordiamo Radioattività (1904), Trasformazioni radioattive (1906),
Le sostanze radioattive e le loro radiazioni (1912), La più recente
alchimia (1937).