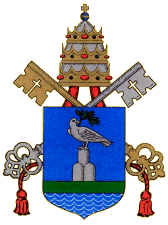|
|
f |
L'ultimo aggiornamento è stato effettuato a:
f |
|
f |
|
g |
|
La sindrome rossa di Eugenio Pacelli, al contrario di quanto comunemente si crede, non risale al 1949 con la scomunica ai comunisti e la profezia della caduta dell'impero sovietico. ha origini più remote: risale infatti a un trauma infantile in cui la psicanalisi non ha mai colto il filo rosso di una delle più straordinarie esistenze del secolo. Eugenio Pacelli, nato a Roma il 2 marzo 1876, aveva all'epoca cinque anni. Era un bambino quieto, andava volentieri in chesa con la madre. Gli piaceva cantare nel coro. in casa aveva costruiito un altarino. Anche se mimare il sacerdote che celebra la messa era solo un gioco, la moltitudine dei parenti in tonaca vi vedeva un segno e l'incoraggiava. Ma sarà proprio da uno di essi, cugino del padre, che Eugenio riceverà il primo shock di fede. Lo zio prete l'aveva preso sulle ginocchia per raccontargli la vita avventurosa - e per lui eroica - dei missionari in America Latina. Era una storia un po' fosca di guerriglieri marxisti e preti in croce. Eugenio ne era rimasto atterrito. "I chiodi no" gridava "i chiodi non li voglio". Le cruente immagini del racconto gli torneranno in sogno a lungo. Nell' Italia di fine Ottocento, specie tra i giovani, erano di moda Antonio Fogazzaro, narratore quasi eretico, e il "sol dell'avvenire" teorizzato da Marx e spiegato agli italiani da Antonio Labriola. Più che pilastri, rappresentavano la pietra confinaria tra i papalini, che avevano chiuso il portone a lutto dopo la breccia di Porta Pia, e la borghesia umbertina, eccitata da Giosuè Carducci e attratta dalla Massoneria. Pacelli, come scriverà in un tema liceale, stava in mezzo al guado. Difendeva Fogazzaro e l'ipotesi di un eros cattolico. Ma al socialismo si opponeva puntiglioso, arroccandosi nella sociologia cattolica: i guerriglieri sudamericani, più che le palme dei missionari, era lui che inchiodavano, offuscando la lucidità di giudizio. Così restava un baciapile anche quando ballava i valzer viennesi più festosi. Uscirà dal guado a diciott'anni, quando entrerà al Capranica, il seminario dove da secoli la Curia arruola talenti per la segreteria di stato. Così, all'inizio del nuovo secolo, entrava in Segreteria di stato: era un prete raffinato, aveva due lauree e conosceva quattro lingue, oltre al latino e al greco antico. Soprattutto aveva una conoscenza profonda della storia, non soltanto della Chiesa, ma anche del movimento operaio. La sindrome rossa non era più un complesso. Ora aveva i contorni di un' idea forza da alimentare e razionalizzare con la cultura e con l'analisi sempre più rigorosa degli avvenimenti storici. Era quindi attento al nuovo che si manifestava nella società e nella cultura. Come pochi in Segreteria di stato, Pacelli capiva sia le spinte riformiste sia quelle rivoluzionarie e ne dava conto nei rapporti sugli avvenimenti italiani, suggeritore occulto delle politiche d'attacco a sinistra e di mediazione con il centro moderato. Per Leone XIII era una sorta di "grillo parlante" da non sottovalutare. In Segreteria di stato nessuno quanto Pacelli sapeva valutare la portata e le ombre del "caso Italia" (come già allora la diplomazia francese sintetizzava le anomalie del nostro sistema). Riteneva più costruttiva la mobilitazione delle coscienze contro la sinistra marxista più radicale, peraltro in ascesa sia nella società che in parlamento. La sindrome rossa aveva già una sostanza politica: ma è difficile dire quanto Pacelli abbia influito sul cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato di Pio X, nuovo pontefice dal 1903. Però sta di fatto che sarà proprio papa Sarto a volerlo sottosegretario agli Affari straordinari, convinto che avrebbe investigato con lucidità il corso degli eventi anche negli Imperi Centrali, Germania e Austria-Ungheria, alleati dell'Italia con un accordo passato alla storia come Triplice alleanza. Aveva creato una propria rete attraverso un sistema di relazioni che curava personalmente, giacchè non rilasciava deleghe. Non le sfruttava soltanto per l'ufficio, ma anche per aggiornare in tempo reale il dossier personale sul marxismo. Stava già tallonando Lenin. Voleva capire quanto e come - in questa vigilia di guerra - l'ideologia bolscevica, il pacifismo e l'obiettivo rivoluzionario della dittatura del ploletariato potevano influenzare le scelte dei socialisti d'Occidente. Nel gennaio del 1914 - quando le grandi potenze acceleravano il riarmo e le sinistre d'Europa, dilatando le parole d'ordine leniniste contro la "guerra capitalista", organizzavano scioperi e manifestazioni di piazza, corpo a corpo con la polizia - l'ufficio di monsignor Pacelli aveva assunto le dimensioni e le caratteristiche di un moderno "centro di crisi". Il pontefice lo consultava con martellante frequenza, giacchè sentiva "il guerrone persino nell'aria". La crisi di sconforto più penosa doveva averla in giugno dopo aver letto rapporti e analisi sulle "settimane rosse per la pace", particolarmente cruente a Ancona e eni porti russi e tedeschi del Baltico. "Bisogna prepararsi al peggio, monsignore mio: ora manca soltanto un pretesto" aveva detto il papa a Pacelli, già pensando a come organizzare l'assistenza alle popolazioni destinate a "franare nella grande fornace". Il pretesto, tragico ed imprevisto, doveva arrivare dalla città sacra ai musulmani della Bosnia-Erzegovina, Sarajevo, con l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Asburgo. Invece di reagire all'evento con "voce profetica sul mondo in tempesta", Pio X in quell'occasione "si stese sull'altare come vittima" per morirvi il 20 agosto 1914, mentre le armate degli Imperi Centrali consumavano a Bruxelles lo stupro dellaneutralità belga. Il nuovo pontefice Benedetto XV aveva imposto la sua linea di imparzialità anche agli episcopati dei paesi coinvolti nel conflitto. La missione attuale della Chiesa, teorizzava con i vescovi, è quella di favorire e sostenere le iniziative contro il proseguimento della guerra, senza badare al prezzo. Quanto ne fosse convinto l'ha dimostrato con i fatti. Nel 1914, mentre le armate degli imperi centrali dilagavano su tutti i fronti, aveva inviato Pacelli a Vienna con il difficile compito di convincere Francesco Giuseppe a far concessioni territoriali all'Italia in cambio della neutralità. Voleva circoscrivere l'area del conflitto. Ma l'imperatore, pur stimando pericolosa l'apertura di un fronte alpino, disse che non intendeva premiare l'irredentismo delle province italiane di Trento e Trieste. Oltretutto era sicuro che nel giro di un paio di settimane avrebbe brindato a Parigi con il Kaiser: un trionfo che avrebbe messo fuori gioco l'interventismo italiano. Non andò così, nè per Parigi nè con Roma. Per la Santa Sede il rifiuto austriaco era un brutto rovescio diplomatico. Anche Benedetto XV era sfiduciato. Diceva ormai che l'unica arma che gli rimaneva era la preghiera. Però, quando all'inizio dell'inverno gli parve che nella Russia zarista fosse maturato uno sbocco per la sua strategia, aveva attivato le Nunziature per spingere il Kaiser a realizzare un piano del servizio segreto tedesco per far ritornare Lenin in patria dalla Svizzera nascosto in un vagone piombato. Stando a quanto ha raccontato Curzio Malaparte, all'epoca segretario d'ambasciata in Polonia, il papa si era mosso sulla base di un rapporto di Achille Ratti, nunzio a Varsavia. Secondo l'ex direttore della Biblioteca Vaticana, con Lenin al potere Mosca sarebbe uscita dal conflitto con la pace separata, accelerando la fine della guerra. L'intuizione era fondata, come la storia dimostra, anche se - come ammoniva Pacelli - c'era rischio che dal potere dei Soviet alla Chiesa potessero venire in futuro solo guai di lunga durata. Il 13 maggio 1917 Pacelli veniva consacrato arcivescovo di Sardi e nunzio apostolico in Baviera. Era più o meno l'ora in cui a Fatima tre pastorelli portoghesi venivano abbagliati dalla visione di una Madonna portatrice di cupe profezie sul futuro dell'uomo. La coincidenza peserà sul destino di Pacelli, dilatando la sindrome rossa in una sindrome mistica, come prova il racconto delle sue visioni su cui hanno raccolto testimonianze i gesuiti che hanno chiuso la loro lunga istruttoria su Pio XII con una proposta di beatificazione. Nel 1917, con Lenin al potere, i russi avevano firmato la pace separata, consentendo allo Stato Maggiore degli Imperi Centrali di riorganizzare il fronte occidentale e quello alpino con il potenziale bellico e le divisioni dislocate lungo i 1400 chilometri del versante orientale. L'analisi di Pacelli era fosca ma realistica. Il nunzio prevedeva - come poi è accaduto - il crollo economicodegli Imperi Centrali e una caduta delle dinastie capace di aprire in Europa un baratro di caos politico e di disordine sociale di cui avrebbe approfittato la sinistra comunista, già peraltro galvenizzata dal successo della rivoluzione bolscevica. Non a caso, puntando l'indice sulla carta della Russia, aveva detto: "Ecco da dove verrà il pericolo per la Chiesa". Nella sindrome c'era già l'ambiguo tratto della profezia. A sottolineare il passaggio è suor Pascalina Lehnert. Nelle sue memorie, come nelle altre testimonianze al Tribunale dei Santi, suor Pascalina ha infatti più volte affermato - e secondo lei provato - che nella solitudine teocratica di Pacelli si potevano cogliere, sin dai giorni della Nunziatura, "le forme tipiche del veggente, del profeta, dell'oracolo", soprattutto a proposito del pericolo comunista. Per quanto dilatata da radicali sentimenti di affetto e di ammirazione, la sua testimonianza ha un peso specifico molto alto.Se non altro perchè, per oltre quarant'anni ha condiviso le giornate, o meglio, come teneva a ricordare, le "pene e le gioie" di Pacelli. Era l'autunno del 1919. Nei regni federati della Germania i sovrani erano stati esiliati e la vecchia classe dirigente liquidata. Ora il potere istituzionale era repubblicano. Con il crollo delle dinastie per Pacelli si aprivano pagine difficili: salvare il salvabile, ossia i concordati, incrementare gli aiuti alle popolazioni affamate, assistere i prigionieri di guerra e gli sbandati, trattare con le truppe d'occupazione, consigliare i deputati cattolici al Reichstag e nei parlamenti regionali, e soprattutto orientarli nel caotico divenire della lotta politica verso quella che il papa gli aveva indicato come una strategia della ricostruzione. Il compito era grave, anche perchè c'era una strisciante atmosfera di guerra civile con il quotidiano contrappunto degli scontri armati e dell'assalto ai forni, degli scioperi selvaggi e dei delitti politici. L'epicentro del disordine era Monaco, roccaforte del comunismo secessionista. Come Pacelli, anche suor Pascalina pensava che il mostro fosse la repubblica di tipo sovietico proclamata dai comunisti bavaresi d'accordo con Lenin e sotto il controllo ideologico dell'Internazionale. Invece era in incubazione la svolta nazista. Infatti, come Eugen Leviné, rappresentante personale di Lenin, era sbarcato a Monaco anche il caporale Adof Hitler. Aveva grandi progetti. Aveva scelto l'eccitabile Monaco come trampolino di lancio, perchè nessun'altra città come Monaco era stata travolta dagli eventi rivoluzionari, dalle passioni e dalle renitenze delle prime settimane del dopoguerra. Pacelli e Hitler non si sono mai conosciuti. Tuttavia, nei mesi più duri del dopoguerra, si sono incrociati nella chiesa di San Bonifacio, quando entrambi frequentavano la mensa dei poveri: Hitler per sfamarsi e Pacelli per confortare "qualche anima in pena". Assistere gli sbandati per Pacelli non era solo uno dei tanti doveri di prete e di Nunzio del papa. Come spiegava nei rapporti alla Segreteria di stato, era anche un impegno politico. Infatti era convinto che senza un preventivo "recupero degli uomini in crisi" non fosse possibile realizzare "un forte progetto di rinascita civile e religiosa della nazione tedesca". Ossia un nuovo ordine democratico garantito dalla Socialdemocrazia e dal Zentrum cattolico. Non vedeva altro modo per bloccare il dilagante estremismo della Lega di Spartaco, il movimento comunista di Karl Liebnecht e di Rosa Luxemburg. Le possibili alternative gli sembravano una fuga dalla realtà. Il principe Rupprecht di Wittelsbach, pretendente al trono di Baviera, si batteva per la costituzione di una federazione monarchica e cattolica tra Baviera, Austria e Ungheria. Il principe aveva cercato anche l'appoggio del nunzio, consapevole com'era dell'ascendente che aveva sull'episcopato mitteleuropeo, ma soprattutto nella convinzione di trovarlo disposto a tutto pur di fermare la valanga rossa. Invece Pacelli non si era lasciato tentare. Anzi, aveva lavorato contro il progetto facendo leva sull'apparato dello Zentrum e delle associazioni cattoliche. Ma soprattutto mediando l'alleanza tra i centri di potere economico-finanziario più avveduti, la sinistra riformista e il movimento dei cattolici. Ossia le forze sociali e politiche che vedevano quanto lui la Repubblica di Weimar come un mezzo per battere il sovietismo secessionista dilagante in Baviera e per consolidare il nuovo ordine europeo. Pacelli aveva lavorato duro senza mai esporsi: infatti, proprio come aveva raccomandato il Segretario di stato, aveva adottato i sistemi della diplomazia segreta, tanto da venir considerato il "Machiavelli del partito della rinuncia" e il "Richelieu di Monaco". Insomma, per la destra quanto per la sinistra era un papista da annientare. A Monaco probabilmente la vita non è mai stata tanto dura come nell'ultimo scorcio dell'inverno del 1919. La città - come scriveva il "Kurier" - sembrava un campo fortificato governato dalle leggi della violenza. Era divisa in settori collegati da pattuglie motorizzate sulle quali, specie verso il tramonto, i cecchini dei Corpi franchi sparavano dai tetti. Durante i rastrellamenti le mitragliere erano puntate ad altezza d'uomo e i caccia sfrecciavano a bassa quota. La gente era stremata, la repressione stava strangolando persino le attività del mercato nero. "La rivoluzione sembra aver importato dalla Russia solo odio di classe, paura e fame". A raccontarlo in questi termini è il capitano Francesco De Luca, addetto militare a Monaco dalla fine della guerra. In teoria De Luca avrebbe dovuto svolgere soltanto mansioni consolari. In realtà coordinava i servizi d'informazione agli ordini del brigadiere-generale Roberto Bencivenga, capo della missione militare che rappresentava l'Italia a Berlino in attesa che venissero ristabilite le normali relazioni diplomatiche. Pacelli e De Luca erano quasi coetanei, entrambi appassionati di cavalli e di lirica. Le affinità finivano qui. Tuttavia - complici l'ovattata atmosfera della Nunziatura, gli scacchi, la musica e un bicchiere di vino italiano, introvabile in Baviera - tra di loro si era stabilita una certa intesa. Anche politica, giacchè verso il comunismo manifestavano la stessa sindrome. Pacelli sapeva che gran parte di quanto diceva sulla situazione veniva tradotto in codice e trasmesso al Bencivenga. Ma gli stava bene. Anzi lo favoriva, dato che la "Questione Romana" era d'ostacolo ad una aperta collaborazione diplomatica tra Italia e Santa Sede. Vent'anni dopo, aspettando l'incoronazione di Pio XII in piazza San Pietro, De Luca ha ammesso che la Missione militare in Germania "doveva molto al contributo indiretto di Pacelli". A prescindere da questo, De Luca era sinceramente affezionato al Nunzio, al punto di aver rischiato la propria vita per salvare la sua durante un'incursione armata della guardie rosse. Su come sia andata, le testimonianze sono scarse e confuse. C'è tuttavia un documento, conservato nell'archivio dello Stato Maggiore, in cui si racconta il momento-chiave di Pacelli. Ricostruito sulla base di "determinanti deposizioni autografe", è stato redatto in stile burocratico il 23 agosto 1919 dal brigadiere-generale Roberto Bencivenga, protocollato dal servizio ricompense col numero 2498/19, ha per oggetto "l'inchiesta sul conferimento della medaglia d'argento al valor militare al capitano Francesco De Luca per aver difeso il nunzio apostolico, con rischio della propria vita, durante i moti spertachisti". L'evento risale al 30 aprile 1919. Pacelli era appena tornato dalla clinica, ancora febbricitante e scosso da violente crisi di singhiozzi (da sempre spia di forte stress). Era una sfida contro Eglhofer, che gli aveva dato quarantott'ore per lasciare il paese, e un atto di disobbedienza verso il papa, che gli aveva raccomandato di rifugiarsi nel convento svizzero delle monache di Stella Maris. Aveva deciso "di restare alla barra", come faceva sul mare in tempesta quand'era solo un velista innamorato. Non lo faceva per un astratto senso del dovere. La realtà è che voleva assistere al crollo del potere rivoluzionario: non solo per una sorta di rivincita, ma anche per poter cogliere a caldo l'opportunità di un'intesa di governo tra socialdemocratici e cattolici. Il suo modello era Weimar. L'archivio conferma che ha perseguito l'obiettivo con successo. De Luca aveva capito questo stato d'animo: perciò aveva intensificato la vigilanza sulla Nunziatura. A dare l'allarme, tuttavia, sarà suor Pascalina. Erano le dieci. Il governo aveva proclamato lo stato d'assedio e la mobilitazione generale. In un messaggio flash per la missione il capitano aggiunge che i piani di difesa venivano realizzati in un torbido clima di violenza, tra agguati, saccheggi ed esecuzioni sommarie. Dalle parole strozzate di suor Pascalina, De Luca aveva capito che stavolta il nunzio era proprio sotto tiro. Era da mesi che Eglhofer lo minacciava, anche se non andava più in là dell'intimidazione perchè gli inviati dell'Internazionale non volevano "cadaveri eccellenti". Ma ora, nella bruciante resa dei conti, l'ex imbianchino considerava quel veto fuori corso: così aveva affidato ad un fanatico di origine aristocratica, il tenente Seidl von Cheminitz, il compito di "dare al papista ciò che da tempo meritava". Dal'inchiesta militare si ricava che De Luca era piombato nel salone della Nunziatura mentre Von Cheminitz puntava la pistola al viso di Pacelli. Voleva la combinazione della cassaforte, convinto di trovarvi le prove delle "trame ordite contro la repubblica". Stando alle testimonianze rese a padre Molinari, postulatore per la causa di beatificazione di Pio XII, Pacelli aveva reagito con calma. "Non ho paura" aveva detto "perchè sto nelle mani di Dio". Poi, stringendo il pettorale, aveva aggiunto: "Sto qui e qui rimarrò. Non mi ritirerò neppure di un passo di fronte a qualunque prepotenza terrena". De Luca dirà poi che "aveva lo sguardo fisso negli occhi dell'ufficiale": tuttavia, "più che guardare, sembrava intravedere un oltre che si ivelava soltanto a lui". Appariva dunque "impenetrabile e impassibile" tra le suore impietrite davanti ai fucili che sette miliziani avevano spianato dopo che suor Pascalina aveva tentato di far da scudo al Nunzio. "Erano in posizione di stallo" preciserà il capitano "e sembravano tutti raggelati". Stando alla motivazione della medaglia al valore, De Luca ne aveva approfittato "per affrontare la soldataglia con fredda determinazione e sprezzo del pericolo, riuscendo ad avere ragione". In effetti con il suo intervento aveva spezzato il filo della crisi, richiamando il giovane ufficiale all'ordine di non seminare "cadaveri eccellenti", per giunta portando la sfida anche contro un militare che rappresentava in Baviera una delle potenze che stavano imponendo il trattato di pace alla Germania. Perciò, abbassata la pistola, Von Cheminitz se ne andava minacciando di tornare "per fare sul serio quanto merita un nemico". In quei giorni tutto era possibile: perciò il capitano lasciò Pacelli in preghiera con le suore per andare al palazzo di governo per trattare direttamente con Eglhofer. Il giorno dopo le truppe federali, centomila uomini, dilagavano in Baviera, dovunque accolte con entusiasmo. L'armata Rossa, il governo e la Lega spartachista si erano dissolti ai primi colpi di cannone. Però questo non aveva evitato un bagno di sangue di proporzioni mostruose. Sotto il fuoco dei plotoni d'esecuzione erano infatti caduti centotrenta miliziani, tra cui Eglhofer e persino ventuno operai cattolici catturati per errore. La controrivoluzione era in piena corsa quando Pacelli il 30 giugno andava a Berlino per annunciare al capo dello stato che il papa l' aveva incaricato di rappresentarlo anche presso la Repubblica Federale del Reich. Alla presidenza c'era il Socialdemocratico Friederich Ebert: era stato eletto con il voto determinante del Parttito popolare, il vecchio Zentrum cattolico, del quale il Nunzio era una sorta di guida occulta. Convinto marxista, e tuttavia cattolico fervente, in Pacelli Ebert non vedeva solo l'alleato di prestigio e di raffinata intelligenza politica, ma anche un prete illuminato. Ai laici di Weimar non piaceva. Lo prova un discorso al Reichstag del segretario liberale."In Germania" aveva detto "c'è un uomo che, pur non essendo tedesco, sa manovrare la politica germanica meglio di tanti nostri leaders: quest'uomo è Eugenio Pacelli". Per Pacelli la destra non è mai stata la giusta soluzione per risolvere le crisi e i problemi di un paese. Tanto meno una diga contro il comunismo. Durante la guerra civile spagnola, per esempio, non ha mai parteggiato per franco e la Falange, benchè il Primate spagnolo avesse documentato alla Segreteria di Stato l'esecuzione sommaria di 13 vescovi, 283 suore e 6.536 tra preti e frati. Ha ostentato diffidenza e distacco anche verso gli ustascia di Ante Pavelic e quei paesi confinanti con l'Unione Sovietica che avevano adottato il modello fascista. Invece sin dal 1943 - quando l'esercito sovietico sembrava sfiancato da quello tedesco con grave pregiudizio per le sorti del conflitto - pensava di eccitare la lotta contro il comunismo con un elettroshock di fede. Alimentata nel segreto delle visioni mistiche, confessate solo a Domenico Tardini, all'epoca prosegretario di Stato, la sindrome rossa aveva finalmente un'identità e un fine. Anzi: lo sbocco doloroso d'una scomunica che avrebbe lacerato le coscienze. Tuttavia in esso vedeva la prosettiva di "un'uscita dai patimenti e dalle colpe". Ne soffriva in modo autentico: così, anche per questo, un teologo americano ha voluto tramandarlo con l'immagine di un dry-martyr, cioè come vittima di un martirio incruento. In quel tempo ripeteva spesso, sino a sfiorare l'autoesaltazione, che aveva "una grave missione da compiere". Quella di "fare della massa il popolo di Dio" e del messaggio cristiano " un'alternativa conforme a grazia e natura" in quanto "fondata sull'amore evangelico e non sulle scelte materialistiche del capitalismo o sui "falsi miti della rivoluzione". Su questi temi è stato martellante. Dal giugno del 1946 al Natale del 1948 Pio XII ha mantenuto il suo popolo sotto pressione con 600 interventi: uno ogni 44 ore. A chi glielo faceva notare, si giustificava con la necessità di dover "radicare nell'uomo il carisma della Chiesa". In realtà alla fine del conflitto mondiale che presentiva il vicolo cieco della contrapposizione frontale tra i blocchi e della lunga stagione della guerra fredda. Nel disordine della pace avvertiva un sommovimento delle coscienze di grande portata, capace di lacerare persino il tessuto connettivo della società - la famiglia - e offuscare quello della gerarchia ecclesiastica con resistenze passive con diserzioni e rivolte. C'erano già i preti operai e i partigiani della pace con religiosi e preti di prestigio in primafila accanto ai big del comunismo. e c'era la chiesa del silenzio, con arcivescovi imprigionati e primati costretti a vivere nelle ambasciate americane presidiate dalla polizia. Non gli era di gran conforto la situazione italiana: nel trionfo elettorale conseguito dalla Democrazia Cristiana nell'aprile 1948 non vedeva una testimonianza di fede, bensì le pulsioni di una società che si era data l'obiettivo di ricostruire il paese secondo i modelli di sviluppo mediati dalle grandi democrazie d'Occidente. Non a caso, sin dai giorni trionfali d'aprile, pensava di opporre allo scudo crociato un partito cattolico in grado di ricomporre il variegato mondo della destra italiana. lo tenterà sul serio nel 1952. Erano i giorni della grande fioritura delle madonne piangenti e dei cristi sanguinanti, di un'isteria religiosa di massa di cui si nutriva il fanatismo della "Legio Mariae", gli arditi dell'ideologia mariana. Sullo sfondo c'era la guerra fredda, con l'incubo dell'olocausto atomico. La scomunica del 1949 fu un fiasco. Quindi non appare casuale che la stessa istruttoria del processo di beatificazione - al punto 97 di pagina 62 - dedichi poco spazio al 1949, caratterizzandolo come anno di transizione. "Il 1949" sottolinea infatti padre Molinari "non fu contraddistinto da fatti notevoli: fu questo un periodo in cui il Vicario di Cristo attese soprattutto a preparare l'Anno Santo". Non aveva più confini. Interveniva su tutto, infatti; e a tutti voleva spiegare il fine e la pratica di ogni missione. Di fronte agli uomini insomma sembrava che si sentisse onnipotente: o per lo meno invincibile. Tipico di questa situazione esistenziale è un episodio tramandato dall'archiatra pontificio. Come al solito alle otto Pacelli era già al tavolo di lavoro con un grande fascio di giornali che davano la notizia della morte di Stalin con titoli a nove colonne. Secondo Galeazzi-Lisi sfogliava le prime pagine con un sorriso beffardo. "Pio XII" racconta il medico "alzò un attimo la testa dalla carta stampata: mi guardò a lungo; e poi, con quell'insolito sorriso, come parlando a sé stesso, mi disse: "Stalin è morto. A Yalta voleva sapere di quante divisioni il papa disponesse. Ora potrà vedere su quale potenza contiamo lassù"". |
Tratto da: Enrico Nassi, "Pio XII e il comunismo-La sindrome rossa", Giunti
|