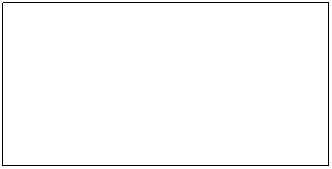-
Era calata la sera nel nuovo lager sconosciuto dove gli Internati
militari italiani erano stati scaricati dai carri bestiame fin dal
mattino e lasciati ammassati a gruppi di trenta, ora in baracca ma
di più all’aperto sotto il nevischio, incolonnati per cinque,
digiuni, in attesa dei controlli, perquisizioni, registrazioni e
della disinfestazione finale, dove i fagotti di indumenti vennero
gettati sulla neve, e loro ignudi a cercarli e a rivestirsi.
-
Il
gruppo dove era capitato il sottotenente Pietro Sartano e il
collega Mario Cefario, ch’erano riusciti a restare insieme, fu
cacciato nel buio fitto; ciascuno seguiva le orme di chi lo
precedeva, a null’altro attento se non a stare incasellato fra i
compagni, unico contatto per non sprofondare nel buio.
-
A
poco a poco Pietro distinse ch’erano in una baracca priva di
divisori; un unico locale, per metà, nel lato lungo, occupato da
tre tavolati soprastanti che formavano delle lunghe e basse
lettiere comuni, come le stive dei velieri negrieri del ‘700.
-
I
prigionieri s’affollarono a gettare la propria roba sui ripiani
dei tavolati in segno d’occupazione del posto. Pietro e Mario
buttarono i loro zaini sull’ultimo ripiano.
-
Un
Capitano anziano che s’era assunta la responsabilità di governo
nella baracca, diceva: - Lasciate i ripiani bassi agli anziani,
non vi affollate; dobbiamo entrarci tutti -. Dopo un po’, presa
cognizione della forza, precisò: - Signori Ufficiali, siamo
centottanta, dobbiamo sistemarci in sessanta per ripiano.
-
Pietro s’arrampicò sul tavolato e al buio, tastoni, slegò la
coperta fra le gomitate dei vicini: - Questo posto è occupato –
disse a uno che gli veniva addosso, e chiamò: - Mario, monta su!
-
Si
udì Mario che cercando di salire sul tavolo borbottava: - Per
favore, mi consenta di entrare... se sposta i piedi... E quello i
cui piedi bloccavano l’accesso sul tavolato: - Ho capito, bisogna
fare ancora un posto, sù, stringiamoci da questo lato.
-
Pietro a sua volta spingeva dall’altro lato dicendo: - Per favore,
stringersi – e distendeva la coperta accartocciata per lungo nello
stretto spazio.
-
Mario borbottava infastidito, come se i vicini gli avessero
lasciato poco spazio: - Nemmeno mezzo metro, appena il posto per
lo zaino...
-
Un
vicino precisò: - Le spettano meno di cinquanta centimetri; divida
per sessanta il tavolato, che non arriva a trenta metri...
-
- Stretti ci teniamo caldi – disse Pietro, che
ancora non si era ripreso dal freddo, preso alla disinfestazione.
-
- Dormiremo di fianco e lo spazio ci avanzerà.
Siamo come le sogliole – disse uno; e un altro di rimando: -
Stasera siamo più sogliole delle sogliole, il mio stomaco s’è
appiccicato alla schiena.
-
I
prigionieri si erano rassegnati a darsi la buonanotte a stomaco
vuoto, quando – erano già le ventuno – girò la voce di recarsi in
una baracca vicina a ritirare i viveri.
-
Non si erano ancora costituiti i gruppi per i viveri, e tutti
ridiscesero dai tavolati, avviandosi all’uscita. Seguivano al buio
la corrente senza fretta e senza l’animazione ch’era solita
all’arrivo dei viventi; erano stanchi, spossati, insensibili e
dimentichi di tutto, anche la fame.
-
La
fila entrò in un baracca illuminata ove ogni dodici uomini
distribuivano un pane e poca margherina, zucchero e marmellata.
Fra i dodici in cui si trovarono Pietro e Mario, il pane fu presto
suddiviso in un angolo della stessa baracca; su ogni fetta
spalmata la poca margarina, marmellata e zucchero. Ciascuno prese
la sua fetta e la mangiò fuori al buio ritornando nella baracca di
prima. S’era consumata un’altra ora di prigionia. Pietro
indolenzito rimontò faticosamente sul terzo ripiano del tavolato
e, senza togliersi né scarponi né pastrano né bustina, si mise
sotto la coperta, diede la buonanotte a Mario, e restò coi dolori
a tremare dal freddo.
-
La
sveglia fu data alle sei e trenta e subito dopo fu chiamata la
prima adunata per la conta, che pareva avesse lo scopo principale
di ricordare, come in certi monasteri medievali, che la vita deve
essere penitenza, espiazione e preparazione alla morte.
-
Giù dunque dal tavolato, dove Pietro, al tepore dei corpi stretti
dei vicini, aveva raggiunto una certa insensibilità; si tirò giù
la coperta, se l’avvolse attorno, vi si incappucciò, e si trovò in
riga a prendere freddo fra la nebbia e l’umidità.
-
Al
rientro, alla luce lattiginosa che entrava dalle finestrelle, ebbe
cognizione della sua nuova dimora. I tre ripiani di tavolato, che
rimpiazzavano i castelletti biposto con notevole economia di
spazio, formavano due stretti lunghissimi rettangoli sovrapposti,
intervallati da fitti travetti verticali che spezzettavano le due
buie fessure in un susseguirsi di loculi quadrati; come quelli dei
cimiteri, ricavati nei muri perimetrali e lasciati aperti in
attesa di murarvi l’ospite. A vederli Pietro si sentì mancare il
respiro. Eppure degli anziani, pallidi, magri, incappucciati come
lui, vi si introducevano stentatamente e scomparivano nel buio
come cadaveri che si seppellivano da soli.
-
- Meno male che ci è toccato l’ultimo ripiano –
disse Pietro come se dai gironi dell’inferno fosse salito al
purgatorio; e Mario sogghignando commentò: - Ci spettavano i
lettini; protestavamo pei castelletti coi trucioli, ed eccoci
accontentati sul tavolato!
-
- Meno male – ripeté Pietro girando lo sguardo –
ci sono le stufe.
-
Ve
ne erano quattro o cinque piccole, di ferro in tutta la baracca;
alcuni attorno si affaccendavano per accenderle; Pietro e Mario si
accaparrarono il compito di accenderne una con le poche schegge di
legno che racimolavano qua e là ed altri volenterosi
raccoglievano. La fiamma era una festa. Gli amici si allietarono
attorno ad essa; qualcuno disse: - Oggi è san Giuseppe.
-
Era domenica diciannove marzo. La notizia della ricorrenza
sorprese Pietro che come tanti altri non seguiva il calendario, ma
annotava il lento trascorrere delle anonime giornate di penitenza;
ed all’istante, nella sua mente, s’affacciò l’immagine della «sfincia»
di San Giuseppe; la grossa, soffice, porosa frittella infarcita di
crema di ricotta, che, nella sua città, era simbolo della festa
stessa; il modo di santificarla, di glorificarla anzi, deliziando
il palato, anche se si privilegiava della umana persona, fra lo
spirito ed il corpo, quest’ultimo (che poi non è da disprezzare se
è tempio di Dio). Pietro si tenne per sé il ricordo, ne soffrì da
solo; perché nessuno prendeva più piacere a parlare e sentire
parlare delle cose buone che avevano visto e mangiato nel paradiso
terrestre delle loro case lontane.
-
Meditava Pietro su quell’usanza palermitana (che da bambino lo
riempiva di gioia e da grande gli aveva ripugnato come cosa
superficiale e primitiva) di trasformare le ricorrenze religiose
in festini. I preti dal pulpito raccomandavano la spiritualità; ma
per tradizione, le novene si facevano giocando a carte; le
penitenze e le sacre meditazioni in cucina preparando sformati e
dolci; e le orazioni trovavano l’equivalente, davanti a tavole
imbandite, nelle mangiate collettive. I piccoli venivano
predisposti alla comprensione dell’evento religioso, dando loro a
sbocconcellare Madonne di zucchero colorato, bambini Gesù e Cristi
crocifissi stampati su croste di torrone.
-
Ma
strano, adesso pensava a tutte quelle cose senza vedervi
profanazione; invece si sentiva struggere dalla nostalgia per
quella gioia infantile di far festa in cucina attorno alle donne;
di trovarsi tutti insieme a ridere, a volersi bene, a godere dei
doni di Dio. Un inno, insomma, alla vita, nella letizia generale.
Non è anche questo lode a Dio?
-
Meditava e si struggeva così nel primo mattino di San Giuseppe,
quando entrò nella baracca un Cappellano in abito talare; si fermò
al centro e disse spiccio: - Sono il vostro amico religioso,
salesiano del collegio Don Bosco di Pordenone; mi chiamo Pasa,
come pas, pasa, pan, che in greco significa tutto; e vorrei essere
tutto per voi, ma sono poco e posso fare pochissimo. Oggi vengo a
celebrare la Santa messa in questa baracca.
-
La
baracca presto si affollò di molti che accorrevano a sentire la
messa. Il Sacerdote, aiutato da un soldato che aveva disposto ad
altarino l’apposito cofano da campo, si approntava indossando i
paramenti liturgici; era corpulento e massiccio di membra; dal suo
viso forte e acceso, dal suo parlare sicuro, pei modi energici che
conservava, pareva non avere subìto i sei mesi di prigionia degli
altri. Baciò la stola e se la mise al collo; si inginocchiò
davanti allo striminzito cofano-altarino, e, circondato da ogni
lato dalla folla, al centro di essa, anticipando la liturgia del
Concilio Vaticano Secondo, portò Cristo fra la gente.
-
Pietro si trovò fra i più prossimi all’altare, come mai gli era
capitato, e ne ebbe disagio; si sarebbe volentieri confuso
indietro; quel posto, così vicino al Sacerdote, al Calice, al
Sacramento, non gli spettava. Si sentiva (lui che era stato così
poco praticante, così tiepido cristiano, ignorante della liturgia,
delle orazioni, delle fasi della Messa) quasi sacrilego a stare in
prima fila. Sapeva, grosso modo, che la Messa rievocava il
sacrifico di Cristo morto in croce per redimere l’umanità e che
nella parte centrale avveniva la consacrazione con la quale
l’ostia diventava il corpo di Cristo; ma non riusciva a
spiegarselo ed ora, chiamato in prima fila ad assistere
direttamente al miracolo, per convincersene pensava al miscredente
prete di Bolsena che all’elevazione fu investito dal sangue
sprizzato dall’ostia. Ma ecco che malignamente gli si insinuava il
dubbio: ricordava di avere letto in un testo scientifico d’un
batterio che attaccava il pane conservato, producendovi delle
chiazze rosse come il sangue. Cercò di scacciare il dubbio, di
trovare artificiosa la spiegazione scientifica e di credere al
miracolo. Cristo aveva detto spezzando il pane: «Questo è il mio
corpo; fate questo in memoria di me». Pietro sapeva che il pane
era un miracolo, che era qualcosa di divino: esso diventava carne
e sangue; ma era il pane in genere e per tutti; era il cibo di
pace che non richiedeva vittime, voluto da Dio per nutrimento
santo; già da tempo, ogni briciola per lui era Ostia consacrata...
Ma che stava farneticando? L’Eucarestia era tutt’altra cosa...
-
- Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
-
- Et salutare tuum da nobis.
-
Pietro si scosse e cercò di seguire la messa; ma non capiva la
liturgia; alcuni vicini rispondevano al sacerdote e lui non sapeva
che un solo ritornello «et cum spiritu tuo», ma non sempre quella
era la risposta giusta e taceva. Si mise a recitare mentalmente
tutte le orazioni che ricordava, per penitenza della sua ignoranza
religiosa, dei pensieri eretici che gli erano venuti e per non
farsene venire altri; ma mentre pregava pensava lo stesso: «Ma è
dunque eresia vedere in ogni briciola di pane il miracolo, la
presenza di Dio?»
-
Frattanto don Pasa andava svelto; s’era concentrato un attimo alla
Elevazione, ed ora recitava brusco, rimescolava, beveva d’un
fiato, ripuliva energicamente e sparecchiava deciso, facendo in
fretta quelle cose ch’era solito fare. Nel rapido concludere
disse: - Scrivetemi in Italia, il mio indirizzo è... – e ripeté:
-
- Collegio Salesiano Don Bosco,
Pordenone. Organizzeremo un pellegrinaggio alla Madonna! - E
raccomandando calorosamente, con gioviale entusiasmo, di partecipare
al pellegrinaggio, come di una imminente bella rimpatriata, sparì.
-
-
* Il racconto è tratto dal
volume di Armando Librino “Carola” (ed. Ila Palma, Palermo 1997).
Il volume presenta diversi racconti che si ispirano alle “Cronache
di una breve estate” che Armando Librino, alto ufficilae
dell’Esercito, ha tratto dagli appunti di un suo diario del tempo
di guerra, dove è descritta la vita di privazioni e di sofferenze
nei Lager nazisti, in cui il rifiuto di aderire alla repubblica di
Salò poteva comportare rischi gravissimi.
-
Il libro vuole contribuire a
risvegliare l’interesse sulla resistenza degli internati militari
italiani durante la prigionia in Germania e richiamare alla memopria
come nella barbarie della guerra furono riaffermati i valori
patriottici, l’onor militare e la dignità umana. Un libro dedicato a
coloro che furono travolti dalla guerra e dimenticati dagli altri
che li oltrepassarono.