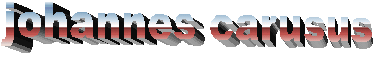
PREMESSA PROLOGO 1 - LA DISFATTA APOLOGO
1 - LA DISFATTA
1.
Assemini è un grosso villaggio, poco lontano da Cagliari, alla confluenza fra due fiumi, il Mannu e il Cixerri, che insieme si gettano nello stagno di Santa Gilla. Altri due piccoli affluenti irrigano le campagne intorno. Si può dire che Assemini è il punto di inizio della piana del Campidano, che attraversa la Sardegna da sud a nord – ovest, sino ad Oristano e oltre. La terra è coltivata a ortaggi, grano, vino, frutta, grazie alla ricchezza di acqua in tutte le stagioni. Il panorama è chiuso a sud – ovest dai monti di Capoterra con la cima di Sa Mirra; a nord – ovest dai monti di Villacidro con la cima di Monte Linas; a est dal Monte Serpeddì. Numerosi villaggi fanno corona ad Assemini e tutti insieme forniscono quanto occorre alla città di Cagliari.
2.
-
Pisa è lontana, Oristano è a tre giorni di marcia.
Gonario,
sdraiato con tutta l’armatura sull’erba, lì al confine di villa Duccio,
nella campagna di Assemini, sulla riva del Rio Flumineddu, era il ritratto della
paura e della fame.
Gli
altri cinque, stravaccati sotto una quercia da poco scorticata, con il fusto così
rosso da sembrare un torso umano insanguinato, annuirono stancamente. Alberco,
appoggiato con il gomito all’elsa dello spadone, la camicia ormai non più
bianca, la barba lunga, lo sguardo perso verso il lontano monte Serpeddì, si
voltò, aprì la bocca per parlare e poi cambiò espressione. Si rizzò, alzò
la spada, si voltò di scatto verso Gonario e gettò un urlo:
-
No! Il disonore è vicino! Vuoi andare? Vai con il Diavolo alla tua Oristano e
portati via questi altri babbei. Io torno a Cagliari, da solo magari. Troverò
pure una barca per Pisa e tornerò e allora guai a te e a Oristano!
Il Conte Alberco era furente, arrabbiato con tutto il mondo:
i cagliaritani che lo avevano costretto alla fuga con soli sei uomini, con
Oristano che non aveva mandato gli aiuti promessi, con Pisa che tardava a
rispondere ai suoi messaggi di aiuto, con il Papa che gli negava udienza, con
l’Imperatore che gli dava il titolo di Marchese della Sardegna e poi lo
destituiva restituendo onori e riconoscimenti ai Giudici, con la moglie Leonarda
che non aveva voluto seguirlo in quell’avventura – Sono barbari! – diceva
– Puzzano di pecora!
E
così eccolo solo, abbandonato, senza viveri e senza denaro, con i nemici di
Cagliari non troppo vicini ma neppure lontani. E’ vero che nessuno si era
arrischiato ad inseguirlo (uscire da Cagliari non era buona idea per quei
bastardi mezzo Mori!) ma neppure era utile tornare indietro a sfidarli.
Correre
ad Oristano e pretendere da Torchitoro i cento cavalli e i trecento fanti
promessi, tornare a Cagliari, riconquistare la città, prendere, torturare,
squartare il vescovo e tutti i preti che gli avevano sollevato contro quei
maledetti pescivendoli? Ma Torchitoro era affidabile? Lo aveva abbandonato e ora
magari si era alleato con i genovesi, per estrometterlo dalla sua Sardegna. Se
avesse avuto ancora con sé più uomini! Torchitoro anche di cattivo grado si
sarebbe convinto a mantenere gli impegni! Con sei uomini affamati, stanchi,
demoralizzati, presentarsi a lui sarebbe stato come dirgli “prendimi,
prendimi!”. Forse era meglio fare un lungo giro intorno a Cagliari, arrivare
alla spiaggia di Maddalena, rubare una barca, un paio di polli, un sacco di
grano e partire per la Gallura, veleggiando lungo la costa. Ma come vincere la
fame durante il percorso? Assalire dei contadini per nutrirsi voleva dire
chiamare i soldati del vescovo Sisinio!
Andando
verso Oristano potevano rubare qua e là perché intanto si allontanavano da
quel maledetto rappresentante di Bonifacio (che il diavolo in persona se lo
porti!). E se Torchitoro non aspettava altro che una scusa per arrestarlo?
-
Eccomi preso fra due fuochi. Qui non posso stare, andare avanti non se ne parla,
indietro neppure!
Villa
Duccio era una casa, grande, ma una casa di campagna. I muri qua e là scrostati
mostravano la struttura fatta di mattoni di fango. Travi di legno, con la testa
sporgente dal muro, sostenevano il tetto di tegole rosse. Un grosso comignolo,
coronato da due tegole oblique per proteggere dalla pioggia il focolare, dal
quale usciva fumo tutto il giorno, denunciava l’esistenza di un camino usato
anche per cucinare. Una stalla, con cinque vacche, un vitello,
due cavalli e un asino, e un fienile mal ridotto completavano le
costruzioni.
Lontano
dal casale c’erano cinque capanne di pietra e frasche per i contadini.
Tra
la stalla e le capanne scorrazzavano le galline e le anatre. Di tempo in tempo
si sentivano cantare i galli e grugnire alcuni maiali. Alberi di pere e viti e
olivi allineati erano tutt’intorno, i fichi, piantati lungo un basso muretto
di pietrame alla rinfusa, segnavano il confine della proprietà. Due donne
sciorinavano il bucato su corde tese fra gli alberi. Il sole ormai alto in cielo
proiettava corte ombre fra i pampini.
Alberco
e i suoi uomini erano sulla proda del fiumiciattolo che segnava un confine della
proprietà di Duccio. L’acqua aveva scavato il suo letto nella terra nera
formando un canale di qualche metro più basso del livello del terreno
circostante. In questo canale, ingombro di canne fruscianti, di cisto, di
lentisco, di mirto, di oleandri in fiore e di querce, gli uomini erano nascosti
alla vista degli abitanti della villa. A sinistra le montagne di Capoterra e di
Villacidro, in lontananza, dalla parte opposta, le montagne di Sinnai. Erano
arrivati in quel nascondiglio il giorno prima a notte inoltrata, dopo una fuga
durata una mezza giornata e s’erano fermati facendo affidamento sulla cortina
di vegetazione che li circondava. Avevano dormito a turno, ma ora la fame li
teneva tutti in allarme e preoccupati per il futuro.
Tre straccioni pisani, un francese senz’arte, due pastori
sardi erano la compagnia di soldati di Alberco, i resti di un’armata di 250
uomini che il giorno prima sembrava in grado di prendere Cagliari senza fatica.
E invece… Invece quei maledetti pescivendoli, aizzati dai preti, guidati da un
invasato, li avevano fatti entrare in città senza ostacoli e poi … Poi li
avevano assaliti con i bastoni, con i sassi, con le tegole scagliate dai tetti,
aizzando i cani. E loro, i suoi soldati ben addestrati, ben pagati, con la
pancia piena del suo grano e dei suoi maiali, quei vermi schifosi, s’erano
fatti uccidere e gli altri si erano arresi. Lui era stato costretto a fuggire,
Alberco di Lando, gran signore in Pisa, con quei sei miserabili che s’erano
salvati scappando al primo urlo dei cagliaritani. Avrebbe dovuto ucciderli lui
stesso, per la loro codardia. Ma ora forse potevano essergli utili.
-
Ho deciso. – Alberco aveva mutato tono, era tornato un comandante responsabile
della vita propria e di quella dei suoi uomini – Appena sarà buio entreremo
nella villa, prenderemo tutti prigionieri, mangeremo e dormiremo. Domattina
decideremo cosa fare. Là dentro ci saranno tre o quattro persone al massimo,
sarà facile e senza pericoli. Ora state tranquilli e nascosti. Tu Marco e tu
Lallo andate lassù e sorvegliate che nessuno venga da questa parte.
Marco
e Lallo, due dei pisani, s’alzarono di gran malavoglia, si tolsero l’elmo e
si avviarono strisciando verso l’orlo del canale. C’era un ciuffo di canne
anche lassù, vi infilarono la testa e si fermarono.
Gonario
guardò torvo il suo padrone, poi si voltò e sgattaiolò carponi fra le canne.
Nessuno protestò – che se ne andasse all’inferno! - Qualche minuto dopo
ecco Gonario tornare con le mani colme di qualcosa.
- Prendete e mangiate, almeno lo stomaco si riempie.
- Cosa sono?
- Cime di canne, sono
tenere. Vicino all’acqua stanno nascendo ora. Le mangiano le pecore e le
capre.
- Io non sono una capra!
- Tieniti la fame!
- Su soldati non facciamo storie! – intervenne Alberco –
Se le mangia Gonario, a noi non faranno male.
E
diede l’esempio addentando il cilindro di un bel colore paglierino. Tenero e
dolciastro, ma quanto a inghiottirlo era una fatica. Ne morse dei pezzi
piccolissimi, masticò a lungo, rompendo le fibre e infine lo mandò giù.
-
Buono! Bravo Gonario.
Leon, il marsigliese, andò a prendere l’acqua con
l’elmo: con l’acqua le canne andarono giù più facilmente.
Il Sole scotta fuori dell’ombra della quercia. I calabroni
ronzano sui rossi fiori dell’oleandro e fanno compagnia alle api e alle
farfalle. Le rondini vanno e vengono: strappano un poco di mota dal margine del
ruscello, lo portano in volo e poi lo depositano sul muro della casa per
costruire il nido. Ogni tanto arriva una capinera, fa il bagno e vola via.
Alberco osserva con attenzione e piano piano si calma, si tranquillizza,
socchiude gli occhi. S’addormenta con la testa sul braccio piegato, su un
letto di erbe e muschio. Anche i suoi uomini prendono sonno. Più tardi Lallo e
Marco vengono giù dal loro osservatorio e il loro posto viene preso da Masetto
e Leon. Sino al calare del Sole nulla si è mosso tra loro e la casa. Al
tramonto ecco che esce un uomo che chiama a gran voce:
- Mohammad! Vieni qui!
Dal gruppo di capanne arriva di corsa un uomo dalla pelle
scura:
- Eccomi signore! Cosa volete?
S’avvicina al primo uomo e i due parlottano brevemente e il
moro si allontana. Poco dopo dalla casa escono un bambino, una ragazza e una
donna che porta in mano un cestino; s’avviano alla stalla e ne escono poco
tempo dopo:
- Oggi solo cinque uova! – dice la donna – deve esserci
una volpe o una donnola che le mangiano. Avrebbero dovuto essere almeno dieci.
- Mamma – dice il ragazzo – se ci fossero animali avrei
visto le tracce. E poi le volpi e le donnole non mangiano le uova ma le galline!
- Bravo Tonino! E tu come fai a sapere queste cose? E come
spieghi che con quindici galline ci sono solo cinque uova?
- Me lo ha detto Mohammad, che al suo paese era un grande
cacciatore.
- E tu gli credi? Interviene la ragazza – Lo sai che i mori
sono tutti bugiardi.
Così chiacchierando e scherzando i tre rientrano in casa.
Gonario e Totore prendono il posto di Masetto e Leon e nulla
più avviene intorno alla casa.
3.
Alberco
è a cavallo, l’elmo luccicante, il corpetto di cuoio rosso, la lancia con
l’insegna oro e argento in resta, alla testa dei suoi soldati. Fanti e
cavalieri lo seguono al suono ritmato dei corni e dei tamburi.
-
Non ho capito perché vostra signoria è sbarcata a Teulada – dice il Vescovo,
a cavallo al suo fianco – invece di venire direttamente qui a Cagliari. Il
popolo vi aspettava con impazienza dopo che il governatore Errico vostro zio si
era allontanato dalla città per un equivoco.
-
Eccellenza, mio zio ha riferito al Gran Consiglio di gravi disordini e di aperta
ribellione di Cagliari, non di un equivoco di poco conto e quindi ho ritenuto
opportuno arrivare a Teulada in modo da vedere con i miei occhi la situazione,
avvicinandomi a Cagliari lentamente.
-
E quale impressione avete ricevuto dai fedeli sudditi sardi che avete
incontrato?
-
Tutto bene, monsignore, tutto bene. Non ci sono state feste, ma neppure cattivi
incontri. Sembra proprio che mio zio abbia sbagliato nel giudicare la
situazione.
E
mentre così diceva al vescovo, del quale conosceva le ambizioni, rimuginava fra
sé gli accordi presi dall’ambasciatore presso il Giudice di Arborea: non
appena Alberco fosse sbarcato in Sardegna, trecento fanti e cento cavalieri, con
armi e vettovaglie, si sarebbero uniti alle sue forze per riprendere Cagliari e
rinsaldare l’alleanza fra i due Giudicati.
Era
sbarcato dalle sue sei navi da otto giorni e aveva inviato pattuglie verso tutti
i centri intorno a Teulada, con l’ordine di rimandare indietro corrieri che
riferissero sull’umore degli abitanti. I corrieri avevano tutti riportato
buone notizie: nessun segno di ribellione o di malanimo, i maggiorenti dei
villaggi avevano tutti accolto benevolmente le pattuglie, dando ai soldati da
bere, mangiare e dormire in modo conveniente.
I suoi corrieri andavano e venivano, ma non aveva notizie da
Oristano: non sapeva ancora dov’era la promessa armata di Arborea. E tuttavia
le buone notizie portate dai corrieri lo avevano indotto a iniziare la marcia
verso Cagliari con le sue scarse forze. Le navi lo seguivano tenendosi a debita
distanza dalla riva, sorvegliando il mare per evitare la sorpresa di un vascello
che da Cagliari portasse truppe nemiche.
Tre giorni di sosta hanno rinfrancato gli uomini e reso
Alberco impaziente di iniziare l’azione. Ha requisito sei carri trainati da
buoi e cinque carretti con i cavalli da aggiungere ai sette portati da Pisa. Ha
acquistato farina, lardo, olio, carne di maiale e di manzo e finalmente si mette
in marcia.
Teulada è in una piccola valle circondata da colline non
alte ma erte, la strada è una brutta carrareccia piena di buche e di curve. I
buoi sono lenti e l’avanzata della colonna di uomini e animali procede con
fatica. Alberco è impaziente: lascia 30 cavalieri con i carriaggi e procede più
speditamente, supera il passo, scende a valle e si ferma alle porte di Domus de
Maria a metà del pomeriggio. Tre ore più tardi arriva la carovana dei carri.
Mentre i soldati montano le tende, gli inservienti accendono i fuochi e
preparano il rancio: minestra di grano e fave con lardo. Tre donne
distribuiscono il vino agli uomini che riposano in gruppi serrati intorno al
fuoco, con le armi a portata di mano. I cavalli e i buoi sono stati liberati dai
carri, sono stati abbeverati e a ciascuno è stata servita una buona dose di
orzo, avena e foraggio: ora si muovono lentamente per i campi, ben impastoiati e
sorvegliati.
Dal paese sono usciti alcuni ragazzi che guardano da lontano
quegli uomini strani.
La mattina dopo riprende la marcia e al pomeriggio si
accampano nella piana di Nora. Alberco con i suoi ufficiali alloggia nella torre
e dalla terrazza fanno segnali alle navi che si sono ancorate a poca distanza:
tutto è in ordine. Giunge un messaggero a cavallo che porta una brutta notizia:
4 cavalieri sono morti precipitando in un burrone fra le montagne di Santadi.
Anche nel campo ci sono tre feriti: due uomini si sono affrontati con il
coltello per disputarsi un pezzo di carne di maiale. Si sono feriti loro e hanno
ferito il paciere che aveva tentato di separarli.
La mattina seguente sei fanti sono ammalati. Hanno giocato a
dadi con i loro commilitoni e hanno vinto dodici razioni di vino che hanno
bevuto ubriacandosi. Quindi hanno dormito all’aperto e ora hanno la febbre e
la tosse. Due dei feriti sono morti durante la notte e vengono seppelliti nella
spiaggia, vicino al teatro romano ormai in rovina. Tutto ciò ha ritardato di
molte ore la partenza della carovana e al pomeriggio hanno soltanto scavalcato
l’altura che racchiude Sarroch. Si accampano in riva al mare.
Tre soldati sono originari di questo paese e si recano sugli
scogli a raccogliere patelle e cozze. Con due amici le mangiano e durante la
notte tutti sono colti da vomito e dissenteria: non hanno visto il rigagnolo di
acque luride proveniente dal paese. Anch’essi viaggeranno sui carri insieme al
ferito di coltello e agli altri ammalati.
Il viaggio riprende e l’esercito si ferma a Capoterra e poi
a Uta.
Il giorno prima dell’incontro con il vescovo tutta
l’armata si era radunata nella piana di Assemini, a ridosso dell’argine del
Rio Mannu. Il podestà, con i maggiorenti del paese, era venuto a rendergli
omaggio portando pane e carne e vino per i suoi uomini. Su un carro tirato da
due buoi c’erano 20 sacchi di farina e due grossi maiali appena sgozzati. I
soldati avevano rizzato le tende e poi avevano fatto festa con uomini e donne
venuti dal paese. La mattina all’alba, riuniti e ripuliti, in ordine perfetto,
erano ripartiti: a cinque chilometri dalla città avevano incontrato il vescovo
e gli altri personaggi cagliaritani. Dopo i saluti convenzionali e gli omaggi e
i complimenti sparsi a piene mani, avevano ripreso il cammino e ormai erano ai
piedi della rocca di Castello. Sulle mura c’era gente che salutava e la porta
della Torre dell’Elefante era spalancata: Alberco e i suoi uomini vi si
infilarono con piena fiducia.
4.
Cagliari era allora costituita di diversi nuclei abitati.
Nella valle a nord – ovest, sulle rive dello stagno di Santa Gilla, c’era un
povero villaggio di pescatori che sopravviveva con il commercio delle arselle; a
ovest un altro gruppo di casupole di pescatori a Giorgino; a sud – est sul
promontorio di Cala Mosca, pescatori e artigiani barcaioli che si industriavano
a costruire e rimettere in sesto le barche; a sud, addossate quasi alle mura,
botteghe artigiane di fabbri, di falegnami, di scalpellini, di maniscalchi;
frammiste alle botteghe grandi e piccole stalle per cavalli e asini.
Parte di queste botteghe erano ricavate nelle numerose grotte
che bucano la rocca vera e propria. In questa zona una parte delle case era
costruita con blocchi di pietra tufacea, così tenera che veniva tagliata con la
scure. Quasi tutte le altre abitazioni erano costruite con mattoni di fango
impastato con paglia, oppure pietrame alla rinfusa, pali e fascine di legno.
Il resto della città è costituito dalla rocca, il Castello,
posto proprio in cima alla collina calcarea che domina il porto. Qui nel
castello abitavano i commercianti, i soldati, i nobili, i notai, i medici, gli
impiegati dell’amministrazione, il clero, insomma tutti gli uomini che di più
o di meno vivono sfruttando il lavoro degli artigiani e dei contadini. Nel
castello c’è la Cattedrale e altre sei Chiese, il palazzo del Giudice, una
piccola biblioteca, tre conventi, le prigioni. Tutt’intorno corrono le mura,
che completano l’opera della natura, e rendono inaccessibile l’ingresso al
Castello. Nelle mura si aprono soltanto due porte, quella di S. Pancrazio a est,
alla fine di un’erta salita, e quella dell’Elefante, a sud, proprio di
fronte al porto. Entrambi gli accessi sono difesi da torri merlate ancorate alla
roccia, con robustissime porte a saracinesca.
Passate le porte si apre un dedalo di viuzze, strette e
tortuose, fatte apposta per disperdere in piccoli rivoli gli eventuali
assalitori. Le case sono alte e strette, al piano terreno si trovano le stalle,
le botteghe, le abitazioni dei servi, mentre i padroni abitano i piani
superiori.
5.
I carri trainati dai buoi e dai
cavalli con le vettovaglie e i malati son rimasti alquanto lontani, con i 43
uomini e donne addetti ai carri e alla cucina. Con Alberco ci sono 182 fanti e
46 cavalieri.
L’armata entra in città fra case
alte tre o quattro piani, percorrendo le viuzze strette, acciottolate e
tortuose. I cittadini escono dalle case, salgono dai borghi, i soldati di
guardia scendono dalle mura, la folla precede, accompagna e segue la compagnia
di Alberco. Eccoli tutti in via Corte d’Appello, nella piazzetta della chiesa
di Santa Croce. Un lato della piazzetta è a strapiombo verso lo stagno di Santa
Gilla. Appoggiandosi alla roccia calcarea, 50 anni prima, i pisani avevano
costruito le mura del Castello alte in quel punto oltre 20 metri.
La folla festante stringe gli
uomini e i cavalli, li isola in piccoli gruppi, specialmente donne e bambini si
aggrappano alle armi, molti soldati perdono gli scudi e gli elmi, molti
cavalieri hanno messo piede a terra, rispondono ai saluti e alle feste, sono
felici di essere giunti alla fine del viaggio.
All’improvviso
si ode un urlo – Forza Cagliari! – e spuntano le armi: spade, coltelli,
asce, forconi, spiedi, lance, bastoni, mani nude di donne e di uomini. I
cavalieri non possono muoversi, vengono scavallati da cinque, dieci mani,
strattonati, infilzati. I fanti non possono adoperare né le spade né gli
scudi: la calca è troppo fitta. Venti, trenta uomini sono uccisi in un batter
d’occhio, altri quaranta vengono scaraventati giù dalle mura. Urla inumane si
levano da ogni dove, i feriti sono calpestati dagli uomini e dai cavalli
imbizzarriti. Gli uomini di Alberco sono dispersi in mezzo ai cittadini,
circondati in piccoli gruppi, tentano di fuggire per riorganizzarsi, ma sono
inseguiti e di nuovo circondati da donne e ragazzi come furie, presi per i
capelli, trascinati su e giù per i gradini della Chiesa.
E’
impossibile resistere a quella furia, si arrendono, ma continuano le bastonate e
le coltellate: solo 25 uomini sono quasi illesi; gli altri sono morti o
gravemente feriti.
Si
leva ora alta la voce del vescovo:
-
Pace fratelli, pace. Basta con le armi!
Pian
piano gli animi si placano: si raccolgono i feriti, si ammucchiano sul sagrato i
morti, si disarmano e si legano i prigionieri.
-
Dov’è Alberco? – chiede il vescovo. – Cercatelo e portatelo in Chiesa
sano e salvo.
I
popolani cercano a destra e a manca, rivoltano i cadaveri: Alberco non c’è.
Il vescovo è visibilmente contrariato:
-
E’ un guaio grosso – confida al sacerdote che gli sta vicino – ora non
abbiamo merce di scambio per negoziare la pace con Pisa e avere la protezione
del Santo Padre su questa terra donata da Dio alla Chiesa di Roma.
6.
Alberco ha combattuto con tutte le sue forze, ha ucciso con
il suo spadone 5 cittadini, ne ha feriti altri 4, ma poi ha dovuto arretrare,
stanco e ferito lievemente in sei punti. Si è fatto largo fra i nemici
inferociti, ora li ha solo davanti, nessuno è più alle sue spalle. Ha visto i
suoi uomini cadere feriti o uccisi, buttati fuori dalle mura, arrendersi laggiù
sui gradini della Chiesa; ha capito che la partita è perduta. Rotea la spada
due, tre volte, e i nemici si allontanano da quella furia urlante.
Alberco si volta e fugge, fugge verso la porta che è rimasta
aperta, si precipita giù per la scarpata. Otto cittadini lo inseguono sino alla
porta poi si arrestano: sghignazzano e ridono, urlano parolacce e insulti, ma si
fermano e Alberco può rallentare la corsa.
Quei
bravi cittadini felici di aver costretto il comandante nemico alla fuga sentono
dei passi di corsa alle loro spalle, si voltano con il riso sulle bocche e
vengono investiti da sei uomini armati che li travolgono, li feriscono, li
uccidono e lasciano gli altri sbigottiti.
Sono
sei soldati di Alberco che hanno trovato la forza, il coraggio, l’opportunità
di seguire la stessa via di fuga. Anch’essi si lanciano giù per la scarpata,
vedono lontano il loro comandante e non lo seguono. Arrivano in un canneto sulla
riva del fiume Cixerri e si fermano per consultarsi sul da fare. Sono Leon il
marsigliese, Gonario di Desulo e Totore di Lanusei, Marco, Lallo e Masetto di
Montalto di Pisa. Solo Gonario ha l’armatura completa; agli altri manca la
spada, o l’elmo o la cotta. Sono stanchi per la lunga corsa, hanno paura anche
se non hanno visto inseguitori, sono senza ordini, non hanno un capo, si
conoscono ma non sono amici.
7.
Gonario
viene da Desulo, un paese abbarbicato sulle spalle del Gennargentu.
Il padre è un povero servo pastore: aveva ereditato dal padre un pezzo
di terra che coltivava ad orzo e grano; ma la terra era povera ed egli aveva
scarsa voglia e scarsa esperienza di coltivatore, e perciò si era stancato di
quella vita, si era dato al bere e ben presto aveva dovuto vendere la terra e si
era ridotto allo stato di servo. Un grosso proprietario terriero lo utilizzava
per star dietro alle sue pecore. Non appena Gonario aveva raggiunto i sette anni
il padre aveva passato al figlio il lavoro e trascorreva le giornate
all’osteria, facendo i lavori più umili e degradanti in cambio di un
bicchiere di vino.
Così
Gonario aveva trascorso ben dieci anni, al sole e al vento, alla pioggia e alla
neve, sempre dietro alle pecore, su e giù dalle balze dei monti, avanti e
indietro dalla montagna in estate alla pianura in inverno. Era suo compito
trovare le pasture, difendere il gregge dai banditi, mungere le bestie, portare
il latte alla casa del formaggio, assistere le pecore durante il parto, allevare
gli agnelli e il tutto in cambio del vitto, di poche monete che il padre gli
sottraeva, di qualche agnello che regolarmente moriva mentre quelli del padrone
sopravvivevano. A diciassette anni aveva detto basta al padrone, aveva messo in
un sacco pane e formaggio ed era fuggito a Cagliari. Si era presentato al
comandante della guarnigione ed era diventato soldato.
-
Io e Totore ce ne torniamo a casa – dice Gonario – Meglio servo pastore che
soldato.
Totore
ha una storia del tutto simile. Anch’egli ha alle spalle una vita da servo
pastore nelle campagne di Lanusei. Ma non ha la stessa personalità di Gonario:
in paese ha conosciuto la figlia del suo padrone, una ragazza della sua età,
non molto sveglia né attraente, che ha trovato nel giovane pastore l’unico
compagno con il quale stare.
-
Io non posso tornare a Lanusei. – dice Totore – Mi cercano perché ho messo
incinta la figlia del mio padrone e ho rubato due pecore. Per me è meglio
restare soldato. Almeno mangio e mi pagano e non vado in prigione.
Leon
viene da Marsiglia. E’ figlio del maggiordomo del conte di Artise. E’
cresciuto alto e forte a spese dei resti della tavola del conte, che all’età
di sedici anni lo ha affidato al capo delle sue guardie per insegnarli l’arte
della spada. È diventato così un soldato addetto alla scorta durante i viaggi
del suo padrone. Due volte ha mostrato il suo valore e la sua maestria con la
spada contro i banditi che infestano le foreste del sud della Francia. Il conte
lo ha ricompensato lautamente e lo ha nominato ufficiale del suo piccolo
esercito. Un giorno è passata da quelle parti una compagnia di ventura in cerca
di ingaggio, Leon è rimasto affascinato dai loro racconti di viaggi, battaglie,
scorrerie, guadagni favolosi: abbandona il conte e si unisce alla compagnia. Ma
la vita del mercenario non è facile come gli avevano raccontato. Passano due
anni e la compagnia si scioglie per mancanza di ingaggi.
-
Io non so fare altro che il soldato. – dice Leon – A Marsiglia ho fatto la
guardia del conte di Artise e poi mi sono arruolato come mercenario. Mi dissero
che Pisa cercava soldati ed eccomi qui. Io dico di cercare Alberco e di tornare
con lui. E’ un gran signore, ci ha trattati sempre bene, se lo aiutiamo adesso
ci sarà sempre riconoscente.
Marco,
Lallo e Masetto vengono da Montalto, un paesello vicino a Pisa. Sono amici
dall’infanzia, i loro genitori sono contadini, in piccoli appezzamenti di
terra che non possono sostenere grandi famiglie. Sin da ragazzini hanno lavorato
nelle botteghe degli artigiani, nei negozi dei commercianti, in campagna. Appena
arrivati a sedici anni i genitori li hanno affidati all’esercito. Hanno
lavorato nelle cucine, ai carriaggi e infine sono diventati soldati. Hanno
partecipato, sempre insieme, a diverse battaglie, contro Genova, contro Firenze,
contro Lucca. Ora sono in Sardegna al seguito di Alberco.
-
Noi siamo pisani e anche se Alberco non è la migliore persona di Pisa, vogliamo
restare con lui. – dice Masetto – Io l’ho visto andare verso nord e lo
seguo. Lallo, Marco andiamo subito altrimenti lo perdiamo.
-
Va bene, va bene. – dice Gonario – Aspettate un momento, vengo anch’io,
non ho voglia di andare da solo sino a Desulo!
E’
già passato il mezzogiorno quando si mettono in marcia, e il sole sta già
calando dietro i monti di Capoterra quando raggiungono Alberco che si è diretto
prima a nord e poi ad est, facendo un largo giro intorno a Cagliari. La luna è
sorta da un pezzo quando si acquattano sulla riva del Flumineddu, ai margini di
villa Duccio.
8.
Il vescovo, anzi l’arcivescovo, di Cagliari era Sisinio di
Pietro, nobile e letterato uomo di Sassari, allevato per fare il prete, deciso
sin da giovinetto a scalare il potere temporale della Chiesa. La famiglia tutta
si era data da fare per assecondarlo (- un prete è sempre utile in famiglia!
– era solito dire il padre).
A Sassari, come in molti altri luoghi, c’era un convento di
frati benedettini che allevavano orfani per avere dei servi e tenevano una
scuola per i figli dei nobili e dei ricchi. Il convento si trovava a mezza costa
sulla collina e aveva un vasto terreno tutto intorno. Gli orfani coltivavano la
terra che forniva quanto bastava ai frati per mangiare e bere. La costruzione,
ampia e ben fornita, comprendeva anche dei locali adibiti a scuola e un grande
dormitorio per gli allievi. I genitori dei ragazzi non dovevano preoccuparsi
d’altro che versare la ricca retta e i severi e dotti padri si occupavano di
tutto il resto.
Se poi fra i ragazzi c’era qualcuno con l’intenzione di
far parte del clero, quel ragazzo era seguito con particolare cura: non gli
venivano risparmiate preghiere e punizioni, studio e sermoni, ma anche premi e
privilegi nel vitto e nel lavoro manuale. Le vocazioni quindi si rinforzavano,
sostenute dall’idea della preminenza del sacerdote rispetto a tutto il resto
della comunità civile. Vedere l’abate discorrere liberamente con tono di
alterigia e di comando con le autorità civili e militari, era un ottimo
incentivo a continuare sulla via del sacerdozio.
Durante il noviziato gli allievi servivano a tavola abati,
preti e canonici e si rendevano conto di quanto la vita di costoro fosse più
comoda di quella dei comuni mortali. E così già a 18 anni era in vaticano, a
servire il Papa e a farsi notare per devozione dai potenti prelati della curia.
Ordinato prete a 20 anni, zelante, sapiente più nei rapporti personali che nel
latino, ossequiente verso l’alto, altezzoso verso il basso, duro
nell’amministrare i sacramenti ai poveri, aveva fatto amicizia con una
combriccola di altri sette giovani della sua stessa risma. La loro specialità
era carpire segreti e scambiarseli, facendone poi discreti cenni ai proprietari
di tali segreti, assicurando che non li avrebbero mai traditi. In questo modo
erano diventati buoni e fidati complici di molti peccati.
Il clero in quel tempo non aveva gran cura delle virtù
teologali: più era alto il grado nella gerarchia, maggiore era la licenza dei
costumi, quasi tutti avevano donne e figli, quasi tutti circuivano uomini e
donne anziani che, per redimere l’anima, lasciavano a Chiese e conventi case e
terreni e denari, i cui profitti finivano nelle tasche di canonici e vescovi.
Case e terreni rendevano cospicue somme, perché gli affittuari e i mezzadri
continuamente erano richiamati all’ordine in nome di Dio.
Periodicamente tornava a Sassari e si pavoneggiava con i
coetanei raccontando del lusso e delle ricchezze delle Chiese di Roma, dei suoi
rapporti di amicizia con vescovi e cardinali e principi e marchesi. E il padre e
la madre se ne compiacevano e si gloriavano di quel figlio che cresceva nel
lusso. In queste occasioni faceva visita alle chiese della città, si metteva in
mostra con il clero locale, stabiliva alleanze e amicizie con i suoi pari.
A 30 anni era diventato canonico di una basilica di Roma e
aveva iniziato ad accumulare denaro con le donazioni dei moribondi. A 40 era
vescovo di una città del Lazio e a 50 arcivescovo di Cagliari, capo di tutta la
Chiesa dell’isola, conosciuto e temuto da tutto il clero che aveva continuato
a frequentare in tutti quegli anni di preparazione.
Per quattro anni aveva provveduto a percorrere la Sardegna in
lungo e in largo, facendo conoscere la sua autorità superiore a vescovi e
canonici delle diocesi e agli abati e alle badesse degli infiniti conventi.
Aveva stabilito nuovi limiti alle decime, aveva aumentato le prebende da versare
alla Chiesa primate di Cagliari, aveva aumentato la donazione dell’isola al
Papa, una volta all’anno tornava in Vaticano a rinnovare le conoscenze e le
amicizie. Insomma Sisinio era diventato quasi una potenza, non solo in Sardegna,
ma anche nella Santa Sede: le sue relazioni erano vaste e intrise di rapporti
compiacenti.
La sua opera aveva un solo scopo: portare (lui diceva:
riportare) la Sardegna sotto il dominio totale del Papa. Il suo sogno era
diventare governatore, in nome del Papa, della sua terra natale. E perciò aveva
anche un figlio, ben nascosto con la madre, anch’essa sarda, in un paesino
perso fra le montagne della Ciociaria. Se il suo piano fosse andato a buon fine,
era pronto anche l’erede, da imporre con l’astuzia e la spada, se
necessario. Nei dieci anni trascorsi al momento di imbattersi in Alberco, aveva
accumulato ricchezza, amici e complici.
Errico
era stato costretto a fuggire, Alberco suo nipote era stato sconfitto. Ora era
necessaria un’alleanza con Arborea e un viaggio a Roma per portare in dono al
Papa mezza Sardegna e averne in cambio una vera investitura come alter ego
nell’isola.
Per
non correre rischi bisognava anche liberarsi di Efisio il calzolaio e dei suoi
amici. Efisio era il capopolo che, da Sisinio istruito e incoraggiato e pagato,
aveva provocato decine di tafferugli e proteste fra i pescatori e gli artigiani
e i pastori durante il governo di Errico, il quale, spaventato, era fuggito
nella sua Pisa.
Efisio
può tradirlo e bisogna tagliargli al testa. Ora che la città è in pace
Sisinio lancia la parola d’ordine: Efisio è un figlio del diavolo, ha
corrotto il popolo inducendolo alla sommossa e all’omicidio. Lui stesso,
l’arcivescovo, lo ha sentito bestemmiare durante la battaglia con Alberco, lo
ha sentito ridere mentre uccideva, lo ha sentito incitare con parole blasfeme i
suoi compagni durante la lotta. E ha sentito anche …..
-
Mentre voi buoni uomini del popolo combattevate in nome di Dio, per la gloria
della Chiesa e del Papa, Efisio e i suoi amici erano invasati dal demonio.
Arrestateli e io li libererò da Satana, in nome di Gesù e della Santa Trinità.
Così
diceva Sisinio, dall’altare della chiesa di Santa Croce, un’ora dopo la fine
della battaglia, dopo aver benedetto le salme dei cagliaritani morti. Ma Efisio
non è lì a sentire le parole di Sisinio.
9.
Appena
finita la battaglia, con dieci amici dei più fidati, è corso giù ai piedi del
muro e ora spoglia i cadaveri dei soldati morti. Ci sono lì accanto le
bottegucce di miseri artigiani e le stalle degli asinieri, poveri uomini che
vivono trasportando merci con i loro carrettini trainati da asinelli. Efisio
chiama:
-
Mariotto, vai da zio Gianni e da suo fratello e falli vanire in fretta con i
carretti.
-
Tutt’e due? – chiede Mariotto.
-
Si, si, ma svelto!
Mariotto
corre, si infila fra i rovi che crescono al piede del muro, su un sentiero
coperto di immondizie e di pietre staccatesi dalla roccia, raggiunge la grotta
adibita ad abitazione di zio Gianni e del suo asino. Fuori, appoggiato al muro,
c’è un vecchio carretto. Mariotto chiama e dal buio dell’antro esce un
vecchio, curvo e mingherlino, la barba bianca e lunga:
-
Zio Gianni venite voi e vostro fratello con i carretti, qui dietro sotto il
muro. Efisio il calzolaio vi aspetta per fare un bel carico. Sbrigatevi, abbiamo
fretta!
Mariotto
corre via e l’uomo dà una voce a suo fratello nella grotta accanto, gli
spiega la richiesta ed entrambi attaccano l’asino al carro e si affrettano
all’appuntamento: finalmente si mangia!
Efisio
e i suoi compari intanto hanno spogliato completamente i soldati, lasciandoli
nudi, e caricano tutto sui carretti:
-
Sbrighiamoci ragazzi, prima che arrivi qualcun altro. Mettete sotto gli abiti e
sopra le armi. Portiamo tutto a casa mia. Lì faremo le parti della roba,
oppure, se vi fidate, prima vendiamo tutto e poi ci dividiamo il denaro.
-
Vendi tutto Efisio. – interviene Iulio, l’amico e compare di Mariotto - Io e
Mariotto ci fidiamo di te.
Hanno
quasi terminato quel barbaro lavoro quando arriva trafelato Bisone, cugino di
Efisio:
-
Via tutti in fretta, il vescovo vi vuole arrestare!
-
Perché ci vuole arrestare? - Chiede Efisio stupito per la notizia.
-
Perché la colpa di questi morti qui e degli altri rimasti lassù è tua e solo
tua! Lui non voleva, tu hai bestemmiato, tu eri preda del demonio.
-
Ma se è stato proprio …. – e qui si interrompe Efisio, ha capito il gioco
di Sisinio. – Su ragazzi, raccogliamo tutto e via di corsa!
E’
sul punto di dare una frustata e un calcio al primo asino per farlo muovere,
quando
-
Il mio asino! Il mio carretto! – urlano in coro zio Gianni e suo fratello.
-
Se li volete venite con noi, oppure aspettate che torniamo.
-
Non possiamo venire, a casa ci sono mogli e figli che aspettano! – piangono e
si disperano gli asinieri.
-
Legateli e nascondeteli – comanda Efisio – altrimenti questi due buoni a
nulla ci tradiscono!
Mariotto,
Iulio e altri due lasciano il lavoro sui cadaveri, afferrano gli asinieri, li
legano mani e piedi, uno straccio in bocca e li trascinano in una grotta poco
distante, il cui ingresso è nascosto da un cespuglio di ginestra e di rovo.
Tornano indietro e tutti fuggono verso lo stagno tirando e spingendo asini e
carretti. Senza saperlo seguono le orme di Alberco e i suoi e si fermano a
consulto quasi nello stesso canneto.
Efisio
fa il conto dei suoi compagni: sono rimasti in otto, due di loro se la sono
squagliata, evidentemente sono convinti di cavarsela dall’ira del vescovo.
- Perché Sisinio ce l’ha con noi? – chiede Mariotto, un
giovane, piccolo, nero, stracciato, sporco, magro come un chiodo.
Efisio
parla con tutti, spiega la situazione, maledice Sisinio e tutti i preti che per
mesi gli hanno parlato come ad un pari, dandogli consigli e denari e
assicurazioni:
-
Vi ricordate quante volte noi nove e altri amici abbiamo mandato pescatori e
contadini a protestare in piazza Palazzo? Vi ricordate che alla fine il Giudice
Errico, mandato da Pisa, se n’è andato e noi abbiamo messo i soldati su una
nave e li abbiamo mandati via? Vi ricordate che ogni volta vi ho dato da bere e
da mangiare e anche qualche soldo? Bene, io organizzavo tutto su consiglio di
Sisinio, è stato lui a convincermi a fare tutte quelle cose.
-
E ora – interviene di nuovo Mariotto – vuole dare la colpa a noi? E ci vuole
anche morti!
-
Quei maledetti preti mi hanno adoperato per i loro sporchi giochi, per liberarsi
dei pisani e avere loro il potere si sono serviti di noi. Noi abbiamo rischiato
la vita, molti di noi sono anche morti, e tutto ciò per permettere a quei
disgraziati di diventare più ricchi sulla nostra pelle. Traditore di un
Sisinio! Demonio d’Inferno è lui!
Tutto
il gruppo commenta in modo osceno queste parole di Efisio e tutti giurano
vendetta contro Sisinio.
Efisio
lascia che i suoi compagni si sfoghino e poi riprende la parola:
-
Secondo voi cosa dobbiamo fare? Se torniamo in città ci torturano e poi ci
impiccano in nome di Dio. Se restiamo qui prima o poi ci trovano e il nostro
destino non cambia.
-
Possiamo fare i banditi. – propone Iulio, grande e grosso, con una gran barba
nera e i capelli lunghi tenuti con uno spago, pescatore di professione, ma con
il desiderio di una vita libera e avventurosa, più facile delle fatiche imposte
dalla pesca.
A
quel tempo, e per molti secoli ancora, la Sardegna è quasi completamente
coperta di foreste, spesso impenetrabili, regno incontrastato di cervi, mufloni
e cinghiali. Le pianure sono solo in parte coltivate, le pecore e le capre sono
diffuse ovunque e vanno al pascolo brado. In molti luoghi anche i maiali sono
allevati semi liberi e si nutrono di ghiande e di erba in campagna. Foreste e
grotte sono rifugi non solo di pastori ma anche di banditi di strada, che vivono
di caccia e di assalti dei pochi viaggiatori e dei villaggi, piccoli e isolati.
Solo intorno agli abitati più grandi c’è la sorveglianza armata dei
barracelli che limita le scorrerie.
-
Iulio, non dire sciocchezze! Qualcuno di noi sa cosa vuol dire fare il bandito?
Noi siamo sempre vissuti in città, abbiamo sempre avuto paura di trovarci da
soli in campagna e ora vogliamo vivere in giro per i monti e in più magari
rapinare la gente che passa? E se incontriamo un pastore siamo capaci di
affrontarlo? E dove troviamo da bere e da mangiare?
-
Io me la sento di affrontare chiunque! Non ho paura di nessuno, io!
-
Senti Iulio – interviene Mariotto – una cosa è rubare ad un vecchio che non
si regge in piedi, un’altra è trovarsi di fronte un pastore armato o un
bandito vero: appena ti muovi ti ritrovi un coltello nella pancia e non sai
neppure perché. Immagina di avere davanti un contadino armato di roncola, con
uno o due cani che lo aiutano: che fine fai?
Iulio
insiste ancora un poco ma alla fine, preso anche in giro da tutta la compagnia,
deve convenire che forse l’idea di fare il latitante, ricercato dai soldati e
dai barracelli non è la migliore.
La
discussione fra questi uomini in pericolo è lunga, tortuosa, le soluzioni
vengono esaminate e riesaminate, le idee vanno e vengono e il tempo passa. Ecco
già l’imbrunire e finalmente la decisione su consiglio di Efisio:
-
Ragazzi, noi abbiamo ucciso soldati di Pisa. Su in Gallura c’è un Giudice
amico dei pisani e dei genovesi. Andiamo da lui: vedrete che ci accoglierà
bene. Muoviamoci subito, prima che qualcuno esca da Cagliari e venga ad
arrestarci. Prendiamo le armi, ci rivestiamo con questi abiti, lasciamo i
carretti e via con gli asini. La strada è lunga e faticosa, queste bestie ci
saranno utili per portare i pesi. Ormai è quasi buio, passiamo da Giorgino dove
c’è un forno. Entriamo, rubiamo pane e farina e poi via di corsa verso Olbia!
10.
Efisio è un calzolaio, figlio di calzolaio e nipote di
calzolaio. Il padre è morto da 15 anni di peste. Ha ormai 32 anni e la sua
bottega serve gran parte dei signori di Cagliari e in particolare il clero. Da
ragazzo ha servito messa nella Chiesa di S. Eulalia, acquistando la fiducia del
parroco. Quando aveva 12 anni venne a bottega un sacerdote ancora giovane che
raccontava a suo padre le meraviglie dei palazzi del Papa, lasciandoli
incantati. Due anni dopo quel sacerdote fu di nuovo chiamato a Roma e portò con
sé Efisio.
Il
ragazzo rimase affascinato dalla vita di corte, fu preso alle dipendenze di un
cardinale per tenergli in ordine le scarpe e visse in casa sua per due anni. La
servitù di Monsignore rimase incantata dal giovane sardo e lo faceva parlare
della sua terra. In cambio gli insegnarono le buone maniere, gli parlarono di un
poco di storia, gli raccontarono che la Sardegna apparteneva al Papa. Efisio era
grato al sacerdote che lo aveva portato a Roma e al cardinale che lo teneva in
casa e desiderava sdebitarsi in qualche modo per cui dava una mano agli altri
servi, era sempre pronto agli ordini del porporato, non gli sembrava vero di
poter fare le commissioni da una parte all’altra della città.
Ma ecco che gli giunge una lettera del padre, un domestico
gliela legge: il padre è malato, la madre e i fratelli sono alla fame. Efisio
va dal cardinale il quale gli da la sua benedizione, qualche moneta e lo fa
imbarcare per la Sardegna. Torna alla bottega e si mette al lavoro per mantenere
la famiglia. Pochi mesi dopo il padre muore e la madre si ammala a sua volta.
Seguono i due fratelli, falciati tutti dalla peste.
Efisio è rimasto solo, frequenta la Chiesa di S. Eulalia e
diventa quasi intimo del nuovo parroco. Il quale parla di lui a tutti i
colleghi, finché la fama di Efisio, della sua religiosità, delle sua dedizione
alla causa del Papa, giunge alle orecchie di Sisinio, l’arcivescovo che ha già
elaborato il suo piano per diventare quasi re di Sardegna. Sisinio lo chiama nel
suo palazzo, gli parla a lungo, sonda le sue idee, gli sembra che quel giovane
sia lo strumento ideale per realizzare i suoi piani.
Sisinio ha come segretario un giovane sacerdote di Sassari,
suo concittadino quindi, con il quale ha stretto una alleanza di ferro con la
promessa di nominarlo vescovo e segretario del governo. Questo prete va e viene
dalla bottega di Efisio portando ad aggiustare scarpe nuove. Convince
l’operaio a preparare una banda di giovani come lui pronti a combattere contro
i pisani per rendere la Sardegna a Sua Santità. Efisio si lascia convincere
facilmente e facilmente trova una dozzina di compagni sfaccendati che in cambio
di qualche moneta e di qualche bicchiere assicurano il loro appoggio alla causa
dell’arcivescovo.
Era
allora governatore del giudicato di Cagliari Errico, zio di Alberco. Efisio e i
suoi compari sobillano i pescatori che protestano per le riserve di pesca,
sobillano i contadini e i pastori che protestano per le requisizioni di pecore e
di maiali, sobillano gli asinai che protestano per le tasse sui trasporti.
Errico ben presto si stanca di quella provincia sempre in rivolta, si stanca di
chiedere invano a Pisa di mandargli altri armati per tenere a freno i ribelli e,
lasciato l’incarico al suo segretario, ritorna in patria per perorare dal vivo
davanti al Gran Consiglio le sue richieste.
Due
giorni dopo la sua partenza Efisio e i suoi uomini, per incarico segreto di
Sisinio, fanno nascere una vera rivolta. La folla inferocita uccide il
segretario, imbarca i pochi soldati pisani su una nave e li spedisce in Toscana.
Il governo, per volontà del popolo guidato dai congiurati, viene affidato a
Sisinio che è la massima autorità in città. Passano sei mesi in febbrili
consultazioni con Pisa, con Arborea, con il Papato. Pisa non vuole sentire
ragioni e invia Alberco dopo essersi alleata con Arborea.
11.
E’
ormai notte. Alberco chiama i suoi a raccolta:
-
Soldati, è arrivato il momento. Le luci in casa si sono spente da un pezzo, non
è entrato nessuno e quindi dentro ci devono essere solo i quattro che abbiamo
visto questo pomeriggio. Farli prigionieri sarà molto facile. Ora vi spiego
come faremo.
Piano
piano, in silenzio, chini, si infilano in un filare di viti e si accostano alla
casa. Guardano a destra e a manca. Si portano sul lato destro della casa per
essere al riparo dalla vista delle capanne degli operai. Accostano l’orecchio
ad una finestra. Non si odono rumori. Accanto alla finestra c’è una porticina
mezzo sgangherata. La forzano in due, spingendo, e quella si apre con uno
scricchiolio. Non entrano, ma due si appostano a sinistra e due a destra, gli
altri tre di fronte all’apertura, accovacciati a terra. Ecco che appare una
luce e dietro di essa un uomo: esce di un passo dalla porta. Lallo e Marco da
una parte, Gonario e Leon dall’altra lo afferrano per le braccia, lo
scaraventano a terra, gli tappano la bocca. Il lume, una candela di sego in un
piattino di legno, cade ma resta accesa. L’uomo è un vecchio dalla testa
bianca, ma vigoroso, si ribella ma nulla può contro i quattro che lo tengono
saldamente.
Alberco
scatta in avanti, gli punta la spada alla gola, gli sussurra – zitto! – e lo
fa rialzare. Totore tira su la candela e tutti insieme, il padrone di casa in
testa, la spada alla schiena e un coltello alla gola, entrano in casa. Si
trovano in un corridoio ampio illuminato da un lume a olio appeso al muro; tre
porte chiuse e una aperta vi si affacciano. La comitiva si ferma e Alberco
chiede all’orecchio del padrone di casa:
-
Quanti siete?
Quello
non risponde e Lallo spinge il coltello nel collo. L’uomo alza la mano e
mostra quattro dita.
-
Dove sono? – chiede Alberco – Chiamali! – Gli toglie il bavaglio.
–
Armina, Tonino, Giannina! Venite qui in corridoio! – chiama.
Alberco
gli ficca di nuovo lo straccio in bocca. Dalla porta aperta si affaccia la donna
anziana, con una lunga veste nera, i capelli grigi scarmigliati
–
Cosa c’è, Duccio? –
Vede
gli uomini attorno al marito, fa per urlare e rientrare in camera: Totore e
Gonario le sono addosso, la strattonano facendola cadere. La donna emette un
gemito, inizia a piangere. Dalla porta di fronte esce il ragazzo, assonnato:
spalanca gli occhi e resta immobile sulla soglia. Dall’altra porta ecco la
fanciulla con i neri capelli lunghi sciolti sulle spalle e una lunga veste
bianca
–
Mamma! – grida e le si inginocchia accanto e l’abbraccia.
-
Silenzio tutti e buoni, altrimenti quest’uomo muore! E voi subito dopo! Non
vogliamo farvi del male. Vogliamo mangiare e poi ce ne andremo. Dov’è la
cucina?
La
voce di Alberco è quella di chi è abituato a comandare, e il coltello alla
gola di Duccio ha la voce di chi è abituato a farsi ubbidire. Armina, con
l’aiuto di Giannina, si alza e il corteo si infila nell’ultima porta ed
entra in un vasto ambiente con un grande camino in un angolo e un ampio tavolo
al centro. Alcune sedie e sgabelli sono allineati contro le pareti.
-
Masetto e Leon legate l’uomo e il ragazzo alle sedie e tu Lallo tieni il
coltello vicino al ragazzo. Voi signora preparate da mangiare: abbiamo molta
fame.
Giannina
si occupa di fermare e lavare il sangue dalla gola del padre e Armina prepara da
mangiare per gli ospiti. Quando Duccio recalcitra, Lallo punzecchia con il
coltello le braccia e il viso di Tonino.
Trascorre
il tempo, gli uomini mangiano e bevono, a turno si sdraiano sui materassi
portati dai letti in un angolo della cucina. Alberco chiacchiera ancora con
Duccio, gli chiede notizie sui maggiorenti di Cagliari. Finalmente si presenta e
Duccio mostra gran meraviglia a sentire il suo nome:
-
Ma io vi ho conosciuto quando eravate un ragazzo!
-
Come? – si meraviglia a sua volta Alberco.
- Io sino a 8 anni or sono ero capitano dei lancieri di Pisa
di stanza a Cagliari! Vi vidi quando veniste in città con vostro zio Errico,
che era allora vicegovernatore. La città era in pace e noi soldati avevamo
abbastanza poco da fare. Perciò riscattai dalla Repubblica questa fattoria che
era stata requisita ad un sardo ribelle, mi congedai e da allora faccio il
contadino. Non mi occupo più né di guerra né di politica.
-
Mi aiuterete a riconquistare Cagliari?
-
Perdonatemi signore, ma non me la sento di riprendere le armi: sono vecchio e
devo pensare a questa mia famiglia. Come vedete ho due ragazzi che dipendono
totalmente da me. E poi ormai mi sento più sardo che pisano.
12.
Duccio da Montepulciano sin da ragazzo aveva mostrato un
carattere forte e deciso. A sedici anni aveva lasciato la famiglia e si era
aggregato ad una compagnia di fanti mercenari. Aveva fatto lo sguattero aiutando
le donne in cucina, si era allenato con le armi con un veterano, aveva imparato
l’arte del comando partecipando alle battaglie per le quali la compagnia
veniva ingaggiata, in Italia, in Francia, in Spagna. Era andato sino in Marocco
a liberare un gruppo di prigionieri cristiani in mano ai mussulmani. Si era
sempre distinto per coraggio e per capacità di organizzazione.
A 30 anni era tornato a Pisa con una buona fama ed era stato
chiamato nell’esercito della Repubblica con il grado di capitano. Aveva
partecipato a tante battaglie contro Genova, contro Firenze, finché era stato
mandato a Cagliari al seguito di Errico per organizzare la difesa della città.
I sardi gli avevano dato poco da fare dopo i primi due anni: pattuglie
regolarmente battevano i villaggi vicini, i ladri quasi sempre venivano presi e
impiccati, le proteste dei contadini erano facilmente represse. Duccio ormai
passava molto tempo nel palazzo del governatore ad organizzare feste e viaggi di
piacere per gli ospiti volontari e per le persone importanti, ma ingombranti a
Pisa, che venivano quasi esiliate in Sardegna.
Durante
la permanenza a Pisa aveva sposato Armina ed era nata Giannina, appena arrivato
a Cagliari era nato Tonino. La mancanza di azione, la noia delle feste a
palazzo, la famiglia ormai fatta, avevano indotto Duccio a lasciare il servizio
attivo e a ritirarsi in campagna. Era stata una vera fortuna: quella proprietà
l’aveva vista durante una visita di poca cortesia al suo proprietario che
aveva avuto la faccia tosta di presentarsi ad Errico per chiedere una riduzione
delle tasse. Duccio era stato incaricato di andare a vedere sul posto lo stato
della proprietà che gli era subito piaciuta.
Il
governatore aveva chiamato il padrone per raddoppiargli il tributo, al che quel
pover’uomo si era ribellato tentando di sguainare la spada nella sala delle
udienze: Duccio lo aveva disarmato e portato in prigione. Una settimana dopo era
stato decapitato e la sua proprietà confiscata, moglie e figli portati in città
e abbandonati a vivere di elemosina. Quell’esempio di giustizia sommaria e
rapida aveva sconsigliato per molti anni tutti gli altri proprietari dal
lamentarsi del carico fiscale.
Ben
presto Duccio era stato preso dal desiderio di ritirarsi a vita privata. Aveva
parlato dei suoi progetti con Errico (e in quella occasione aveva conosciuto
Alberco) e aveva ottenuto di riscattare quella proprietà per una somma non
troppo elevata come ringraziamento per aver servito la Repubblica con fedeltà e
capacità. Da allora viveva in campagna, dedicandosi con le forze che gli erano
rimaste allo sviluppo della proprietà.
Al
suo servizio aveva sette operai, due dei quali erano mori cristiani, liberati
tanti anni prima in Marocco insieme ai prigionieri bianchi. Quei due si erano
fatti mandare in Sardegna dove si trovava già una piccola colonia e il caso
aveva voluto che ritornassero alle dipendenze del loro liberatore. La
riconoscenza dei due mori era grande ed erano diventati i punti di forza
dell’azienda.
Villa
Duccio aveva intorno 50 ettari di terra dove si coltivava la vite e il grano e i
ceci e le lenticchie per gli uomini e l’orzo e le fave e l’avena per gli
animali, si raccoglieva il fieno e la paglia, si piantavano e si tagliavano gli
alberi per il fuoco, in una parte si coltivava il lino per gli abiti e si
allevavano le pecore per la lana e il latte e il formaggio: molto lavoro e poche
comodità era il motto di tutti. Ma questo aveva permesso a Duccio e ai suoi
uomini di avere buone scorte nei magazzini e di poter pagare le decime alla
Chiesa e le tasse al governo e sopportare un paio di razzie da una banda di
tagliagole barbaricini che infestava periodicamente i villaggi del Campidano.
-
Per tutto questo, signore, non posso aiutarvi. Prendete tutto quel che vi serve,
ma io non voglio apparire vostro complice agli occhi di chiunque governi ora il
Giudicato. Ho già servito a lungo Pisa e non voglio mettermi nei guai con i
nuovi padroni. La mia vita è qui, devo pensare ai miei figli e al loro
avvenire.
-
D’accordo Duccio, farò in modo che nessuno possa accusarvi di nulla. Ora però
noi resteremo qui ancora un giorno e poi ce ne andremo. Mandate vostra figlia a
chiamare il vostro aiutante di cui vi fidate.
-
Giannina, vai a chiamare Mohammad. Che venga subito da solo.
Mohammad
è quasi vecchio, arriva trafelato, nella sua sottana lunga sino ai piedi e
scalzo. Quando vede gli uomini di Alberco e il suo padrone ancora legato si
butta in ginocchio, pregando di lasciarlo andare.
Duccio
lo chiama a sé e lo rincuora:
-
Non aver paura Mohammad, non ti faranno del male. Ora ascolta bene quello che ti
dirà questo signore e fai come se te lo dicessi io.
13.
Il
piano è semplice e quindi ben congegnato: Duccio, Tonino e Giannina partiranno
con Alberco e i suoi uomini all’alba del giorno dopo. Armina e Mohammad
andranno in giro dicendo che il padrone è malato, che sono arrivati degli amici
che lo porteranno in città per farlo curare. Giannina e Tonino saranno ospiti
di quegli amici e torneranno con il padre quando sarà guarito. Duccio e
Giannina andranno a cavallo, l’asino sarà attaccato al carretto caricato di
provviste. Mohammad sarà il capo degli operai e curerà la proprietà come
sempre.
Stabilito
tutto ciò Armina e Mohammad escono e vanno a dare le notizie agli altri operai
nelle loro capanne, raccomandando che nessuno si avvicini alla casa per non
disturbare il padrone. Il giorno passa, viene la notte e poi l’alba. La
comitiva esce di casa e si avvia secondo il piano preparato. Duccio è legato
alla sella, Tonino è legato sul carro, Giannina sembra una gentildonna sul suo
cavallo. Alberco e i suoi sono in parte davanti e in parte dietro gli animali.
Sul carro c’è pane, farina, olio, vino, prosciutto, lardo, formaggio, una
piccola brocca di latte, due grandi brocche d’acqua e un sacco di fave per gli
animali. Sembra davvero una comitiva di amici in viaggio di piacere.
Uscirono
dalla proprietà prendendo la strada per Cagliari, ma appena fuori dalla vista
di villa Duccio, per una strada che era quasi un sentiero, voltarono verso le
montagne che li avrebbero accompagnati a nord sino ai piedi del Gennargentu.
Percorsero
non più di venti chilometri al giorno, tenendosi il più lontano possibile dai
piccoli villaggi lungo il percorso, aiutati da Gonario e da Totore che un poco
conoscevano la regione. Qualche volta la via era decisa dallo stesso Duccio che
aveva più volte guidato i soldati in pattuglia in quei luoghi non sempre
pacifici.
Alla
sera del quarto giorno Alberco chiama i suoi a consiglio fuori dal rifugio:
-
Duccio e Tonino ci ritardano la marcia. Vorrei liberarmene. Cosa consigliate?
-
La cosa più semplice è ammazzarli tutti. – propone Masetto – Così volendo
possiamo anche correre!
-
No – si oppone Gonario – mi sembra inutile. Secondo me, se li trattiamo
bene, il capitano Duccio potrà esserci utile quando torneremo a Cagliari.
Rimandiamo indietro padre e figlio e teniamo la ragazza. La madre non ci ha
denunciati perché avevamo i figli e il marito con noi. Il padre non ci denuncerà
perché avremo ancora la figlia.
-
Bene Gonario, il tuo consiglio mi pare ottimo. Vado a parlare con Duccio.
Quella
sera erano accampati tra le mura di una casa semidistrutta. I tre prigionieri
erano legati gli uni agli altri con una fune ben stretta alle loro caviglie.
Alberco rientra e si siede a terra di fronte a Duccio:
-
Sentite Duccio, noi abbiamo bisogno di andare più veloci e in più siamo
troppi. Domani mattina voi e vostro figlio tornerete a casa. Giannina resterà
con noi come ostaggio, così non sarete tentato di mandarci dietro i soldati di
Sisinio.
-
Don Alberco – dice Duccio piangendo, dopo un momento di smarrimento a quella
notizia – Don Alberco, non fatemi questo, lasciatemi venire con voi, oppure
lasciate andare i ragazzi: io resterò con voi, camminerò più in fretta,
correrò se è necessario, ma lasciate andare loro, resterò io, vi prego, siate
buono, Dio vi ricompenserà!
-
Duccio non piangete, siete un soldato! Voi capite che non posso mandare i
ragazzi da soli: si perderebbero, potrebbero fare cattivi incontri. E’ molto
meglio che siate voi ad andare con uno di loro, per sicurezza. Vostra figlia
Giannina con noi non correrà nessun pericolo, questo ve lo giuro sul mio onore
di soldato. Non le accadrà alcun male. Avete visto in questi giorni che i miei
uomini si sono affezionati a lei, che tutti la considerano una figlia.
Duccio
prega e implora, promette e giura ma Alberco è irremovibile.
-
Quando la libererete? – chiede Duccio, ormai rassegnato.
-
Lascerò vostra figlia in un convento vicino a Nuoro fra quattro settimane e
intanto nulla le accadrà, ve lo prometto di nuovo.
Il
mattino dopo Alberco lasciò ai due malcapitati pane e formaggio, la brocca che
aveva contenuto il latte, li legò ad un albero in modo che potessero
sciogliersi facilmente e ripartì:
-
Se vi vedo tornare ammazzerò Giannina! Badate bene Duccio, tornate a casa e
silenzio con tutti!
Duccio
e Tonino rimasero soli, si liberarono e piangendo e sostenendosi e confortandosi
a vicenda presero la via di casa orientandosi con il sole, come ogni buon
soldato sa fare. Dopo una settimana erano a villa Duccio e con Armina, felice di
riavere almeno un figlio, ripresero a piangere e a sospirare e a temere per
l’altra figlia.
Passate
due settimane Duccio comprò tre cavalli, caricò un poco di provviste e con
Mohammad per compagno partì verso nord, visitò tutti i conventi di suore dei
paesi intorno al Monte Albo e finalmente si ritrovò Giannina fra le braccia a
Nuoro.
14.
Il viaggio era terribile: le montagne seguivano alle
montagne, le foreste alle foreste, le strade quasi inesistenti, piene di buche e
dossi, solcate profondamente dalle piogge, cosparse di sassi franati dalle
alture. Qualche volta gli uomini dovevano sostituirsi all’asino nel trainare
il carro. Ogni quattro o cinque tappe si fermavano a riposare per un intero
giorno in una grotta. Allora potevano accendere il fuoco e cucinare e preparare
un poco di pane, cotto sulle pietre arroventate. I cavalli e l’asino, legati a
lunghe funi, potevano brucare la poca erba fra gli alberi, mangiare le ghiande e
un pugno di fave, e anche loro riposare.
Giannina
non pensava assolutamente a fuggire (e dove poi avrebbe potuto arrivare?) anche
perché a casa sia il padre che la madre che i contadini della villa non
raccontavano che storie terribili di banditi che si divertivano a torturare in
tutti i modi le fanciulle sulle quali mettevano le mani. Gli uomini che la
circondavano erano tutto sommato persone gentili ed educate, abituate alla
disciplina militare che Alberco in qualche modo faceva rispettare anche in
quelle misere condizioni.
Alberco
poi in certo qual modo la affascinava: era un bell’uomo, gentile, premuroso,
dispiaciuto del disagio che le procurava, pieno di promesse sulla sua incolumità.
La sera, prima del pasto, le raccontava dei suoi viaggi, delle bellezze di Pisa,
di Firenze, di Roma. La fantasia di Giannina correva lontano dai luoghi dove si
trovava, chiedeva e chiedeva nuovi particolari, beveva le descrizioni di Alberco
e ne voleva ancora altre.
Dopo
altri 12 giorni di marcia a mezzo pomeriggio si ritrovarono in prossimità di
Gavoi, su un pianoro che guardava il paese. Si accamparono dentro un nuraghe
ancora in buone condizioni. Nascosti da quelle poderose mura, in mezzo ad un
fitto bosco di querce, pini e carrubi, potevano stare tranquilli.
-
Signore – disse Gonario, seduto su un masso, la schiena appoggiata al
ciclopico muro, la pancia finalmente piena – siamo vicini a Nuoro. Forse è
arrivato il momento di liberare Giannina e di sentire qualche notizia. Siamo
partiti da tre settimane e quaggiù in paese sapranno certamente qualcosa.
-
Hai ragione Gonario. Qui dentro siamo al sicuro e possiamo restare qualche
giorno. Domani tu scendi in paese e senti cosa si dice in giro.
15.
Il
giorno dopo Gonario si spogliò di tutti i simboli di soldato ed entrò in paese
per sapere le novità.
Gavoi
è un piccolo paese accoccolato su un colle roccioso che domina una vallata
stretta e lunga ad arco di cerchio . Alle sue spalle svetta il Gennargentu la
cui cima si intravede dopo una lunga serie di balze che si inerpicano l’una
sull’altra. Le strade sono tortuose e acciottolate. Le case verso valle hanno
due piani, verso monte uno solo; il piano basso serve come magazzino e stalla,
quello superiore è l’abitazione umana.
Gonario
ha una sacca in spalla e cammina lentamente guardandosi attorno. Ad una svolta
c’è un piccolo slargo davanti ad una bettola che inalbera la sua insegna: un
ramo di palma. Addossate al muro ci sono quattro sgabelli, costruiti con fogli
grezzi di sughero, occupati da uomini anziani. Accosciati con la schiena
appoggiata alla parete altri due uomini ancora giovani, con la berritta calata
indietro. Tutti chiacchierano fra loro. Gonario s’avvicina con deferenza al più
vecchio e lo saluta:
-
Salute, zio. Posso offrirvi da bere?
-
Salute a te. Perché vuoi offrirmi da bere?
-
Vorrei qualche informazione, zio. Vengo da lontano e non conosco nessuno qui in
paese.
-
Da dove vieni? – chiede uno dei giovani.
-
Vengo da Sanluri, ero soldato, ora mi sono congedato e cerco lavoro. Potete
aiutarmi?
-
Forse si. Ma andiamo a bere prima. – interviene un altro degli anziani.
Entrano
tutti nel locale, piccolo e non certo pulito. Dentro c’è ben poca luce che
penetra a fatica da una finestrella aperta nello spesso muri di pietra. Un forte
odore di muffa e di vino pervade il locale. Un grosso banco di noce appena
squadrato arreda il locale, sul fondo un’apertura stretta conduce ad un antro
buio: certo è la cantina scavata nella roccia.
Al
banco c’è una vecchia magrissima, tutta vestita di nero, con un grande
scialle pure nero legato sotto il mento, che le copre la testa.
-
Cosa volete? – chiede la vecchia.
-
Da bere per tutti, zia! – grida allegramente Gonario.
Da
una mensola appiccicata al muro scendono sul banco sei bicchieri di latta che la
vecchia riempie da una botticella in piedi su un rocco di quercia. Ciascuno
degli uomini riceve un bicchiere e va a sedere su una panca che corre lungo la
parete del locale. Quando tutti sono serviti e seduti e si è scambiato
l’augurio – Salute! - e i bicchieri sono a metà, il più anziano chiede:
-
Come ti chiami e di dove sei?
-
Mi chiamo Gonario e sono di Desulo. Ho quasi finito i soldi e vorrei lavorare
per guadagnare qualcosa prima di arrivare in paese.
-
Io e questo mio compare – e indica uno degli altri anziani – possiamo
aiutarti se hai davvero voglia di lavorare.
-
Ho voglia e necessità di lavorare zio. Ma permettetemi di offrirvi ancora da
bere.
Gli
altri capiscono che ormai lo straniero è preda di quei due, escono e li
lasciano soli. Gonario fa riempire di nuovo i due bicchieri e si siede accanto
ai due vecchi.
Al
terzo bicchiere i due sono diventati suoi amici per la vita, e gli raccontano
vita morte e miracoli di tutti gli abitanti di Gavoi nonché le ultime notizie
dal mondo. Tutti sapevano della battaglia di Cagliari, della fuga di Alberco,
del vescovo Sisinio che era diventato in pratica Giudice, di Arborea che aveva
preferito non entrare in quella guerra perché aveva paura di irritare gli
Spagnoli. Niente però sapevano del rapimento di una famiglia. Rassicurato sulla
lealtà di Duccio, Gonario prende accordi:
-
Zio, vi ringrazio molto per il lavoro che mi avete proposto. Domani o dopodomani
verrò per darvi una risposta. Ora vi saluto, vado a casa di un mio cugino che
abita vicino a Sarule. Mi dite dove posso comprare un poco di pane?
-
Vai più su e trovi il forno. Arrivederci.
Gonario
compra il pane ed esce dal paese; lungo la via del ritorno vede un pastore
intento alla mungitura, si ferma e compra un orcio di latte. Tre ore dopo è al
campo e Giannina gli è grata per il pane e per il latte.
Le
notizie portate da Gonario hanno confortato Alberco: per ora tutto va bene,
nessuno corre loro dietro, ormai sono vicini alla meta. Si devono liberare di
Giannina e poi via verso Olbia e la civiltà e la vendetta.
Il
giorno dopo Gonario mise una bisaccia con pane, formaggio e carne arrostita
dietro la sella di un cavallo, fece montare Giannina, prese le redini in mano e
si avviò verso il paese. Giannina salutò tutti quasi con rimpianto mentre il
cavallo andava tranquillo al seguito di Gonario. Attraversarono Gavoi e Orani e
finalmente a sera tarda si presentarono al portone del convento delle Clarisse
di Nuoro. Gonario raccontò alla badessa che Giannina era in viaggio per
raggiungere il padre, che costui era in ritardo all’appuntamento e quindi
chiedeva la cortesia di ospitare la giovanetta finché non fosse arrivato il
genitore. Diede alla Madre una moneta d’oro, cosa che la convinse pienamente,
e se ne andò. Montò a cavallo e prese la via del ritorno. Si fermò in una
osteria alla periferia del paese, offrì da bere a un pastore che gli raccontò
le ultime notizie, poi andò a dormire nella stalla vicino al cavallo. Il giorno
dopo, prestissimo, montò in sella e prima di sera era di nuovo al fianco di
Alberco.
16.
Torchitoro
è Giudice di Arborea da otto anni. E’ succeduto al padre Mariano che ha
governato Oristano per ben 22 anni, intessendo rapporti di amicizia o non
belligeranza con gli altri tre Giudicati, con il regno di Castiglia e quello di
Aragona.
Torchitoro
sa bene che la Spagna, Genova, Pisa, il Papato hanno mire di conquista
sull’isola. Suo padre ha dovuto fare concessioni, ma in fondo il Giudicato può
ancora considerarsi forte e sovrano.
Pisa
gli ha chiesto aiuto per riconquistare Cagliari dopo la ribellione contro Errico
ed egli è stato soddisfatto di questa richiesta: significa che il suo Giudicato
è considerato, almeno da Pisa, un alleato forte e influente.
-
Signor ambasciatore, riferite al Gran Consiglio che il Giudicato di Arborea è
onorato di poter contribuire con le sue forze al ristabilimento della legalità
nella città di Cagliari. Voi ben sapete che Oristano è favorevole al
mantenimento dello statu quo e perciò ha stabilito buone relazioni con tutti.
La nostra più fervida speranza è che tutto ritorni allo stato iniziale.
-
Signor Giudice, la Repubblica che rappresento ha sempre avuto un occhio di
riguardo alla politica di Oristano. Vostro padre ha stretto legami ben saldi con
Pisa e anche voi vi siete mantenuto entro le linee tracciate da lui. Di ciò la
Repubblica vi è grata.
-
Ringrazio il Console per la considerazione del ruolo di Arborea. Venendo alla
situazione attuale, signor ambasciatore, la richiesta di 600 fanti e 200
cavalieri è davvero fuori delle nostre possibilità. Voi sapete che questo
Giudicato è piccolo e povero e non può sobbarcarsi un simile peso militare e
finanziario. Tuttavia, poiché l’amicizia di Pisa è importante e necessaria,
vi forniremo ciò che è nelle nostre possibilità e cioè 300 fanti e 100
cavalli, che opereranno sotto il comando del generale Carlo alle dipendenze del
vostro generale Alberco, come mi avete annunciato.
-
Giudice, la vostra offerta è inferiore a quanto la Repubblica aveva chiesto.
Tuttavia io la trasmetterò al mio governo nella speranza che essa sia accettata
di buon grado.
-
L’impegno da noi assunto è il massimo che Arborea possa mettere in campo.
Avvertitemi con un mese di anticipo sull’inizio delle operazioni, in modo che
si possano fare i preparativi necessari. Quando il vostro esercito sbarcherà,
noi saremo pronti a raggiungervi.
17.
Sono
passati quattro mesi da questo accordo, quando l’ambasciatore di Pisa chiede
un nuovo colloquio con Torchitoro:
-
Giudice, il generale Alberco con l’esercito sbarcherà a Teulada fra quattro
settimane.
-
Bene, signor ambasciatore. I nostri 300 fanti e 100 cavalieri aspetteranno
l’ordine di entrare nel Giudicato di Cagliari accampati nelle campagne di
Uras. Voi avete una guarnigione a Sardara: il generale Carlo invierà un
messaggero alla guarnigione quando sarà in posizione.
18.
Arborea
non ha una gran flotta: nessuno dei quattro Giudicati che governano l’isola ha
mai avuto mire di espansione fuori della Sardegna. Possiede otto navi
relativamente piccole che sono costrette a pattugliare il mare occidentale con
continuità: tre navi a turno sono sempre in navigazione per avvistare in tempo,
e poter mettere in allarme la terraferma, gli invasori provenienti dall’Africa
o dalla Spagna.
Il
generale Carlo con le sue truppe è accampato ad Uras e sta per mandare un suo
messaggero alla guarnigione pisana a Sardara
quando viene raggiunto da un messaggero inviato da Torchitoro:
-
Generale il Giudice vi ordina di tornare ad Oristano subito.
Il
generale Carlo fa smontare il campo e due giorni dopo è alla presenza di
Torchitoro:
-
Giudice, cosa accade?
-
Generale, siamo nei guai: le nostre navi hanno avvistato una grande flotta
aragonese ancorata nell’isola di Madera. Una spia mi ha riferito che la flotta
si dirigerà ad Oristano. A Bosa, a Santa Caterina, a Tarros, e a Porto Palma
sono già in allarme e si stanno raccogliendo altri soldati.
-
E l’accordo con Pisa?
-
Prima viene la nostra sicurezza! Quando sarà passato questo pericolo, penseremo
a Pisa.