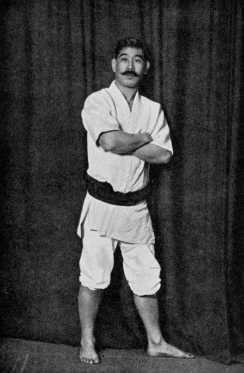|
|
LIVIO TOSCHI |
|
|
|
|
|
|
|
Storia del Judo |
|
|
Prima parte: Dalle
origini alla seconda guerra mondiale |
||
|
Il Judo ha la natura dell’acqua. Eccola, turbinante nelle cascate del Niagara, calma nella superficie di un lago, minacciosa in un torrente o dissetante in una fresca sorgente scoperta un giorno d’estate. Questo è il principio del Judo.
GUNJI KOIZUMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
|
|
|
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
|
|
5. |
|
|
6. |
|
|
7. |
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Le origini del Jujitsu |
|
|
|
|
|
Il monaco indiano Bodhidharma (Ta Mo in cinese, Daruma in
giapponese), figlio del re Suganda di Madras, 28°
patriarca buddista e seguace del Mahayana
(la dottrina del «grande veicolo»), alla morte
del suo Maestro Prajnatara andò in Cina. Vi giunse
nel 520 d.C. e fu ricevuto dall’imperatore Wu
Di, ma rimase deluso del buddismo praticato alla corte cinese. Dopo un lungo
peregrinare soggiornò per molti anni nel monastero di Shao-lin (Sho-rin in giapponese), costruito ai piedi del monte Song, nella provincia di Henan. La tradizione vuole che a Shaolin abbia fondato una scuola impostata sulla meditazione: dhyana in sanscrito, chan in cinese, zen in giapponese. Insegnò inoltre ai monaci degli esercizi di respirazione (chi kung) e di ginnastica per fortificare il loro fisico, messo a dura prova da pesanti sedute meditative nella posizione zazen. |
|
|
Secondo la leggenda,
poiché in India aveva fatto parte della casta dei guerrieri ksatriya, insegnò anche delle tecniche di
combattimento a mani nude, che col tempo furono arricchite e perfezionate grazie al contributo di altri monaci e di
esperti di arti marziali che si recavano a Shaolin
attratti dalla crescente fama del luogo. Per Bodhidharma le arti marziali (wu-shu,
ossia «arte della guerra»; in giapponese bu-jitsu; in Occidente
più note come kung-fu) servivano
indubbiamente a rafforzare il corpo e a mantenerlo sano, pronto a difendersi
da eventuali attacchi, ma contribuivano soprattutto al perfezionamento
spirituale del praticante. Wu-de
costituiva la virtù marziale. |
|
|
|
Bodhidharma |
Quella di Bodhidharma che insegna arti marziali ai
monaci è solo una leggenda, visto che queste si praticavano (anche nei
monasteri) già molti secoli prima che lui giungesse in Cina, ma il Maestro Barioli l’interpreta così: «L’avvento della
religione indiana, fortemente popolare, fornì alle discipline di combattimento
il necessario substrato morale, giustificandone la pratica che altrimenti sarebbe degenerata al servizio dell’egoismo e della
violenza».
Nel
621 il principe Li Shimin,
fatto prigioniero dai soldati del generale Wang, fu liberato
da 13 monaci di Shaolin armati solo di bastoni. Quando divenne imperatore li ricompensò con generosità,
consentendo inoltre al monastero di addestrare militarmente alcuni religiosi:
nacquero così i monaci-guerrieri. Costoro si esercitarono non soltanto nel
combattimento a mani nude, ma usarono le armi proprie dei soldati, servendosi di ottimi maestri per perfezionare l’addestramento. Li Shimin è considerato dalla
storiografia uno dei migliori sovrani che la Cina abbia mai avuto (ebbe postumo
il titolo di Tang Tai
Zong = Grande Antenato Tang).
Sotto di lui le virtù civili (wen, in
giapponese bun) e quelle militari (wu, in giapponese bu)
si combinarono con perfetto equilibrio.
Il
monastero di Shaolin, completamente rinnovato non
molti anni fa, si struttura sull’asse nord-sud e
mostra una pianta rettangolare molto allungata. Tra i vari edifici vanno
ricordati la “Stanza dei Rivestimenti Bianchi”, nota anche come la
“Stanza degli affreschi del wushu”, e il
museo, inaugurato nel 1986: raccoglie ben 215 statue a grandezza naturale,
raffiguranti i monaci nelle posizioni tipiche dello Shaolin-chuan
(Shorinji-kempo in giapponese).
* * *
I
tanti metodi di combattimento nati in Cina si sono sviluppati lungo due
direttrici. La prima prende il nome di nei-chia,
stili “interni” o “morbidi” di combattimento, che privilegia gli aspetti filosofici e metafisici. Il
principale di questi stili è il tai-chi-chuan
(«pugno della suprema vetta»), la cui base spirituale è costituita
dall’I-Ching, il Libro dei Mutamenti.
Gli stili morbidi sviluppano il concetto taoista del wu-wei, che viene
solitamente tradotto «non azione», ma sarebbe meglio dire «non ingerenza». In
sostanza è la capacità di dominare le circostanze senza opporvisi, che consente
di sconfiggere un avversario cedendo apparentemente al suo assalto per
neutralizzarlo con movimenti per lo più circolari, rivolgendo quindi contro di
lui la sua stessa forza.
Va evidenziato che il
taoismo (tao o dao in cinese, do
in giapponese, significa «Via spirituale») si fonda sui principi complementari yang
e yin:
nessuno dei due può esistere senza l’altro. Nel mondo tutto è in perpetua
mutazione tra questi due poli attraverso combinazioni dinamiche. Lo yang rappresenta l’uomo, il giorno, la luce,
il caldo, la durezza e l’attacco; lo yin la donna, la
notte, l’oscurità, il freddo, la morbidezza e la difesa. Le due forze
inseparabili yang-yin sono raffigurate con il
simbolo di due pesci gemelli che formano un cerchio: un pesce è nero con un
occhio bianco e un pesce è bianco con un occhio nero, per significare che non
vi è nulla di assoluto.
Nel
XIII secolo l’eremita taoista Chang Sanfeng, considerato il
padre del tai-chi-chuan, concentrò
l’attenzione sull’energia interiore (chi in Cina, ki in Giappone), che può
manifestarsi all’esterno con incredibile potenza anche nelle persone meno
prestanti. Nessuno meglio del piccolo Maestro Ueshiba
ha saputo in tempi recenti esprimere la potenza del ki.
|
|
Si racconta che Chang Sanfeng abbia creato il
nuovo stile dopo aver osservato con attenzione il combattimento tra un
serpente e un uccello. Ma fin dal III secolo il
medico Hua To aveva
elaborato un sistema ginnico che si basava sullo studio delle tecniche di
combattimento di cinque animali: tigre, orso, cervo, scimmia e gru.
L’idea di Hua To ebbe successo e la maggior parte delle scuole che
seguirono prese esempio dall’istintivo mondo animale, libero dai
condizionamenti imposti all’uomo dalla ragione (paura della sconfitta,
del dolore, della morte). |
|
|
Posizione della tigre |
|
Posizione della scimmia |
La
seconda direttrice è la wai-chia,
stili “esterni” o “duri” di combattimento, che
si fonda sull’uso della forza in linea retta. La potenza del colpo viene molto accresciuta usando opportunamente il movimento
dell’intero corpo e la respirazione. Con il passare dei secoli gli stili esterni del nord (bei-chuan)
si differenziarono da quelli del sud (nan-chuan):
in sintesi possiamo dire che al nord si predilessero i movimenti lunghi e
aggraziati, con calci alti, al sud i movimenti brevi e potenti, con calci bassi
o pugni. Da qui il detto: «Nan chuan, bei tui» («Al sud le braccia,
al nord le gambe», ovvero «Pugni nel sud, calci nel nord»), che
sintetizzava la caratteristica più appariscente delle due tradizioni.
Gli stili duri erano
collegati al monastero di Shaolin, gli stili morbidi
ai templi taoisti, che s’ispiravano alla dottrina
di Lao Tzu
(contemporaneo di Buddha e Confucio), cui è stato a
lungo attribuito il famosissimo Tao-tê-ching.
Il più importante tempio taoista fu quello posto sul monte Wu-Tang,
nella provincia di Hopei.
Questo dualismo tra
stili duri e morbidi, pur evidente, non ha tuttavia confini rigidi. Gli stili
esteriori, più facili da comprendere e quindi meglio utilizzabili nella realtà
del combattimento, ebbero maggiore popolarità e furono esportati in Corea e ad Okinawa, mentre gli stili interiori rimasero a lungo
circoscritti agli strati superiori della società cinese. Gli stili duri in
Corea generarono il taekwondo («Via dei pugni
e dei calci in volo»), ad Okinawa il karatedo («Via della mano vuota»), diffuso in
Giappone da Gichin Funakoshi;
gli stili morbidi nel paese del Sol Levante generarono il
jujitsu, da cui sono derivati il judo («Via
dell’adattabilità») di Jigoro Kano e l’aikido («Via dell’armonia con
l’energia universale») di Morihei Ueshiba.
Attraverso
i secoli centinaia di “stili esterni” e decine di
“interni” si sono formati, mescolati e sovrapposti: la loro storia
è talmente complessa da scoraggiare un maggior approfondimento. La cultura
cinese, del resto, non ha mai facilitato agli occidentali l’accesso ai
suoi misteri.
* * *
L’immediatezza
dello zen, che
puntava sull’intuizione (contrapposta all’erudizione libresca) e
sull’imperturbabilità, si adattava bene alla mentalità semplice del
guerriero giapponese. Lo zen
s’innestò sulla religione autoctona, lo shinto
o kami-no-michi («Via degli
dei»), costituendo l’etica del bushido,
il codice d’onore dei samurai. Si legge nell’Hagakure
che la «Via del guerriero» era la morte, da affrontare con la mente vuota da
ogni preoccupazione, da ogni passione (mu-shin). Quando non si ha paura di essere sconfitti
o di morire, quando cioè la morte diviene «più leggera
di una piuma», è molto più facile prendere all’istante e risolutamente le
giuste decisioni che ci aiuteranno a vincere. Uesugi Kenshin, un grande condottiero del
XVI secolo, così esortava i suoi soldati: «Affrontate la
battaglia risoluti a morire e vi ritroverete sani e salvi; il desiderio
di sopravvivere alla battaglia vi porterà alla morte».
In questo periodo,
sotto l’influsso del taoismo, nacque e si diffuse rapidamente uno stile morbido
di combattimento a mani nude, che prese il nome di jujitsu (o yawara),
ossia «arte dell’adattabilità». Le sue origini si perdono tra le
leggende. La più nota racconta che un medico di Nagasaki, Shirobei
Akiyama, si recò in Cina per approfondire le sue
cognizioni sull’agopuntura e sui metodi di rianimazione (kappo), che presupponevano una perfetta conoscenza
dei punti vitali del corpo umano. Akiyama, uomo di
multiforme ingegno, approfittò del soggiorno nel continente per studiare anche
il taoismo e le arti marziali cinesi. Tornato in patria, durante un periodo di
meditazione notò che i rami più robusti degli alberi si spezzavano sotto il
peso della neve, mentre quelli di un salice si piegavano flessuosi fino a
scrollarsi del peso, per riprendere poi la posizione senza aver subito danni.
Applicando alle tecniche di combattimento apprese in Cina le considerazioni
maturate sulla cedevolezza o «non resistenza», fondò la scuola yo-shin (del «cuore di salice»).
Dal Tao-tê-ching voglio citare alcune massime di
grande importanza per il nostro studio:
|
Il più cedevole nel mondo |
|
|
Vince il più duro |
|
|
|
|
|
Non vi è al mondo nulla di più cedevole e
debole dell’acqua |
|
|
Ma nello stesso tempo |
|
|
Non v’è nulla che la superi nel
vincere il rigido e il forte |
|
|
[...] |
|
|
Così: il debole trionfa sul forte |
|
|
Il flessibile trionfa sul rigido |
|
|
|
|
|
L’uomo nasce debole e delicato |
|
|
Muore rigido e duro |
|
|
[...] |
|
|
Così: rigido e robusto sono i modi della morte |
|
|
Debole e flessibile sono i modi della vita |
|
|
|
|
|
La massima del buon combattente è: |
Lao Tzu |
|
Assecondare per mantenere l’iniziativa |
|
|
[...] |
|
|
Vince colui che
lascia |
|
|
Le molte scuole di jujitsu,
pur con diverse sfumature, fecero proprio questo fondamentale concetto, che rivoluzionò
la maniera di lottare: la morbidezza può vincere la forza. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Jigoro Kano |
|
|
|
|
Il
jujitsu raggiunse il massimo splendore durante il lungo periodo di pace instaurato
da Ieyasu Tokugawa dopo la
battaglia di Segikahara (1600), la sua proclamazione
a Shogun (1603) e la conquista del castello di Osaka
(1615). La fine delle guerre civili che avevano
insanguinato il Giappone dal XII secolo, interrotte soltanto per respingere le
invasioni mongole di Kublai Khan nel 1274 e 1281,
lasciò disoccupati migliaia di samurai, che divennero perciò ronin («uomini onda», ossia guerrieri senza
padrone). Molti di loro pensarono quindi di mettere a frutto quanto avevano appreso sui campi di battaglia, raccogliendo e
perfezionando le tecniche di combattimento, con o senza armi, ereditate dal
passato. E mentre in precedenza esistevano solo scuole private ad uso dei
grandi clan, ognuno dei quali elaborava e tramandava al suo
interno colpi di particolare efficacia, sorsero allora scuole di bujitsu (arti marziali) aperte a tutti. L’uso
strategico del corpo umano raggiunse livelli sbalorditivi di efficienza,
ma contemporaneamente il bu-jitsu si
trasformò in bu-do: tramite
l’addestramento marziale si tendeva a raggiungere anche un
perfezionamento spirituale.
Due secoli
e mezzo di pace durante lo shogunato Tokugawa furono possibili grazie a
un rigoroso controllo verticistico, che tendeva al
mantenimento dell’ordine. Divennero difficoltosi i contatti
all’interno e furono decisamente vietati quelli
con l’esterno, pena la morte, relegando il paese fuori dalla storia.
Intorno alla metà del XIX secolo, però, alla ricerca
di nuovi mercati commerciali in Estremo Oriente dopo l’apertura di cinque
porti cinesi nel 1842 (trattato di Nanchino, a
seguito della “guerra dell’oppio”), le grandi potenze
decisero di porre fine all’isolamento nipponico.
L’8 luglio 1853
il commodoro statunitense Matthew Calbraith
Perry giunse nella baia di Uraga con le sue celebri quattro «navi nere», prospettando
a nome del presidente Fillmore l’apertura del
Giappone al mondo occidentale. In seguito ai temporeggiamenti
nipponici, Perry tornò nel febbraio 1854 con otto
navi, facendo chiaramente intendere che non avrebbe tollerato un rifiuto.
Al trattato di Kanagawa con gli USA seguirono ben
presto quelli con Gran Bretagna e Russia, gettando nello sconforto quanti
avrebbero preferito morire combattendo contro un nemico meglio armato che
sottostare a un umiliante cedimento. I contrasti tra i
“falchi” e le “colombe” si acuirono via via fino a spaccare in due il paese. Ne conseguì
inevitabilmente una sanguinosa reazione a catena, culminata nel 1868 con la
fine del bakufu (shogunato)
Tokugawa e con la «restaurazione Meiji»:
dopo sette secoli il potere politico dalle mani dello shogun
tornava in quelle dell’imperatore. Il giovane Mutsuhito,
figlio dello xenofobo Komei e 122°
esponente della dinastia, trasferì la capitale da Kyoto
(ove risiedeva dal 794) a Edo, che chiamò Tokyo, ossia «capitale
dell’est», inaugurando l’era Meiji, di
«governo illuminato».
Nei primi anni
dell’era Meiji (1868-1912), sotto
l’infatuazione per la civiltà e i costumi occidentali, il bujitsu subì una rapida decadenza (anche per
l’enorme diffusione delle armi da fuoco) e molti esperti, rimasti senza
allievi, per sopravvivere in una società profondamente mutata dovettero
esibirsi a pagamento in squallidi locali o finirono
nella malavita. I maestri non tramandavano più il loro sapere, portandosi nella
tomba i segreti del ryu (scuola): un grande patrimonio di nobili tradizioni stava per scomparire.
Questo era il triste spettacolo che apparve a Jigoro Kano.
* * *
Nato
a Mikage (nella prefettura di Hyogo)
il 28 ottobre 1860, terzo figlio di Jirosaku Mareshiba, a 11 anni si trasferì a Tokyo con la famiglia.
D’intelligenza vivissima ma di gracile costituzione, doveva subire la
prepotenza dei compagni. Per difendersi avrebbe voluto praticare il jujitsu, ma la disciplina all’epoca era screditata
e ritenuta troppo violenta; dovette quindi rinunciarvi, dedicandosi alla
ginnastica e al baseball. Dopo aver frequentato la scuola di lingue straniere,
ove imparò a perfezione l’inglese, Kano s’iscrisse
all’Accademia Kaisei, trasformata in Università
nel 1877. A 17 anni poté finalmente avvicinarsi al
jujitsu, e vi si dedicò con passione, impegnandosi in duri allenamenti: sempre
ricoperto di piaghe, era soprannominato “unguento” a causa delle
pomate cui doveva ricorrere. Allievo di Hachinosuke Fukuda e di Masatomo Iso, della Tenjin-Shinyo-ryu, dopo la
loro morte venne in possesso dei densho, i
libri segreti della scuola. Conobbe quindi Tsunetoshi
Iikubo, già generale dello shogun,
esperto della scuola di Kito. Mentre
progrediva con sorprendente facilità, penetrando i segreti dei diversi stili,
ottenne la laurea in lettere e cominciò anche a
insegnare al Gakushuin (Scuola dei Nobili).
Nel
1882 il giovane professore aprì una palestra di 12 tatami
nel tempio buddista di Eisho,
radunandovi i primi 9 allievi: nasceva così il Kodokan («luogo per studiare la “Via”»),
dove elaborò una sintesi di varie scuole di jujitsu.
Il nuovo stile di lotta non doveva essere soltanto un’arte di
combattimento, ma era destinato alla divulgazione quale forma
educativa del corpo e dello spirito. Venne chiamato judo («“Via” della
flessibilità»): si fondava sul «miglior uso dell’energia» («seiryoku zenyo»),
da perseguire attraverso «amicizia e mutua prosperità» («jita
kyoei»).
|
In breve il Kodokan,
con un occhio alla tradizione e l’altro al futuro, assurse a grande fama grazie anche alle importanti vittorie sulle
scuole di jujitsu: nel 1886, dopo aver trionfato su quella del famoso Maestro
Hikosuke Totsuka (il
Kodokan riportò 13 vittorie e 2 pareggi su 15 incontri), Kano ebbe
l’incarico di addestrare la polizia di Tokyo. Il
judo, eliminati gli aspetti più violenti insiti nel jujitsu, entrò persino
nei programmi scolastici, diffondendosi a poco a poco anche lontano dal
Giappone. |
|
||
|
|
Jigoro Kano |
||
|
Nel 1895 Kano elaborò
il primo go-kyo
(«cinque principi») o metodo d’insegnamento; nel 1906 riunì a Kyoto i rappresentanti delle varie scuole per delineare i primi kata
(«modelli» delle tecniche di lotta); nel 1920 presentò il nuovo go-kyo, che è quello ancora usato in tutte le
palestre con qualche adattamento; nel 1922 diede vita alla Società Culturale
del Kodokan. Il Kodokan subì numerosi trasferimenti, ampliandosi in
continuazione: la sede attuale fu inaugurata il 25
marzo 1958. Va inoltre sottolineato che dal 1909 al 1938 Kano rappresentò il
Giappone nel CIO e nel 1911 fondò il Comitato Olimpico nipponico, di cui fu
presidente fino al 1921. Addetto alla Casa Imperiale, rettore del Collegio
dei Nobili, consigliere e segretario del Ministero dell’Educazione
Nazionale, direttore dell’Educazione Primaria,
per 26 anni fu anche direttore della Scuola Normale Superiore di Tokyo.
Senatore, ricevette postumo il 2° rango imperiale. Educatore di grandi
qualità, Kano seppe mirabilmente salvaguardare le nobili tradizioni delle
arti marziali, pur adattandole alle moderne esigenze dello sport. |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Lontano dal Giappone, nonostante i viaggi e le dimostrazioni di
Kano, si diffuse soprattutto il jujitsu, che aveva tratto nuovi stimoli
dalla rivalità con il Kodokan. I maestri di jujitsu, infatti, costretti a
subire la crescente popolarità del judo in patria, trovavano un fertile
terreno d’insegnamento in Occidente, dove non si era in grado di
rilevare le pur notevoli differenze tra i due metodi. Ai veri maestri, però,
si mescolarono quanti avevano praticato la disciplina solo per qualche
settimana in Giappone o presso un sedicente esperto occidentale, e anche non
pochi ciarlatani, generando diffidenza nel pubblico. |
|||
|
Vediamo rapidamente
quali furono i pionieri del jujitsu in Occidente. Già dal 1901 si
trovavano a Londra i maestri giapponesi Raku Uyenishi e Yukio Tani, che insegnarono i
rudimenti del jujitsu al campione svizzero di lotta libera Armand Cherpillod, cui si deve
il primo manuale in lingua francese (tradotto in italiano nel 1906). Nel 1905
Uyenishi aprì una palestra a Londra e Cherpillod impartì lezioni di jujitsu a ufficiali di marina
durante un corso a Portsmouth. Ben presto, alla scuola di Edith
Garrud, il jujitsu
fu praticato anche dalle donne, ma di judo
si cominciò a parlare solo nel 1918, con la fondazione del “Budokwai” sotto la guida del Maestro Gunji Koizumi. |
|
||
|
|
Yukio Tani |
||
|
A Parigi, intanto, dopo una lunga campagna di stampa, il 26
ottobre 1905 s’incontrarono in un combattimento divenuto famoso il
professor Ré-Nié, che insegnava jujitsu in una palestra in rue de Ponthieu, e il maestro Georges Dubois, valente pugile,
schermitore e pesista. Nei locali dell’officina Vedrine, a Courbevoie, Ré-Nié ebbe la meglio sul rivale
(di 12 kg. più pesante) in appena 26 secondi con una leva articolare. Sul
finire del 1905 giunsero a Parigi Tani e Katsukuma Higashi, proveniente
dagli Stati Uniti: in dicembre i due disputarono un interessante incontro
all’ippodromo Bostock. |
|
||
|
|
Ré-Nié |
||
|
Nel 1906, a Berlino, Erich Rahn apriva la prima
palestra di jujitsu in
Germania, venendo ben presto incaricato d’impartire lezioni alla
polizia berlinese e all’Istituto Sportivo Militare. Grazie anche ai
numerosi scritti di Irving
Hancock, subito tradotti in francese dagli
ufficiali di artiglieria Ferrus e Pesseaud, fin dai primi anni del secolo gli USA si
appassionarono al jujitsu
(nel 1905 veniva insegnato all’Accademia Navale di Annapolis).
Hancock stesso, allievo del Maestro Inouye, lo praticò con discreti risultati. Per diffondere il metodo Kano, dal 1902 al 1907 soggiornò in
America il grande Yoshiaki Yamashita
(nel 1935 ottenne il 10° dan, il grado più
elevato), che ebbe tra i suoi allievi il presidente Roosevelt.
Una prova dell’interesse statunitense per il jujitsu è la sua inclusione nel
programma delle Olimpiadi del 1904, inizialmente assegnate a Chicago. Il jujitsu
fu poi depennato dal programma dei Giochi di Saint Louis,
scelta al posto di Chicago in virtù della concomitante Louisiana Purchase Exposition. |
|||
|
* * * |
|||
|
Anche in Italia, dove
imperava la lotta greco-romana, con i suoi Ercoli statici
e muscolosi, non mancò qualche sporadica dimostrazione. Tra il 1905 e il 1906
si disputò il Trofeo Florio di lotta, articolato in tre prove, che ebbero luogo a Palermo, Napoli e Roma. In tutte e tre le città il pubblico poté assistere anche a sfide di jujitsu tra lo statunitense Witzler e alcuni partecipanti al Trofeo. A Roma le gare
si svolsero al teatro Adriano e videro il successo di Raoul le Boucher su Paul Pons. Lo statunitense Witzler
rinnovò la sua sfida, sconfiggendo prima il tedesco Schakmann
e poi il senegalese Amalhou, ma arrendendosi al
fortissimo Raoul (che sarebbe morto l’anno seguente, a soli 24 anni). Stesso copione, e quindi sentore
di combine, nell’aprile 1906 al teatro Verdi di Firenze. |
|
||
|
|
Witzler |
||
|
Sempre
nell’aprile 1906 tre maestri giapponesi di passaggio a Roma si
esibirono al Club Atletico Romano e uno di loro, Ysmano,
si trattenne per qualche tempo nella capitale, impartendo lezioni ai soci del
Club: fu lui, dunque, anche se per poco, il primo
insegnante giapponese di jujitsu
in Italia. Per la cronaca, il Club Atletico Romano era sorto nel 1885 per
iniziativa dei tre fratelli Protto, figli
dell’industriale piemontese produttore di un famoso vino tonico. |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
I contatti tra i marinai italiani e quelli nipponici, consolidati al
tempo della rivolta cinese dei Boxer (1900),
favorirono la diffusione delle tecniche di jujitsu anche tra i nostri
soldati, incuriositi e affascinati dall’abilità dei guerrieri del Sol
Levante nel combattimento all’arma bianca o a mani nude: i guerrieri
del Mikado, presi singolarmente, erano senza dubbio i migliori mai visti.
L’esaltante vittoria giapponese sulla Russia
(1904-05) accrebbe l’ammirazione per quel popolo: uscito da un
interminabile medioevo feudale solo nella seconda metà dell’Ottocento,
in pochi lustri aveva saputo conquistarsi un posto di primo piano tra le
grandi potenze. E nel mondo si cominciò a parlare
degli invincibili samurai e
del loro codice d’onore, il bushido
(«Via del guerriero»), che Inazo Nitobe descrisse con efficacia in un libro divenuto ben
presto famoso e tradotto per la prima volta in italiano nel 1917. Domata la rivolta
xenofoba dei Boxer, l’Italia ottenne una
concessione a Tientsin, allargando così i propri
interessi in Estremo Oriente. Gli entusiastici commenti di civili e militari
sulle virtù della lotta giapponese, soprattutto in vista di un suo impiego
bellico, convinsero il Ministro della Marina Carlo Mirabello
a organizzare un corso sperimentale
sull’incrociatore Marco Polo. Assegnato al capitano di vascello
Carlo Maria Novellis il
comando della nave, che stazionava nelle acque della Cina,
lo incaricò quindi di assumere a bordo un istruttore di jujitsu. Dopo molte ricerche Novellis trovò a
Shanghai un insegnante che godeva la fiducia del console giapponese. Il 24
luglio 1906 venne dunque stipulato un contratto di quattro mesi, tempo che il
maestro giudicava «necessario e sufficiente per portare gli allievi ad un
grado di capacità tale da renderli abili ad insegnare alla loro volta». Il
corso si sarebbe svolto a bordo e al termine gli allievi
migliori avrebbero sostenuto gli esami al Kodokan. Un mese dopo Novellis fece sapere a Mirabello
che aveva selezionato sei marinai e ordinato al medico di bordo «di seguire
lo sviluppo fisico degli allievi con le misurazioni che la scienza suggeriva»
per conoscere «quali requisiti fossero di principale importanza per
conseguire un notevole grado di perfezionamento in quella ginnastica».
Tutto sembrava procedere bene e Novellis,
soddisfatto dei risultati raggiunti a metà del corso, dispose che i marinai,
«sotto la guida del maestro, impartissero a loro volta lezioni ad
altri individui dell’equipaggio». E chiese (inutilmente) a Mirabello di «dare senz’altro
assicurazioni precise sulla loro posizione avvenire [...] avuto riguardo sia alla carriera che quegli istruttori avrebbero
potuto fare, sia ai vantaggi finanziari [...] necessari
per evitare che andassero disperse le spese che allora si incontravano
per istruirli». Alla fine di
settembre il Marco Polo giunse nel porto di Yokohama e qualche giorno
dopo i nostri baldi marinai varcarono la soglia del Kodokan per sostenere gli
esami, sul cui esito leggiamo la sconfortata
relazione di Novellis al Ministero. «Pur
avendo raggiunto, relativamente al breve periodo di
istruzione, un notevole grado di abilità, gli allievi del “M.
Polo” hanno ancora molto da apprendere. E ciò
appare cosa naturalissima, se si tiene conto dell’unanime opinione del
presidente e di tutti gli insegnanti del Kodokan, i quali ritengono essere
necessario un periodo di lezioni non inferiore ai tre anni per formare un
buon insegnante di Jujitsu. Ritengono gli stessi professori che
l’istruttore attualmente arruolato sul
“M. Polo”, e che ho anche fatto sottoporre ad esame, pur essendo
abbastanza abile, non può insegnare ai suoi allievi più di quanto egli sa: ed
essendo personalmente all’altezza di un allievo della classe media,
aveva perfettamente ragione nell’asserire che in quattro mesi avrebbe
portato gli allievi alla sua altezza, la quale però è ben lungi da quella di
un buon insegnante di Jujitsu». Si risolse così con
una beffa la prima esperienza del judo
italiano! Per evitare altre
spiacevoli sorprese, il povero Novellis
pensò allora di richiedere un insegnante proprio al Kodokan. Il Maestro Kano,
«reputato la personalità più competente nell’arte del
Jujitsu», consigliò di assumere a bordo due insegnanti, con contratto
biennale e facoltà di rinnovo, a L. 1.600 mensili
oltre «le spese di viaggio, pel caso di invio degli istruttori in Italia».
L’ingaggio di un solo insegnante avrebbe comportato la spesa di L. 900 mensili. Nonostante le
insistenze di Novellis, che voleva sapere se il
corso sarebbe proseguito in Estremo Oriente o sul Marco Polo, in
procinto di rientrare in patria, il ministro non diede alcuna risposta,
probabilmente seccato del precedente “contrattempo” e timoroso di
gettare al vento una non lieve somma. In dicembre, comunque,
Novellis effettuò una visita all’Accademia
Navale di Etajima, assistendo agli esami di jujitsu
e convincendosi sempre più della notevole importanza di quella disciplina. |
|||
|
* * * |
|||
|
Il 31 dicembre 1906 giunse a Shanghai l’incrociatore Vesuvio
e Novellis cedette il comando delle operazioni in
Estremo Oriente al capitano di vascello barone Eugenio Bollati di Saint Pierre. Questi fece imbarcare dal Marco Polo due marinai
ormai abili nella lotta giapponese: uno di loro, il timoniere brindisino Luigi Moscardelli,
nell’aprile 1907 ottenne a Tokyo «il diploma di abilitazione
all’insegnamento». Fu lui, quindi, il primo istruttore italiano della
disciplina. Ricevette anche una gratifica di 20 lire dal capitano Bollati
«per il metodo efficace e la solerzia messa nell’insegnamento del jujitsu», che il comandante riteneva «un buon
esercizio per mantenere l’elasticità dei muscoli», utile anche alla
polizia «per avere un mezzo di ottenere ragione di qualche malfattore in caso
di colluttazione». |
|
||
|
|
Allenamento a bordo dell’incrociatore Vesuvio |
||
|
Nel settembre 1907 a
bordo del Vesuvio si disputarono le gare semestrali imposte dal Ministero
della Marina per mantenere in allenamento gli equipaggi. La gara di jujitsu
fu vinta dal sottocapo cannoniere Raffaele Piazzolla
di Trani sul cannoniere
scelto Carlo Oletti,
diciannovenne torinese destinato a lasciare un segno profondo nella storia
della disciplina in Italia. Favorevolmente
impressionato dagli «esercizi di scherma di bastone in vigore sulle navi
giapponesi», da lui ammirati durante una visita all’arsenale di Maidzuru, nel settembre 1907 il comandante del Vesuvio
introdusse a bordo anche un corso di kenjitsu
(«arte della spada»). Bollati lo riteneva «utilissimo, in un col jujitsu, per
sviluppare l’ardire e la forza dei nostri equipaggi». Questa volta
l’insegnante fu inviato direttamente dal Ministero della Marina
giapponese: il sottufficiale Kamei eseguì
brillantemente l’incarico dal 23 settembre al 16 ottobre. Ma la “scherma giapponese”, così lontana dalla
nostra tradizione, non fece proseliti in Italia. Il 30 settembre
l’equipaggio visitò la scuola media di Mijadzu.
Nella sua relazione il tenente di vascello Alberto Malvani
descrisse, tra l’altro, le esercitazioni di jujitsu e kenjitsu.
Il jujitsu gli sembrava «utilissimo per
sviluppare non solo il fisico dei fanciulli, ma soprattutto le loro energie
morali», poiché «nella lotta si coltivano le qualità d’iniziativa e di
combattività» che saranno loro utili «sia nelle terribili lotte della guerra,
sia in quelle non meno serie della pace». Notò poi che nel kenjitsu
i contendenti si affrontavano «come galli feroci aizzati l’un
contro l’altro», menando terribili fendenti a due mani con i lunghi
bastoni di bambù. Al termine di alcuni scontri cui
presero parte anche i marinai italiani, Malvani
commentava divertito: «Non
vi è nulla di più originale di un piccolo maestro nipponico alle prese con
uno dei nostri poderosi cannonieri, che non grida e non si lancia con la
testa in avanti, ma che quando può allunga dei colpi di bastone che, se non
fossero abilmente parati, farebbero passare al buon maestro un pessimo quarto
d’ora. I nostri hanno mostrata molta
disposizione per imparare le due segrete arti, e noi siamo felici di vedere
che, a qualunque cosa essi pongano mano, sanno non mostrarsi mai inferiori
agli altri». Un po’ di ottimismo non guasta davvero ... |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Le lezioni di jujitsu sul Vesuvio furono dunque impartite
da un nostro marinaio, magari assai capace, che aveva però soltanto pochi mesi
di esperienza, per di più fatta con un mediocre
insegnante giapponese. Attingendo solo saltuariamente alle fonti
dell’«arte gentile», finimmo per confondere il
judo con il jujitsu, praticando una disciplina
“autarchica” ben diversa da quella del Kodokan: già al primo
incontro con lottatori giapponesi, nel 1907, il metodo seguito dai nostri
marinai fu dichiarato dagli avversari «non regolamentare». Pochi mesi dopo il
capitano di fregata Roberto Giorgi De Pons scriveva che «fino a quando gli istruttori non si
saranno perfezionati e moltiplicati e fino a quando questo genere di lotta,
talvolta alquanto brutale, non sarà stato disciplinato, riuscirà cosa
pericolosa e poco proficua introdurlo sulle navi come sistema collettivo di educazione». Tradendone completamente
lo spirito, nel nostro paese il jujitsu-judo
fu praticato usando molto più la forza che non la cedevolezza (ju), trascurando completamente la ricerca della
“Via” (do). A riprova della confusione che regnava intorno alla disciplina basti pensare che nel 1926
il termine judo in Italia veniva ancora tradotto «rompi muscoli»! Persino dal
già citato Oletti, che si vantava di averne appreso
«tutti i segreti» e di essere perciò «padrone di
tale metodo». All’epoca furono in molti a
improvvisarsi maestri di jujitsu e judo, pur non conoscendo che
poche tecniche, le più spettacolari e pericolose per l’incolumità
dell’avversario (e spesso del compagno di allenamento). |
|||
|
* * * |
|||
|
In un’atmosfera effervescente, dovuta anche all’ascesa
in Campidoglio dell’amministrazione popolare guidata dal sindaco Nathan e alle tante iniziative in cantiere per celebrare
il cinquantenario dell’unità d’Italia, nel 1908 a Roma non
mancavano davvero avvenimenti mondani di forte richiamo: in aprile, per
esempio, s’inaugurarono il congresso femminista e il concorso ippico
internazionale. Fu in questo clima che la Società per il movimento dei
forestieri e l’Istituto nazionale per l’incremento
dell’educazione fisica diedero vita alle
grandiose feste di fine maggio. Così, il pomeriggio di sabato 30 maggio 1908
si svolse la prima dimostrazione di jujitsu fatta da italiani. Teatro
dell’eccezionale avvenimento fu l’incantevole villa Corsini alle pendici del Gianicolo,
alla presenza di un folto pubblico allietato dalla musica del celebre maestro
Vessella. Sotto lo
sguardo attento del ministro Mirabello, negli
intervalli tra le gare di lotta greco-romana organizzate dall’Audace
Club Sportivo, «due abilissimi sottufficiali di marina diedero una
dimostrazione della teoria e della pratica della lotta giapponese». Pochi
giorni dopo, evidentemente incuriosito, Vittorio Emanuele III volle che
l'esibizione fosse ripetuta nei giardini del Quirinale. Così Il Messaggero
commentava l’avvenimento: «La dimostrazione fu
fatta, con molta chiarezza, dal maestro di scherma De Cugni
Francesco, il quale dimostrò, con competenza non comune, l’importanza
di questo sport, nuovo per l’Italia. I due lottatori
presentati sono i sottufficiali Vegliante Emanuele e Guzzardi
Giuseppe. Il re,
che si interessò moltissimo dell’esperimento,
pregò di ripetere vari colpi e fece scattare molte volte la sua macchina
fotografica ritraendoli in più pose. Da ultimo ebbe per i bravi
lottatori parole di vivo compiacimento. Assistevano pure il ministro della marina, on. Mirabello,
l’ammiraglio Viale e il comandante Como, intelligente ed appassionato
cultore dello sport, al quale si deve se tale genere
di lotta sta per essere introdotta in Italia». Il giorno seguente la
dimostrazione fu ripetuta nella palestra della Scuola magistrale in via Cernaia. A conclusione delle
feste di maggio il comandante Como di Santo Stefano, già capitano di corvetta
sul Marco Polo, tenne al Circolo militare un’applaudita
conferenza sull’educazione fisica. Nonostante
l’ottimo esordio, il cammino del jujitsu fu
lento e difficile. Infatti, se si eccettua qualche articolo
o conferenza, una timida proposta dell’Istituto nazionale per
l’incremento dell’educazione fisica e i generosi ma vani
tentativi del bresciano Umberto Cristini, della «Via della flessibilità» non
si parlò davvero molto in Italia. |
|||
|
* * * |
|||
|
Al campionato mondiale di lotta per professionisti, svoltosi a
Parigi nel 1908, aveva preso parte anche il giapponese Akitaro
Ono, esperto di jujitsu, battuto in
greco-romana dal nostro Giovanni Raicevich sia
nella capitale francese che al Torneo delle Nazioni,
disputato al teatro Eden di Milano dal 16 gennaio al 15 febbraio 1911. Quale “contorno” al torneo, Ono
sostenne svariati combattimenti di jujitsu, promettendo 200 lire di
premio a chi avesse saputo resistergli per due minuti: è ovvio che vinse
sempre e con estrema facilità. Ma tra i suoi avversari, il già citato Cristini dimostrò «inconfutabilmente di essere uno
specialista finissimo dell’arte nipponica della difesa personale», tanto
che pochi giorni dopo il loro incontro, Ono e Cristini furono invitati a una
nuova esibizione. |
|
||
|
|
Umberto Cristini |
||
|
Dal 1° marzo 1911 i
milanesi poterono assistere per alcuni giorni agli incontri di sumo, gominuki e jujitsu
disputati al Trianon da 24 atleti nipponici, che vennero anche al teatro Apollo di Roma dall’11 al 20
marzo. Commentava il giornalista sportivo Alberto Cougnet:
«Sono esibizioni d’una straordinaria
suggestività e che dimostrano una tecnica ed un’abilità molto superiore
a quella della greco-romana, cristallizzatasi, da due millenni, in formule
combattive ed estetiche, ma di poca o nulla praticità come difesa personale». A Milano il solito Cristini resisté ben otto minuti all’esperto Atagawa. Di Cristini vanno
ricordate anche le sfide milanesi con i lottatori professionisti Ambrogio Andreoli (al Teatro Lirico) e Giovanni Raicevich (al Trianon) nel
tentativo di dimostrare la superiorità del jujitsu
sulla lotta greco-romana. Poi, complice anche la guerra, per molti anni sulla
lotta giapponese calò il silenzio. E un totale
disinteresse mostrò la Federazione Atletica Italiana, che allora si
occupava di lotta greco-romana, pugilato e sollevamento pesi, ma non voleva
sentir parlare di lotta libera, soprattutto di catch o jujitsu. A cavallo della Grande Guerra la lotta giapponese ebbe un
discreto sviluppo in occidente. Risale comunque al
1918 l’avvenimento più importante, ossia la costituzione del Budokwai per opera di Gunji
Koizumi. La palestra londinese assunse in breve il
ruolo di guida del judo europeo, grazie anche
all’apprezzamento di Kano, che la visitò nel 1920. |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
6. Si costituisce la Federazione Jiu-Jitsuista
Italiana |
|||
|
|
|||
|
Nel primo dopoguerra due eventi avvicinarono Italia e Giappone,
rinverdendo vecchi legami di amicizia: il raid aereo
Roma-Tokyo, pensato da Gabriele d’Annunzio ma
realizzato dal tenente Arturo Ferrarin tra il
febbraio e il maggio 1920, e la visita a Roma del principe ereditario Hirohito nel luglio 1921. Gli avvenimenti, largamente
reclamizzati dalla stampa, ridestarono l’interesse della gente per
l’impero del Sol Levante, per i suoi costumi e per le sue efficacissime tecniche di combattimento. Così, sul
finire del 1921, il capo cannoniere di prima classe Carlo Oletti (già imbarcato sull’incrociatore Vesuvio),
fu chiamato a dirigere i corsi di jujitsu introdotti alla Scuola Centrale Militare di
Educazione Fisica a Roma, di cui era comandante il colonnello
Giulio Cravero. La Scuola, istituita con R.D. 20
aprile 1920, ebbe sede nei locali del Tiro a Segno Nazionale alla Farnesina, segnalandosi subito all’attenzione
generale. |
|
||
|
|
Carlo Oletti |
||
|
Da quel momento le iniziative si susseguirono numerose. Nel 1922 Oletti insegnò nella palestra della “Giovane
Italia” in via della Consulta, e dal gennaio 1923 cominciò le lezioni
alla “Cristoforo Colombo” in via Tacito, che divenne
ben presto la società sportiva più forte d’Italia nel jujitsu.
Per diffondere la disciplina, i suoi appassionati cultori costituirono la Federazione
Jiu-Jitsuista Italiana. Domenica 30 marzo 1924, nella palestra della
“Colombo”, i delegati di 28 società e corpi militari si riunirono
con svariati esponenti del mondo sportivo: furono approvati statuto e
regolamento, si scelse Roma quale sede del primo congresso, si elesse il
consiglio direttivo, presieduto dal comm. Antonello Caprino (avvocato ed alto
funzionario comunale) e composto da 12 membri, tra
cui ricordo il cav. Vermiglio Puglisi (vicepresidente),
il cav. Arturo Bernacchi (segretario), il dott.
Emanuele Cigala (medico federale), il maestro Carlo
Oletti e il comm. Felice Tonetti.
Il primo articolo del regolamento tecnico federale riconosceva «quale metodo
ufficiale di Jiu-Jitsu, sia per l’insegnamento che
per la pratica, il metodo Kano»; il secondo articolo precisava che la FJJI
aveva sede a Roma; il terzo articolo affermava: «La FJJI ha carattere
prettamente sportivo, onde è apolitica e non si
occupa di questioni religiose». Questo articolo fu
depennato nel testo del 1927. Il 20 e 21 giugno 1924 alla sala Flores in via
Pompeo Magno si disputò il primo campionato italiano: il titolo assoluto fu
vinto da Pierino Zerella, esperto di lotta
greco-romana, mentre il titolo a squadre andò alla Legione Allievi
Carabinieri di Roma davanti alla SCMEF e alla Guardia di Finanza. «La
completa riuscita di tali gare - commentava la stampa - ha confermato
l’interesse del pubblico per questo genere di sport, che è mezzo
efficace di cultura fisica e di educazione del
carattere, mentre insegna pratiche originali di difesa personale e
procedimenti strani e tuttora incomprensibili di mezzi per richiamare alla
vita», con evidente riferimento al kuatsu. |
|||
|
* * * |
|||
|
Nonostante gli sforzi di pochi appassionati, il
jujitsu si faceva largo assai lentamente tra il grande pubblico. Tra
l’altro, dopo le edizioni del 1924, 1925 e 1926, i campionati italiani
erano stati interrotti. E a nulla era servita, nel
1927, la trasformazione della FJJI in Federazione Italiana Lotta
Giapponese sotto la guida del dinamico Giacinto Puglisi,
presidente della “Colombo”. Ritenendo che la disciplina potesse fare un salto di qualità con una spettacolare
manifestazione, il 7 luglio 1928 il quotidiano L’Impero
organizzò con l’ “A.S. Trastevere”
una grande riunione di propaganda nella sala della Corporazione della Stampa
in viale del Re a Trastevere. La manifestazione
ebbe un buon successo grazie a due presenze non previste: la partecipazione dell’esperto judoka nipponico Mata-Katsu
Mori, che si trovava a Roma in veste di pedagogo presso la famiglia
del poeta Shimoi, e - soprattutto -
l’intervento del Maestro Kano. Questi, venuto a
conoscenza dell’iniziativa mentre era a Parigi, non volle
mancare all’appuntamento. Fortunatamente per noi, L’Impero
comprese il valore di quella presenza eccezionale e mandò senza indugio un
suo cronista all’hotel Royal in via XX Settembre, dove Kano alloggiava. Servendosi
dell’illustre poeta Harukichi Shimoi quale interprete, Kano rilasciò
un’intervista preziosa, di cui ritengo utile trascrivere un brano significativo. «Il Judo è
l’arte di utilizzare col massimo rendimento la forza umana: utilizzare
la forza umana vuol dire farle assumere diverse forme e farle raggiungere
diversi risultati. Combattere per la gioia di vincere, cercare la robustezza
del proprio fisico, coltivare la forza senza perdere nulla in scienza e in
intelligenza, migliorare l’uomo rispetto alla vita sociale: ecco i fini
che deve avere uno sport che vuole rendersi utile
nella vita di una razza e di una nazione. Ed ecco ciò che si propone il Judò, il quale non ha solo lo
scopo di educare il corpo, ma vuole anche plasmare moralmente e
intellettualmente l’individuo per formarne un ottimo cittadino [...]. Per questo il Judo in Giappone non viene
considerato come un’arte, ma come una cultura, che oltre ad offrire
un’utilità immediata con la difesa personale per la vita, rinvigorisce
i sentimenti migliori dello sportivo e dell’uomo». Un pubblico numeroso si radunò in Trastevere
per assistere a dimostrazioni e combattimenti. La riunione ebbe un «successo
lusinghiero», riscuotendo anche il plauso di Kano, che tenne nell’occasione una «conferenza teorico-pratica». Mata-Katsu Mori si trattenne per qualche tempo nella
capitale, insegnando jujitsu-judo presso la “Società Ginnastica
Roma”. Pochi giorni dopo la manifestazione a Trastevere
si svolsero alla SCMEF i primi esami per l’attribuzione della qualifica
di Maestro. Quindi, nel giugno 1929, si disputò a
Roma il quarto campionato italiano. Ma il trasferimento di Oletti a La Spezia nel 1930, nonostante le manifestazioni
caparbiamente organizzate dalla “Colombo”, raffreddò non poco gli
entusiasmi. Nel febbraio 1931, per di più, la FILG venne
soppressa e incorporata nella Federazione Atletica Italiana (fondata
nel 1902 dal marchese Luigi Monticelli Obizzi), paralizzando per un decennio l’attività judoistica. |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Tra le pochissime manifestazioni svoltesi in Italia negli anni
Trenta dobbiamo ricordare quelle organizzate a Roma
dal vicepresidente della FAI e presidente della “S.S. Cristoforo
Colombo”, Giacinto Puglisi (già
presidente della FILG). La più importante fu la Coppa Puglisi,
istituita nel marzo 1931 e replicata l’anno seguente. Inoltre, per
celebrare il 25° e il 26° anniversario della gloriosa società, vennero inserite dimostrazioni di lotta giapponese nel
programma dei festeggiamenti. Tutto finì quando Puglisi lasciò la presidenza della “Colombo”
nel dicembre 1932. Nel 1934 si riparlò di judo anche a Genova e a Milano grazie alle
esibizioni curate dal maestro Francesco Cao.
Quell’anno a Dresda si disputò un campionato,
impropriamente definito «europeo», visto che furono solo 4 le nazioni in
gara: Cecoslovacchia, Germania, Lettonia e Ungheria. Nel novembre 1933, intanto, la FAI aveva
cambiato il nome in Federazione
Italiana Atletica Pesante. Passarono quasi inosservati il temporaneo ritorno a Roma di Oletti (1933-36), che riprese l’insegnamento alla “Colombo”, e persino il secondo viaggio in Italia di Kano, recatosi a Milano nel settembre 1936 per ringraziare il conte Alberto Bonacossa (membro del Comitato esecutivo del CIO) dell’appoggio italiano alla candidatura di Tokyo per l’Olimpiade del 1940. |
|||
|
* * * |
|||
|
Incluso nel comitato organizzatore dell’Olimpiade di Tokyo, Jigoro Kano si adoperò senza risparmio per
il successo della manifestazione, nel cui programma
compariva anche il budo quale sport
dimostrativo. Partecipò al congresso del CIO al Cairo (13-18 marzo 1938).
Alcuni dei congressisti si recarono poi ad Olimpia, dove il 26 marzo ebbe luogo una toccante cerimonia: il cuore di de Coubertin venne tumulato nel monumento eretto nel 1927 in
memoria della rinascita dei Giochi (così aveva lasciato scritto il barone nel
suo testamento). Kano compì invece un breve viaggio in America, ma mentre era
sulla via del ritorno, il 4 maggio moriva di polmonite a bordo del piroscafo Hikawa-Maru. Il suo funerale, celebrato al Kodokan il 9
maggio, fu imponente e solenne. Non assistette dunque alla disfatta del
Giappone, ma poco prima di morire, quasi presagendo la tempesta che stava per
sconvolgere il mondo, lasciò una specie di testamento spirituale, così riferitoci
dal Maestro Koizumi. |
|
||
|
|
La statua di Kano al Kodokan |
||
|
«Il Judo non
è soltanto uno sport. Io lo considero un principio di vita, un’arte e
una scienza [...]. Deve essere libero da qualsiasi
influenza esteriore, politica, nazionalista, razziale, economica, od
organizzata per altri interessi. Tutto ciò che lo riguarda non dovrebbe
tendere che a un solo scopo: il bene
dell’umanità». |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Nel luglio 1941 il dott. Giovanni Valente veniva
nominato presidente della FIAP. Valente rilanciò i campionati di società,
appoggiandosi soprattutto ai gruppi sportivi dei Vigili del Fuoco, e istituì
i Trofei di Propaganda: quelli di lotta greco-romana e sollevamento pesi
cominciarono nel 1942, quello di lotta libera (intitolato a
Umberto Cristini) nel 1943. A lui si deve, inoltre, la rinascita della lotta giapponese: il
14 giugno 1942, infatti, inaugurò alla Scuola di Polizia di Caserta il 1°
Corso allenatori di judo, diretto dal maestro Francesco Cao,
che aveva abitato a lungo in Giappone, ottenendovi la cintura nera. Gli
atleti selezionati agli esami del 30 luglio presero parte al Corso di
perfezionamento che si tenne in settembre alla Scuola di Polizia in via Guido Reni a Roma. Gli appunti
di Cao sulle lezioni impartite agli allievi
allenatori, pubblicati nel 1943 dal Ministero dell'Interno, non parlavano più
di jujitsu, ma di judo. E indubbiamente
nell'opuscolo si riscontava una chiara conoscenza dello "stile
Kodokan", persino nell'uso dei termini giapponesi appropriati. Cao descrisse con minuzia il «saluto», le «posizioni», gli «spostamenti», gli «squilibri», le
«cadute», suddividendo le tecniche secondo lo schema ancora oggi adottato. Il
"vero" judo faceva quindi capolino in Italia proprio nel momento
più tragico della nostra storia recente. Il 1° agosto 1942, nella caserma del 54° Corpo dei Vigili del
Fuoco di Napoli, aveva inizio il 2° Corso allenatori, anche questo della
durata di un mese, per i Vigili del Fuoco e la Polizia Portuaria, nonché per i civili ritenuti idonei dalla FIAP. L'attività
della Federazione non conosceva soste. Nel dicembre 1942 la FIAP rese noto il calendario dell'attività nazionale,
prevedendo campionati di lotta giapponese a squadre e individuale, oltre al
"Trofeo del Giudò". Le 30 eliminatorie
del Trofeo, patrocinato da La Gazzetta dello
Sport, si svolsero in diverse città a partire dal 16 maggio 1943 e riscossero un lusinghiero successo. Le semifinali si
disputarono il 20 giugno a Roma, Milano, Salerno e Vicenza. La finale, in
categoria unica, si disputò il 4 luglio 1943 nella palestra della "Reyer" a Venezia e vide la vittoria di Enzo Fantoni su Marino Cipolat (ambedue agenti di P.S. del Centro di Milano). |
|||
|
* * * |
|||
|
Nel luglio 1943, alla conclusione del Trofeo che aveva patrocinato,
“La Gazzetta dello Sport” poteva affermare che il
judo (comunemente scritto «giudò») era ormai di
casa in Italia. L'interesse dei "media" sembrò davvero la premessa a una diffusione sempre maggiore della disciplina.
Ovunque, infatti, fiorivano nuovi corsi, nuove
manifestazioni. Il Direttorio della FIAP, riunitosi il 30 aprile 1943 a Bologna,
fissò al 24 e 25 luglio (a Bologna) il campionato di prima divisione a
squadre e al 3 ottobre (a Roma) il campionato assoluto individuale. Si
puntava soprattutto al campionato assoluto per la definitiva affermazione
della disciplina, ma le drammatiche vicende succedute al 25 luglio
arrestarono nuovamente il cammino del judo italiano. La presidenza Valente costituì comunque
un periodo felice, che «fu apportatore di un sano dinamismo alla Federazione,
fornendo nuova linfa al corpo stanco dell'atletica pesante italiana». |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
(fine della prima parte) |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||