| Presentation | News | Events | Archives | Links | Sections | Submit a paper |
FRENIS zero
"Id-entità mediterranee. Psicoanalisi e luoghi della memoria". N.10, anno V, giugno 2008.
| "I LUOGHI DEL SOGNO E DELLA MEMORIA NEL CINEMA"
di Massimo Maisetti
| |
|
Questo testo è stato presentato dall'autore al convegno internazionale "Id-entità mediterranee. Psicoanalisi e luoghi della memoria" (Lecce, 5 aprile 2008). Massimo Maisetti è critico cinematografico e risiede a Milano.
| |
|
|
Il cinema, linguaggio per immagini, sa essere ben altro che un passatempo senza storia quale fu considerato tanti anni or sono da Sigmund Freud.
La psicoanalisi tende a recuperare attraverso l’interpretazione dei sogni, in un percorso a ritroso, il significato di immagini in cui figure o personaggi rappresentano il mondo interno, istintuale, affettivo, in una situazione di caos primigenio, emozionale.
Il film è quel luogo dell’immaginario dove una nebbia felliniana sospende i confini tra memoria e sogno e lo spazio e il tempo si dilatano ad accogliere realtà e fantasia.
“Otto e mezzo” è l’esempio di un viaggio sognato senza sapere dove andare, magari senza arrivare in nessun posto, nell’isola-che-non-c’è di Peter Pan.
E’ un recupero dell’ignoto sulle orme di Joyce, Pirandello e Kafka, nel quale si riflettono la storia di una crisi, l’emozione dell’opera che si fa mito e riferimento, e la terribile incertezza dell’autore di fronte alla necessità anche intima di sperimentare.
E’ il senso di vuoto, di spavento, di incredulità che prova Guido, il protagonista, al momento di cominciare: che cosa raccontare e perché?
E’ uno smarrimento analogo a quello dello scrittore, ma tanto più grave in quanto davanti e intorno al regista c’è uno stuolo di operatori e attori, talvolta oggetto di proiezioni psicologiche del regista, tutti in attesa di disposizioni e pronti a quel ciak si gira che dovrebbe dare corpo a illusioni verosimili.
Qui la crisi di chi fa cinema si identifica con l’interrogativo nel quale ogni persona inciampa almeno una volta nella vita: a che serve o a chi serve il film, il libro, la relazione, l’intervento, il mio vivere?
La risposta del cardinale all’uomo che cola sudore nel caldo infernale del bagno turco è una domanda che suona beffarda: “Chi ti ha detto che si vive per essere felici?”
Un’altra risposta potrebbe essere cercata attraverso la psicoanalisi, la scienza capace di cogliere il significato profondo insito nei metalinguaggi della patologia, della letteratura, del cinema, dei comportamenti umani.
La psicoanalisi può valere come strumento di decodifica e di approfondimento, utile per capire quel gioco di introiezioni e proiezioni che informa chi fa cinema e chi ne fruisce, e che può essere esteso a qualunque aspetto della vita.
Il cinema contemporaneo sembra prediligere gli aspetti più crudi e sgradevoli del nostro mondo, quelli nei quali l’eros è inquinato dalla violenza, scade nelle brutture, sprofonda nel trash. Si adeguano a questi livelli la moda, la pubblicità, la stampa, la televisione, che si appropriano delle immagini più violente e più crude rendendole quotidiane, consuete, dunque normali. Il corpo e la sua rappresentazione pornografica diventano la materia prima di chi vuole provocare attraverso una trasgressione più o meno perversa.
La pratica dello shock è condivisa con entusiasmo dagli artisti della Biennale come dai giornalisti televisivi. Considerato che la difesa del brutto sta diventando una sorta di imperativo sociale che assolve dall’obbligo di acculturarsi, converrebbe ricordare che il brutto e lo sgradevole sono necessari soltanto quando ci costringono a fare i conti con la nostra parte oscura, ma non possono assolverci dalla cattiva coscienza e dal cattivo gusto.
Guardiamo al cinema del passato, e in particolare all’opera di Luis Buňuel che nel suo complesso offre una straordinaria campionatura di sogni, fantasie, desideri inconsci, legati agli affetti, ai timori e alle ossessioni della mente.
Dal suo primo film “Un chien andalou” (1929-1931), scritto in collaborazione con Salvador Dalì (che come il successivo “L’age d’or” colpì favorevolmente lo stesso Sigmund Freud) ai suoi ultimi più noti, tra i quali prediligiamo per una rapida analisi “Bella di giorno”, Buňuel si è impegnato nella rappresentazione dell’inconscio anticipando quanto la psicoanalisi è in grado oggi di rendere più comprensibile con la teoria dell’organizzazione del Sé.

Nei suoi protagonisti proietta il proprio mondo interno.
“I sogni – ha scritto - sono la continuazione della realtà, della vita vigile, il primo cinema inventato dall’uomo, perfino con maggiori possibilità del cinema stesso. Il cinema è lo strumento migliore per esprimere il mondo dei sogni, delle emozioni, del subconscio, le cui radici penetrano così profondamente nella poesia”.

“Bella di giorno”, Leone d‘oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1967, si apre con il viaggio immaginario di Séverine con suo marito Pierre, in carrozza attraverso il verde di un parco o di una campagna.

L’idillio iniziale è bruscamente interrotto da una frase della donna –“Ho soltanto te ma..”- e dal marito che replica –“Vorrei che tu non fossi così fredda”– e subito blocca la carrozza, la fa trascinare e legare dai due cocchieri a un albero, la fa frustare e la offre a uno dei servi che la bacia sulle spalle nude. Quando Séverine sta abbandonandosi al piacere, è richiamata alla realtà nella propria camera da letto da Pierre: “A che stai pensando?“,“Sognavo di te, di noi
due, facevamo una passeggiata in carrozza”, “Sempre la carrozza..”, “Ho voglia di baciarti”.
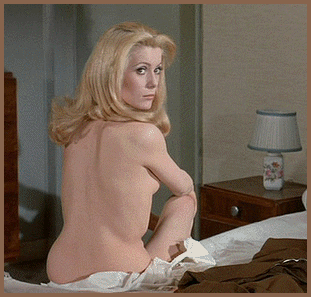
Il sogno a occhi aperti denuncia: la ripetitività dell’evasione (Sempre la carrozza), il masochismo di Séverine, la presenza di una perversione priva di sbocchi, dove il marito è l’intermediario per la ricerca del piacere in un altro uomo brutto e volgare.
Su queste premesse si snoda con ammirevole coerenza il racconto.
Meritano un’attenzione particolare le dichiarazioni rilasciate dal regista una volta conclusa la rielaborazione della sceneggiatura, scritta insieme a Jean-Claude Carrière e tratta dal romanzo “Belle de Jour” di Joseph Kassel: <<Il soggetto non mi piace per niente, l’ho accettato per riuscire a fare una cosa che mi piacesse da un’altra che non mi piaceva affatto>>.
Tra i tanti personaggi memorabili di Buñuel spicca quello di Don Juan, infelice perché conosce il desiderio e non sa o non può soddisfarlo, emblema delle velleità che non riescono a scalfire lo status quo sociale.
Don Juan emerge da protagonista assoluto, sempre riconoscibile aldilà delle variazioni di età e di nome richieste dalle storie in cui si trova inserito. Attraverso il racconto della sua vita Buñuel offre un esempio di concezione surrealista dell'esistenza, dove la realtà si salda con l'inconscio e il sogno borghese cerca riscontri impossibili in immagini reali.
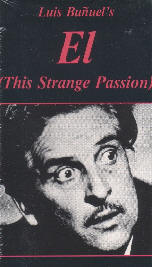
E’ un Don Juan feticista messaggero di morte nei due film girati in Messico, "El" (1952) e "Ensayo d'un crimen" (1955); è un don Chisciotte imborghesito e senza più sogni nella prima stesura di "Tristana" (elaborata sul romanzo omonimo di Benito Pérez Galdòs e messa da parte fino al 1970).

"Viridiana" (1961) propone con don Jaime le ossessioni di un don Juan invecchiato, patetico e turpe, emblema della trasgressione nell'ordine.

Buñuel si riflette nel personaggio nel momento in cui è costretto ad ammettere che il proprio desiderio di liberare lo spettatore attraverso lo schermo é del tutto velleitario. Lo spettatore non è affatto libero, il surrealismo è superato, nulla più stupisce (se non il flash dell’effetto speciale, l’allucinazione creata dalla tecnologia, che il maestro aragonese, mancato nel 1983, non ha fatto in tempo a conoscere).
Nella realtà di cui cercava una visione integrale attraverso il cinema, l’oggetto del desiderio è il non-luogo dell’utopia.
Diversa nello stile ma analoga nella sostanza è l’interpretazione offerta da Carmelo Bene nel suo “Don Giovanni”, liberamente ispirato al racconto “Il più bell’amore di Don Giovanni”, dai ”Diaboliques” di Barbey D’Aurevilly.

Dire liberamente ispirato è un eufemismo: il film è divagazione parodistica e barocco stravagante, dove il mito del conquistatore di donne è totalmente stravolto.
Il grande seduttore viene osservato con occhio beffardo nel momento in cui, stanco di prede facili, è attratto da una bambina innocente che fa raccolta di immagini sacre.
Tramite una donna precedentemente conquistata tenta di sedurla, le offre oggetti sacri, assume addirittura le sembianze del Crocifisso.
E’ tutto inutile.

Al centro del film ci sono l’ossessione per l’impotenza di fronte al mancato possesso e le velleità nelle quali Carmelo Bene rielabora un proprio personale senso di esclusione di fronte alla vita, esprimendolo in forme provocatorie, ripetute, strane, smisurate, nei costumi come nella recitazione.
Non ci sono spiragli, solo morte e autodistruzione, con il cacciatore vittima delle proprie vittime in un disordine figurativo che non rispetta alcuna regola e che sorprende il reale attraverso angolazioni nuove ed eccentriche.
Mi piace cogliere questa occasione per riconoscere le qualità e le doti di questo grande protagonista nel teatro, nel cinema e nella poesia: l’originalità anzitutto, poi la radicale contestazione delle forme, la rielaborazione del linguaggio, sia quello teatrale della parola che quello cinematografico dell’immagine, lo spiazzamento dei codici espressivi, il narcisismo spesso esasperato.
Uomo di teatro fra i più originali e discussi, ha trasferito nel cinema la sua ridondanza scenica provocatoria, aggressiva, iconoclasta con cinque film in cinque anni, dal 1968 al 1973: “Nostra Signora dei Turchi” (1968), “Capricci” (1969), tratto da “Arden of Feversham“ (opera di un anonimo inglese del 600), “Don Giovanni”(1970), “Salomé” (1972) da Oscar Wilde, “Un Amleto di meno” (1973) da Shakespeare. Sono cinque giochi di distruzione di miti e riti del teatro e del cinema, dove tutto, novità e tradizione, viene condannato senza appello.
Dagli anni Settanta ai nostri giorni l’aria dello scandalo si è andata affievolendo. Continuano a colpire e rimangono impresse delle sue opere le invenzioni formali, i funambolismi stilistici, le improvvise accensioni poetiche; soprattutto la rabbia iconoclasta che non si riduce a semplice ribellione, ma affonda le radici in una visione tragica della vita.
Rimane l’affondo della parodia, intesa come gesto critico, parodia dell’essere eroe, parodia della compiutezza dell’eroe.
L’essenza secondo Carmelo Bene è in ciò che non c’è, nel non detto, nell’ineffabile.
Concludo con quattro versi tratti da uno dei Canti orfici di Dino Campana, che Carmelo Bene tradusse in un concerto di variazioni per voce, con una premessa che cito testualmente: <<Per me la lettura, lungi dalla pretesa noiosissima di riferire lo scritto del morto orale, la lettura è non più ricordare, è non-ricordo, oblio>>.
Il canto s’intitola “Quando gioconda trasvolò la vita”.
Gli ultimi quattro versi dicono:
“Tutto ora posa in un silenzio vano
E’ falso il nulla perché dorme informe
Ah! La vita barocca pluriforme
A tradimento mi titilla piano”.
|
|
|
|
|
|
Responsabile Editoriale : Giuseppe Leo
Copyright - Ce.Psi.Di. - Rivista "FRENIS ZERO" All rights reserved 2004-2005-2006-2007-2008