-
-
-
-
- Oristano dal crollo del
Marchesato alla fusione della Sardegna col Piemonte
- (autore: Giorgio
Farris; tratto da
“Oristano la storia, le immagini”; editrice
S’alvure Oristano 1994)
-
-
-
-
-
- Sfortunata e patetica la storia di Oristano a
seguito della scomparsa del giudicato d’Arborea ed il crollo del
Marchesato, dopo le inutili impennate degli Alagon, nel drammatico epilogo della
battaglia di Macomer del 1478 contro le preponderanti forze aragonesi. Una fine
prevedibile questa del giudicato, dopo la precedente e umiliante convenzione di
S. Martino in Oristano, segnata dalle sfortunate e incalzanti vicende di
quello squallido giorno del 28 marzo 1410, dove la Spagna di Pietro IV
d’Aragona, per mano del luogotenente Torelles, poneva dure condizioni
all’Arborea con l’imposizione di un marchesato che non era più il regno
dinastico giudicale, ma che ne poneva fine, con l’inizio di una sudditanza verso
la Spagna, quasi un vassallaggio rigoroso.
- La convenzione di S. Martino, se aveva da una parte
liquidata ogni possibilità di riscossa del giudicato arborense, aveva
anche assicurato a Leonardo Cubello il riconoscimento di quasi tutto
il territorio del giudicato, ma ora, solo col titolo di Marchese di
Oristano e Conte del Goceano.
- Dopo la morte di Leonardo e poi di quella del
figlio Salvatore (1470) si era però spenta la dinastia dei Cubello ed il
Marchesato fu subito rivendicato da Leonardo Alagon, figlio della sorella di
Salvatore Cubello e di don Artale, appartenente, questi, ai “ricos
hombres” aragonesi.
-
- Leonardo Alagon
 La rivendicazione di Leonardo Alagon fu
ben presto osteggiata dal Viceré Nicola Carroz, discendente di Ugone II
d’Arborea per parte di madre, ma Leonardo si impose con la forza delle armi
nella battaglia di Uras. L’entusiasmo in favore di Leonardo fu tale da dare lo
spunto ad una rivolta nazionale che si estese dalla Barbagia al Goceano, dal
Marghine al Campidano al grido di “Arborea vaia suso Aragona vaia
juso”. La stessa capitale,
Cagliari, sede del Viceré Carroz fu minacciata dalle truppe di Leonardo. Ma la
Spagna, temendo un ritorno del nazionalismo giudicale cercò di arginare la
riscossa con forti contingenti. La battaglia di Macomer del 19 maggio 1478,
doveva purtroppo segnare disastrosamente la fine e a nulla valsero
l’entusiasmo e i tentativi di rivolta nazionale. Le soverchianti forze
aragonesi con contingenti di “spingarderos” e altre potenti armi di artiglieria giunte
dalla Sicilia, lasciarono sul campo di Macomer, dopo una dura battaglia,
una scena agghiacciante e desolante con settemila o diecimila morti
secondo le diverse fonti.
La rivendicazione di Leonardo Alagon fu
ben presto osteggiata dal Viceré Nicola Carroz, discendente di Ugone II
d’Arborea per parte di madre, ma Leonardo si impose con la forza delle armi
nella battaglia di Uras. L’entusiasmo in favore di Leonardo fu tale da dare lo
spunto ad una rivolta nazionale che si estese dalla Barbagia al Goceano, dal
Marghine al Campidano al grido di “Arborea vaia suso Aragona vaia
juso”. La stessa capitale,
Cagliari, sede del Viceré Carroz fu minacciata dalle truppe di Leonardo. Ma la
Spagna, temendo un ritorno del nazionalismo giudicale cercò di arginare la
riscossa con forti contingenti. La battaglia di Macomer del 19 maggio 1478,
doveva purtroppo segnare disastrosamente la fine e a nulla valsero
l’entusiasmo e i tentativi di rivolta nazionale. Le soverchianti forze
aragonesi con contingenti di “spingarderos” e altre potenti armi di artiglieria giunte
dalla Sicilia, lasciarono sul campo di Macomer, dopo una dura battaglia,
una scena agghiacciante e desolante con settemila o diecimila morti
secondo le diverse fonti. - Finiva così miseramente il Regno delle
dinastie giudicali, con il crollo dell’unità delle contrade e delle
masse, nel passato sempre determinante a risolvere situazioni e momenti
ardui nella lotta redentista arborense. Un crollo fatale dovuto sicuramente
a ridotte e non più aggiornate e competitive forze militari, ma anche e
soprattutto al crollo psicologico di una nazione non più nazione, che
aveva contato fino allora sulla figura carismatica del suo judike, legislatore
attento e premuroso, nonché condottiero trascinatore di masse, con alle spalle
tutta una sua tradizione dinastici autorevole e garante.
- Da quel momento Oristano non sarà più protagonista
nella storia, dovrà anzi subire soprusi, umiliazioni, spoliazioni, ruberie
d’ogni sorta e, come anche per tutte le altre contrade della Sardegna,
accettare l’amaro giogo della colonizzazione con le comprensibili
conseguenze dopo tanti secoli di creatività e di libertà.
- Dal superbo protagonismo passa al più
squallido servilismo e ha inizio il feudalesimo mai prima d’allora
conosciuto dalla civiltà giudicale, dove, in un clima di crescente sospetto, si
accentueranno anche rivalità e gelosie nell’assegnazione dei feudi, e la storia
sarà, infatti, costellata di episodi frequenti, tragici e brutali di
vendetta.
- Un amaro destino che il popolo tarda a
comprendere e ad accettare nel mezzo del disordine, delle angherie,
del disorientamento, e “su Re” sarà sempre, anche nei secoli
successivi, un punto di riferimento spontaneo e naturale, quasi
disperatamente cercato o sognato, perché nella mente e nel cuore del sardo
si guarderà sempre alla corte giudicale anche se ora inesistente: solo il
“Judike” è il sovrano, il simbolo vero perché immensamente opposti saranno
i ruoli esercitati in Sardegna dai sovrani stranieri subentrati con la
forza.
- Nella mente del sardo risuoneranno sempre,
nostalgiche, le parole solenni, regali dei “preamboli” delle “carte agrarie” dei
sovrani arborensi che parlano la lingua dei loro sudditi, la lingua del
popolo: “Nos Marianus pro
gracia de Deus Juyghi Arborée, Conti de Gocianu e Bisconti de Basso:
considerando sos multos lamentos, continuamenti sunt istados, e sunt peri sas
Terras nostrad de Arbarée, e de Logudori pro sas vingias, ortos e lavoris, chi
si disfaghint, e consumant peri sa poca guardia, e cura...”.
- E ancora: “NOS ELIANORA peri sa gracia de
DEUS JUYGHISSA d’ARBAREE. CONTISSA de COCIANI, e BISCONTISSA de
BASSO, desiderando, chi sos Fidelis, e Sudditos nostros dessu Rennu nostru
d’Arbarèe siant informados de Capidulos, ed Ordinamentos, pro sos qualis pozzant
viver, e si pozzant conservari in sa via dessa veridadi, e dessa Justicia,ed in
bonu,pacificu,e tranquillu istadu, ed honori de Deus Onnipotenti, e dessa
gloriosa Virgini Madonna Santa Maria Mamma sua, e pro conservari sa Justicia, e
pacificu, tranquillu, e bonu istadu dessu pobulu dessu Rennu nostru
predittu...”.
- Un orizzonte lontano, questo, quasi un
miraggio per i sudditi sardi, dove la nostalgia di un mondo ideale perduto
ritornava ripetutamente amara. Per lunghi secoli la “Carta de Logu”
rimarrà, comunque, in piedi come toccasana e codice insostituibile a risolvere, a
garantire, a placare gli aspetti molteplici della giustizia. Quel Codice,
con momenti autentici di una politica illuminata, con le “Carte Agrarie” volute
soprattutto da Mariano IV, rimarrà per molto tempo a coprire un vuoto, a far
sentire l’ombra di una giustizia che presto e spesso verrà purtroppo sostituita
dall’arroganza del vassallaggio, abilissimo, questo, nella inventiva di
“balzelli” e “pregoni”.
- E l’isola non sarà più considerata come un Regno, ma
come semplice preda, terra di esilio e di sfruttamento.
- I feudatari di Carlo V di Spagna passeranno
alla storia come una classe sorda ai richiami del sovrano e più intenta ad
opprimere il popolo.
-
-
- Il patrimonio monumentale e artistico del Regno
giudicale
-
- Di quel momento giudicale, possono
ancora e molto testimoniare i monumenti rimasti in piedi nell’assolato
paesaggio urbano di Oristano, dove le cadenti incrostazioni delle aggiunte
dei secoli restituiscono giorno dopo giorno molti brandelli di questa città
giudicale, ripetutamente profanata nei secoli. Il romanico ed il gotico si
intrecciano nelle sfaldature delle aggiunte stilistiche ed esprimono ancora il
meglio di una architettura che ha caratterizzato la capitale arborense, ma
anche il contado con il prezioso patrimonio di deliziose basiliche sparse
ovunque e di Cenobi con i particolari paramenti litici dal colore
locale.
- Se dovessimo per un solo momento
immaginarla questa capitale quale doveva essere, ricorrendo magari ai punti
di riferimento: le torri che ancora incidono nel dare tono e colore al
tessuto urbano, e seguendo il percorso irregolare delle mura caratterizzate un
tempo dall’ampio fossato, avremmo una immagine quasi fiabesca se, all’interno,
del disuguale tracciato perimetrico aggiungessimo il castello, il
palazzo di corte, le basiliche, quella maggiore e quelle minori, i Cenobi, i
conventi, le torrette e i posti di guardia, la ruga mercatorum, quelle
degli artigiani, le viuzze e i giardini recintati.
- Forse questa immagine così pensata avrebbe
offerto lo spunto ad Ambrogio Lorenzetti per dipingere una seconda tavola
di “Una città sul mare”, quanto quella da lui dipinta, ed ora esposta
alla Pinacoteca di Siena, che ci ricorda e ci aiuta ad immaginare questa
nostra città medievale sulla laguna.
- Una nota amara si aggiunge alla storia di
questa antica città dopo il crollo del marchesato: nei secoli che seguirono,
lentamente, quasi a brandelli, giorno dopo giorno, cadono molti dei suoi
monumenti, complice l’incuria, l’indifferenza, l’egoismo, la smania
“per il nuovo”. Così
inspiegabilmente viene demolita la “Porta a Mari”.
-
- Porta a Mari
(foto tratta da “editrice S’alvure’94”)
-
 Difficile oggi giustificare quel documento di
demolizione redatto in data 27 settembre 1906 che inchioda molti illustri
nomi del tempo sulla responsabilità dell’abbattimento affrettato per dar
luogo ad una piazza e lo sbocco diretto alla via per Cagliari, già del
resto allora esistente attraverso l’ampia porta giudicale.
Difficile oggi giustificare quel documento di
demolizione redatto in data 27 settembre 1906 che inchioda molti illustri
nomi del tempo sulla responsabilità dell’abbattimento affrettato per dar
luogo ad una piazza e lo sbocco diretto alla via per Cagliari, già del
resto allora esistente attraverso l’ampia porta giudicale.
- Infatti in tale data, così Foiso Fois ci
ricorda “... per disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione,
di pugno del Ministro che esprime il suo personale rammarico, secondo il parere
favorevole dell’allora Direttore del Museo Archeologico, prof A.
Taratnelli, del Direttore dell ‘Ufficio Regionale per la conservazione dei
Monumenti ing. Dionigi Scano, dell ‘Ing. Civico del Comune di Oristano:
Busacchi, del Prefetto Onorato Germanico, del Sindaco Alberto Sanna, del
Dott. Silvio Lippi, Direttore dell’Archivio di Stato, dell’Ing. Mariello e dell
‘Avv. Ballero Ciarello, concorde il senatore Parpaglia, veniva decretata la
demolizione della “Porta a Mari” ritenuta di nessun valore storico ed
artistico. In pari tempo veniva richiesto, da parte dell ‘Ufficio Regionale
per la Conservazione dei Monumenti, l’impegno al Comune di
salvaguardare da ulteriori danni le restanti mura ed i ruderi della adiacente
Torre di S. Filippo”.
- A ricordo di questa “PORTA”, gemella della
“PORTA PONTE” di San Cristoforo, ci è rimasta l’epigrafe del 1293, così
solennemente celebrata:
- IN NOminE DomINI NotRI
IHesV CHRISTI AMen. HOC OPus HVIus TURRIS POST COnFECTIOnEM/PorTE PVBLICE HVIus
MVR: FACTVm FVIT Hanc TVRREm/ET FABRICAM MVRI FECit FIERI DomiNus MARIAnus
VlCEcomes/DE BASSO IVDEX ARBORee QVI FELD( DIV VIV/AT ET POS(t eius) (o)BITVM IN
CHRIstO QUIESCAT/PRO CVius ANIMA QVICUMQUE HAS LITERAS LEG/ERIT INTERCEDAT AD
DomiNuM.
- MCCXCIII. InDiCione VI. /ANNO REGnI EIvs
XXVIII. (Carta
Raspi, op. cit.).
- Il contenuto di questo straordinario
documento che ha la firma, come la gemella del 1290, dello stesso Mariano
II, dice tutto sulla importanza storica di questa Porta Mare, mai abbattuta
dalle forze nemiche, ma sempre salda ed emblema di un grande giudice, ora
condottiero ora costruttore edile, che progettò, disegnò e seguì con entusiasmo
tutti i lavori di fortificazione della città giudicale erigendo le
importanti porte nei punti vitali, aperte verso il ponte sul Tirso, verso
il Barigadu e verso il porto, dotando, quindi, la città di salde mura con tutti
gli accorgimenti strategici di una fortezza militare.
- Mariano II è l’artefice di questa colossale
opera, come è anche attento stratega e uomo di raffinata cultura che si attornia
di celebrati artisti come Anselmo da Como, maestro lombardo educato alla scuola
borgognona, che, nel 1293, edificherà la spaziosa basilica gotica di S. Pietro
di Cuuri, oggi Zuri, che custodisce e compendia preziosissimi d’oltralpe ed
influenze locali, esaltando nel contempo, nei molteplici percorsi
scultorei, gli aspetti salienti della società giudicale.
- Così nella esaltazione del “ballo
sardo”, espresso nell’alta mensola
esterna della basilica, come rituale simbolico, il rilievo è volto ad esprimere
l’omaggio al santo patrono dei giurati del popolo uniti e concordi
ora, attorno alla loro basilica che frequentemente accoglierà le masse dei
villici in determinati momenti, sia per l’ elezione democratica dei
rappresentanti del popolo, sia per affrontare via, via i problemi connessi alla
vita dei paesi limitrofi confinanti col giudicato di Torres.
- Ed i simbolismi continueranno nella
mensola del fianco meridionale dove si dà rilievo alla “scrofa” che
allatta i maialetti, rimarcando in questo uno degli aspetti vitali della
economia dell’epoca che assicurava in una forma autarchica il
sostentamento annuale della famiglia. Così pure nella mensola della
“tribuna”, Anselmo da Como non a caso darà rilievo ai “falchetti nostrani”,
predatori infallibili addestrabili per la caccia e tanto ricercati dalle corti
mediterranee, europee ed orientali.
- La munificenza di Mariano traspare in tutte
queste opere non limitate esclusivamente al capoluogo.
- E l’impronta del suo intuito politico era
anche rappresentato dalla “Porta a Mare”, segno della importanza di crescita
culturale e commerciale del Giudicato arborense che guardava al mare
come libero ed aperto orizzonte.
- Quella “Porta” non avrebbe di certo oggi
sfigurato specie ora in questo contesto di crescita della città e della sua
provincia, ma avrebbe ancora rappresentato il punto simbolico di una società
nuova, orgoglio-sa della sua identità, che guarda ancora al mare.
- Se osserviamo la bellissima litografia
eseguita nel 1827 dagli architetti Cominotti e Marchesi, dove la torre
appare ancora integra con la sua porta, accanto il castello diroccato che
conserva il suo perimetro ed il Palazzo Giudicale in buono stato, nel mezzo di
una topografia urbana ben definita e pulita che non si discosta poi tanto
da quella odierna, comprendiamo ancor più il grave colpo inferto alla città agli
albori del secolo. E sono scempi che hanno spazzato via immagini vere e sacre
della storia di questa città. E sono immagini su cui l’uomo di oggi deve
soffermarsi a meditare, perché non vi è progresso senza il rispetto della
propria identità.
- Certo non si può vivere sognando la città
antica, ma è anche vero che la città moderna ha il dovere di tutelare
questa immagine, e sarebbe ora che si discutesse seriamente di questo
patrimonio che appartiene alla gente. La storia di questa città potrà
essere ancora palpitante quando la Municipalità avrà finalmente riacquisito
tutti quegli elementi mancanti, legati alla vita del castello e al palazzo
giudicale rimasti fatalmente inglobati nelle strutture del carcere.
- Come è giusto che la Basilica di S.
Francesco, il cui Cenobio custodisce documenti straordinari della cultura e
dell’arte giudicale, riottenga il suo antico Chiostro con l’annesso refettorio
dove avevano luogo le solenni ed importanti adunanze giudicali nella
lotta nazionalistica di Mariano IV e dei suoi figli Ugone ed Eleonora d’Arborea.
Riavere tutto questo significherebbe il ritorno alla “verità storica”, il
ritorno ad un patrimonio che non può oltre rimanere ingabbiato, celato,
ignorato, perché il monumento è di tutti, perché la storia è anche il monumento,
e la crescita della città è nel rispetto delle radici culturali che diventa
orgoglio nella vita operativa di tutti i giorni. L’appello non è soltanto
di oggi, ma oggi è urgente decidere nel momento in cui la città prende coscienza
ed ha una sua fisionomia ben definita di Città-guida.
- Il Chiostro di S. Francesco deve essere
restituito al suo convento per essere attivo come lo è stato nel suo
passato. Deve ritornare ad essere “cenacolo di cultura” come lo sono quelli di Alghero, di Sorres ed
altri, che sono e rappresentano nel tessuto sociale dell’isola non
esclusivamente il “cimelio”, ma elemento vivo nella vita economica e
culturale della città, del territorio, della regione.
- Questa necessaria divagazione non ci ha
allontanati dal discorso sulla presenza dell’arte nei Giudicato d’Arborea. La
fioritura del romanico e poi del gotico, adattato e contenuto,
quest’ultimo, nei suoi elementi stilistici, ci consente di ripercorrere i
“momenti” particolari dei
fermenti artistici che hanno animato l’Arborea. Maestri di chiara fama giungono
in Sardegna e operano in città e nel territorio realizzando opere
architettoniche sobrie ed interessanti con l’impiego di materiali locali
spesso anche di spoglio, che danno colore e plasticità diverse a seconda del
loro impiego.
- Ad Oristano predomina
l’arenaria sia nella architettura militare e civile che religiosa, mentre
nel territorio i paramenti litici appaiono più vari: dalla trachite rossa
ai tufo bianco, al basalto nero o grigio. Assai viva è la scuola toscana, ma non
mancano gli incontri con la scuola lombarda, con quella comacina e
campionese, con la borgognona, come non sono assenti i riscontri islamici
certamente limitati ad elementi decorativi ma densi di contenuti estetici. Opere
architettoniche che non sono sporadiche, ma frutto di una politica
amministrativa giudicale di affidare il territorio alla cura delle comunità
monastiche depositarie della cultura classica e portatrici di rinnovamento
e di tecniche più aggiornate nel campo delle diverse colture: dall’agronomia
all’apicoltura, dall’allevamento del bestiame all’arte tessile, incrementata,
quest’ultima, soprattutto dai benedettini, Frequente anche l’attività
ospedaliera in molti monasteri. Un’attività, quindi, intensa che non
trascurava nulla del territorio. Le campagne erano animate giorno e
notte da una intensa vita lavorativa.
-
-
- La Cattedrale dei Giudici
Arborensi
-
- Il trionfo del gotico nel Giudicato arborense
è segnato dagli elementi superstiti della Basilica di Santa Maria.
- Ben poco conosciamo della sua volumetria e
della suggestiva cornice che doveva caratterizzare questa basilica tanto
amata dai giudici arborensi.
- La mancanza di dati scientifici non ci
consente di andare oltre se non con la fantasia. Maria Manconi De
Palmas, nel suo rigoroso studio dedicato a questa basilica così riferisce:
“Completamente perduta è infatti, l’immagine di un’antica chiesa
ricordata da documenti del sec. XII e da due picchiotti bronzei che portano
la seguente iscrizione: AD HONOReM DEI eT MARJE eT IUDICIS MARIANI
PLACENTJNUS NOS FECIT eT COPERTURAJvI MCCXX VII ARCHIEPiscopus
TROGOTOREUS NOS FECIT eT COPERTURAm ECCLESIAE”.
- E ancora Maria Manconi De Palmas,
riferisce: “... Sopra tutti l’Aleo ne scrisse con sufficiente chiarezza e
attraverso le sue parole, gli storici hanno cercato di ricomporne l’aspetto, di
individuarne i momenti costruttivi. L’Aleo la vide ricoperta con capriate,
divisa in tre navate da due file di colonne secondo uno schema cui si informano
le più importanti chiese costruite in Sardegna nei secoli XI e XII”. “Scrisse,
infatti: “Esta Iglesia en su architectura muestra ser obra de Pisanos como la
demas Cahcdrales de la Isla. Trazeronla espaciosa, alta y capaz en forma de cruz
con tres naves que las dividen dos ordinas de colunas de una pleza depiedra
mjfnerte, cosus arcos de selleria que sustentan las paredes y el maderaje del
texado de la misma Iglesia. Toda la ohra dentro y fuera es de cantos quadrados
de color bianco colorado jy nigro entraverados con tal arte y primay que muestra
haver sido edif icio y obra Real muy vistosa y primorosa...”.
- “Chiesa insigne, dunque, improntata a quei
cromatismo che tendeva ad alleggerire i volumi spessi e conclusi del primo
romanico e che si riscontra in una serie di monumenti costruiti conforme schemi
e ornati di alcune chiese della Toscana”, Lasciamo ai lettori la conclusione di
questa immagine della basilica di S. Maria, che ci viene suggerita dalle
bellissime pagine di Maria Manconi De Palmas, che chiama in causa l’Aleo,
unico testimone oculare che neI 1684, nella sua lingua spagnola, descrive
la tipologia della Basilica e con meraviglia le sue personali impressioni
sul gioiello gotico andato poi
- distrutto.
-
- Cattedrale vista
dall’alto
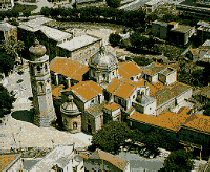
- Gli elementi superstiti, ancora suggestivi
nella loro poesia architettonica, aiuteranno il lettore a focalizzare
questa sequenza così ormai lontana nel tempo.
- Lo spazio, purtroppo, non consente di
allargare il discorso sul significato della presenza in Città e nel
territorio di altre basiliche che hanno animato l’Arborea, perché tante e
tutte importanti sono le testimonianze.
- È sufficiente il richiamo alla sola
elencazione e datazione di quelle della sola città-capoluogo per comprenderne il
loro ruolo nei secoli: Chiesa dello SPIRITO SANTO (IX-X sec.)/S. GIUSTA (anno
1140)/Cattedrale di S. MARIA (anno ?)/ SAN PIETRO DE CLARO o SANCTUS PETRUS DE
EPISCOPIU (anno 1131?)! San NICOLA DI GIURGO (anno 1182?)/ S. ANTONIO ABATE
(anno 1175)/S. MARTINO (anno I228)/S. FRANCESCO (anno 1250)/LA MADDALENA (anno
I325)/S. LAZZARO
 (1336)/S. CHIARA (1343).
(1336)/S. CHIARA (1343).
-
- Chiesa di S.
Chiara (interno)
-
- Dalla
dominazione spagnola in poi: S. SEBASTIANO (I500?)/S. VINCENZO (?)/S.
GIOVANNI BATTISTA EXTRA MUROS (1500)/CHIESA DEI CAPPUCCINI (1608)/S.
DOMENICO (1634)/S. SATURNINO (1500)/S. GIOVANNI EVANGELISTA (1662) nel vecchio
Liceo De Castro/S. EFISIO (1660?), costruita dopo la peste del 1652-1656./CHIESA
DEL CARMINE (1736)/CHIESA DELLE CAPPUCCINE (1738)/ S. CATERINA (1730) di fianco
alla PORTA MANNA, fu abbattuta nel 1903/SS. TRINITÀ (anno ?), dirimpetto
al Duomo, già sede dei Gremi dei ‘Terrai”, “Falegnami”, “Contadini” ./ S.
LUCIA (1770)/SANTUARIO DEL RIMEDIO (anno ?), era l’antica parrocchia
di Nuracraba. Non è menzionata nella Ratio Decimarum Sardiniae (1342-1359) e
neppure nell’Atto di pace fra Aragona e Arborea (24 gennaio 1388). Questa
elencazione qui proposta può apparire esagerata per il numero delle chiese, se
rapportata alla contenuta topografia urbana della città giudicale
(escludendo quelle sorte dal ‘500 in poi), ma i monasteri nel medioevo, piccoli
o grandi che fossero, assolvevano ai diversi problemi che poteva porre un
territorio urbano o extra urbano, compresi i problemi umanitari, di
assistenza, di soccorso, di consulenza, ecc.
- Inoltre la stessa corte si
serviva di prelati colti per la cancelleria giudicale: per gli atti notarili,
per i donativi, per le ambasciate, per i rapporti politici con gli altri
stati e con la stessa Chiesa di Roma, per i trattati, per tutti i problemi
connessi alla città e al territorio, anche se le Curatorie avevano i loro
rappresentanti e gli ufficiali regi.
- Uno sguardo alla documentazione cancelleresca
è sufficiente a dimostrare quanto questa fosse complessa e rigorosa, non solo
per l’aspetto calligrafico amanuense, ma anche per l’uso frequente del latino,
dello spagnolo, del sardo e dell’italiano.
- In tutto questo si profila il grande ruolo
svolto dalle comunità monastiche nel mondo giudicale ed il conseguente
apporto dato alla storia e alla cultura nella custodia dell’immenso
patrimonio monumentale e artistico.
-
-
- Artisti di Corte a Oristano
-
- Non deve meravigliarci la presenza di maestri
di corte ad Oristano. I giudici arborensi erano nobili di casta, studiavano
in Spagna e possedevano una buona cultura non soltanto militare. Tessevano
rapporti continui e diretti con tutte le corti europee e amavano anche l’arte.
Ecco, infatti, giustificatissima la presenza di maestri toscani o non
toscani nella Basilcia di Santa Maria, sede vescovile, ma anche punto di
riferimento e di prestigio della corte giudicale fedele alla Chiesa di Roma.
Ecco il toscano Nino Pisano, autore dell’Annunziata la cui immagine è
vibrante nei suoi canoni gotici, evidenziati da quel movimento corporeo
spontaneo e armonioso che accompagna e accentua l’espressione di turbamento
della Vergine, per l’improvvisa apparizione dell’Angelo Gabriele. Il gruppo
ligneo policromo del Duomo appare ora smembrato e privo dell’angelo Gabriele che
ha trovato la sua nuova collocazione nella parrocchia di Sagama e non si sa in
quale data e circostanza. È probabile che questo gruppo, così stranamente
composto di statue e basamenti separati, servisse a soddisfare esigenze
coreografiche in determinate solennità religiose.
- Attribuita ancora a Nino Pisano è la statua
marmorea di S. Basilio del convento di S. Francesco di Oristano. Pare che la
statua fosse policroma per la presenza di tracce d’oro e di altri colori che
evidenziano un arabescato disegno floreale che caratterizza la mitra e la
tunica, mentre il “rivolto” di quest’ultima è colorato in azzurro. Detta
statua ha una forte espressività e si regge su un basamento ottagonale su
cui è incisa a caratteri gotici la scritta: “‘ Ninus: Magistri : Andree: De
Pisis : Me Fecit”.
- Ma la Basilica gotica di S. Francesco,
diventata poi neoclassica, ci serba ancora delle sorprese con i suoi
preziosi cimeli ricchi di preziosissimi decorativi: le croci astìli d’argento,
reliquiari, tavole dipinte, ecc. e, soprattutto i manoscritti di canto
gregoriano in “maggior parte tutti meni branacei, in pergamena (membrana
animale, soprattutto ovino) risalenti in buona pur-te ai secoli
XIV-XV”.
- Ma in alcune carte di guardia (pagine
normalmente più antiche, che f ungevano da protezione al cosiddetto
corpus libri) sono presenti frammenti provenienti da libri risalenti al sec.
XII-XIII’.
- “... La scrittura musicale di queste opere
rappresenta uno dei più antichi esempi di notazione quadrata
documentati in Sardegna”.
-
 Il discorso
vale anche per i manoscritti appartenenti alla Basilcia di Santa Maria. Grande
attenzione merita il Crocifisso ligneo detto di Nicodemo della stessa
basilica di S. Francesco. E l’opera scultorea sacra più impressionante
dell’arte italiana medievale, per il suo profondo realismo che prelude già al
Rinascimento: il “pathos” dell’atroce agonia è espresso qui con rigore
e l’ignoto artista crea la più rara immagine plastica del “trapasso”: la cassa
toracica del Cristo si dilata, gli arti si con-traggono in un ultimo sforzo; gli
occhi si velano, la bocca si dischiude per esalare l’ultimo respiro. Una
immagine commovente, di straordinario valore artistico. E attribuita alla
scuola spagnola, ma secondo Remo Branca rivela riscontri renani (Farris,
op. cit.).
Il discorso
vale anche per i manoscritti appartenenti alla Basilcia di Santa Maria. Grande
attenzione merita il Crocifisso ligneo detto di Nicodemo della stessa
basilica di S. Francesco. E l’opera scultorea sacra più impressionante
dell’arte italiana medievale, per il suo profondo realismo che prelude già al
Rinascimento: il “pathos” dell’atroce agonia è espresso qui con rigore
e l’ignoto artista crea la più rara immagine plastica del “trapasso”: la cassa
toracica del Cristo si dilata, gli arti si con-traggono in un ultimo sforzo; gli
occhi si velano, la bocca si dischiude per esalare l’ultimo respiro. Una
immagine commovente, di straordinario valore artistico. E attribuita alla
scuola spagnola, ma secondo Remo Branca rivela riscontri renani (Farris,
op. cit.). -
- il
Crocifisso di Nicodemo
-
-
-
- L’epoca spagnola
-
- La sanguinosa sconfitta subita da Leonardo
Alagon nell’ultima disperata battaglia di Macomer (1478), segna la scomparsa del
Marchesato di Oristano e pone fine a quella lotta redentista durata un secolo e
mezzo (dall’epoca giudicale) contro l’egemonia straniera. Una lunga lotta, con
l’aggiunta di pestilenze e carestie che spolperà totalmente l’isola
riducendola a centocinquantottomila abitanti. Avvenuta l’unificazione
dell’Aragona con la Castiglia, la Spagna, sotto lo scettro dei re cattolici
Ferdinando II e Isabella di Castiglia, allunga la sua ferrea dominazione in
Sardegna con la nomina del Viceré Ximene Perez Scriva de’ Romani, principe
corrotto e venale che farà pesare ai sardi la sua politica. Ma la Sardegna
peggiorerà ancora con la reggenza di Inigo Lopez de Mendoza. Ferdinando promuove
azioni riformistiche che miravano però a rafforzare
esclusivamente l’autorità del
governo spagnolo. In questa fase di riforme si possono ricordare tre
avvenimenti: il primo per la convocazione dei Parlamenti negli anni 1481-85;
1497-1511. Tali Parlamenti non produssero nulla di nuovo e di concreto per
i sardi, ma si caratterizzarono per la “corsa all ‘accapparramento dei
privilegi” fra i tre “ordini”
del regno: il reale, il feudale, l’ecclesiastico.
- Il secondo, perché la Sardegna vede
l’istituzione nel 1492 del Tribunale dell’Inquisizione, il terzo,
perché si assiste alla espulsione della classe commerciale ebraica per non
essersi convertita.
- Al provvedimento seguiva l’incameramento
dei beni (le Sinagoghe) alla Corona. Con l’istituzione del tribunale
dell’Inquisizione, gli ordini religiosi venivano a trovarsi sottoposti ai
Vicari di Spagna e non più agli ordini ecclesiastici italiani.
- La Sardegna era, quindi, un regno
caratterizzato dal governo retto dal viceré residente a Cagliari, ma
dipendente dal sovrano.
- Il Parlamento sardo era formato dai
rappresentanti delle classi sociali dette “STAMENTI” o “BRACCI”.
- Il Regno, inoltre, era costituito da città
autonome con i propri naturali territori, rette da magistrati che,
a seconda delle
scelte, potevano essere capitani, vicari, podestà indicati questi dal popolo.
Queste autorità erano nominate dal sovrano e dovevano offrire col giuramento
fedeltà alla corona.
- Città autonome erano Cagliari, la capitale,
Villa di Chiesa, Oristano, Bosa, Alghero, Sassari e Castel Aragonese.
- I territori, suddivisi in “Capo di
sotto” e “Capo di sopra”,
erano controllati da due
Governatori: il primo con residenza a Cagliari, ed il secondo a
Sassari.
- Anche sotto il regno di Carlo V (1516-1556)
la Sardegna non ottiene grandi benefici, perché continuerà ad essere
soggetta a un regime di sfruttamento regio e feudale con qualche piccolo
spiraglio di progresso. Tra le iniziative, merita comunque una menzione la
introduzione a Cagliari dell’istituto Padre d’Orfani per la assistenza agli orfanelli e ai
derelitti onde avviarli verso un proficuo ed onesto mestiere.
- Sotto il regno di Filippo II(1556-1598),
figlio di Carlo V, passato alla storia come il “cattolicissimo”
per il suo trionfo sul
protestantesimo dilagante e per la supremazia sull’Europa, per la Sardegna
saranno anni di progresso: si sviluppa una nuova coscienza dei sardi,
migliora l’agricoltura, un miglioramento anche nella amministrazione della
giustizia; la riforma della Reale Udienza (il massimo tribunale e organo
consultivo per gli affari di governo del Viceré); la regolamentazione
dell’istruzione col divieto di accesso alle cattedre episcopali sarde
di prelati stranieri. In questi quarant’anni di regno, inoltre, Filippo II si
prodigò per la difesa degli attacchi barbareschi con la costruzione lungo le
coste di una cortina di torri. Fu incoraggiata la cultura sostenendo
iniziative locali di enti e di privati. Intensa, poi, l’attività artistica
degli argentieri sardi e degli scultori e decoratori su legno, dediti alla
creazione di “retabli”.
-
-
- Il
saccheggio degli Ugonotti
-
-
-
- Durante il regno di Filippo IV (1621-1665),
Oristano dovrà subire l’orribile saccheggio di un corpo di spedizione
francese.
- L’episodio è uno dei tanti della lunga guerra
dei “Trent ‘anni” che
coinvolse nel 1618 i paesi della Boemia, dell’Olanda, della Germania, della
Spagna, della Francia e dell’Italia.
- Ma la vicenda di Oristano si riferisce
all’ultimo periodo, quello francese, che vide, a partire dal 1635, le
strategie contro la Spagna ad opera del Richelieu, del Condé e del
Turenna.
- Nell’inverno del 1637 giunse nel
Mediterraneo dall’Atlantico una potente flotta composta di quarantasette
galeoni al comando del conte di Harcourt e dell’arcivescovo di
Bordeaux, Antonio di Borbone (Antonio Sourdis d’Escobleau secondo il La
Marmora).
- Compito della flotta era quello di portare
soccorso al duca di Parma il cui territorio era stato occupato dagli spagnoli,
ma nel frattempo il principe spodestato era stato rimesso sul trono dagli stessi
spagnoli e quindi la mossa francese risultò vana. Agli ugonotti non rimase altro
che ritirarsi e ripiegare sulla Sardegna, allora colonia spagnola, per colpire
la Spagna in un punto nevralgico.
- La Sardegna si trovava allora assai
sguarnita di milizie, in un territorio così vasto poteva contare su un
corpo composto complessivamente di quindicimila unità di cavalleria e cinquemila
di fanteria distribuito in tutta l’isola, e perciò l’impresa di conquista
parve ai francesi assai allettante in partenza. 1121 febbraio del 1637
sull’orizzonte dell’ampio golfo di Oristano apparve l’enorme flotta nemica
di 47 galeoni che bombardò a breve distanza l’unica torre di difesa
che oggi porta il nome di Torre Grande, mettendo in fuga i pochi difensori che si
precipitarono in città per informarne l’alcaide.
- Sulla murata della torre, nella parte alta
che guarda al mare, sono ancora visibili i grossi proiettili sferici infissi.
Oristano fu presa dal panico e molti ripararono nei dintorni.
- Il colonello don Luca Nieddu radunò la sua
cavalleria e attese gli eventi sul “poggio” di Santa Giusta; altrettanto fecero
il vescovo Vico, l’intero Capitolo ed il clero.
- Gli invasori, in maggior parte ugonotti
ticonoscibili dalle rigonfie “brache” gialle, entrarono in Oristano senza
incontrare alcuna resistenza, capeggiati dal conte di Harcourt e
dall’arcivescovo di Bordeaux. Si calcola che circa cinquemila uomini
secondo i dati storici francesi, e undicimila secondo le notizie
sardo-spagnole, invasero Oristano occupandola interamente e dan-dosi subito al
saccheggio. Altrettanto fecero le altre truppe ugonotte nei paesi vicini.
- Erano giorni di Carnevale e nelle case
oristanesi non mancavano dolci e vernaccia, perciò le strade deserte di civili
si riempirono ben presto di un esercito di ubriachi.
- Questo particolare lo riferisce Diego
Masones, un ufficiale sardo veterano della guerra di Lombardia e delle
Fiandre e conoscitore della lingua fiamminga che,
travestitosi in quelle giornate oristanesi da soldato ugonotto, era
riuscito a penetrare nella città per rendersi conto della
situazione.
- Subito dopo lo stesso Masones tese degli
agguati e insistette sulla strategia della “beffa”,
iniziata dal colonnello Nieddu, ripetendo i giri dei miliziani a cavallo
attorno al poggio della Basilica di S. Giusta, in attesa che giungessero i
rinforzi.
- Questa strategia allarmò gli ugonotti che
credettero ad un massiccio assembramento di truppe e
si prepararono di conseguenza
ad abbandonare la città. Nel medesimo tempo, in un estremo tentativo, il
conte di Harcourt tentò di parlamentare con l’arcivescovo Vico chiedendo come
condizione alle truppe di S. Giusta di deporre le armi.
- Ma le bande del Masones e del Nieddu
risposero con un assalto alle mura della città coadiuvate dalla cavalleria
miliziana giunta improvvisamente dal Sud al comando dell’Aymerch con don
Francisco Villapaderna e i capitani Fortesa e Furca. Poi sopraggiunsero quelli
di Laconi e di Quirra con don Girolamo Pitzolo, Bernardino Solivera e Gaspare
Pira di Oristano.
- In quella notte del 26 febbraio la città, prima del
ritiro degli ugonotti, subì un orribile saccheggio e non furono rispettate
neppure le chiese e i monasteri. I francesi lasciarono la città carichi di
bottino con alle spalle le altissimi fumate degli incendi da loro
provocati.
- Ma i miliziani sardi non indugiarono e
passarono all’inseguimento partendo da diversi punti della pianura (Gregori,
Fenosu, Benaxi) e investendo ai fianchi e alle spalle gli ugonotti. Altri
attraversarono il guado “Bau de procus” a valle della Chiesa della Maddalena.
- Nei pressi del Ponte Grande
sul Tirso, in località
“su palon i”, le bande
del governatore Aragall e quelle comandate dal capitano Fortesa
assalirono le truppe dell’arcivescovo di Bordeaux che abbandonò il campo
affidando i suoi soldati al conte di Harcourt.
- Altre bande di miliziani giungevano da
Pozzomaggiore al comando del Quesada che incalzava fino all’abitato di Cabras,
altre ancora da Ghilarza, Aidomaggiore, Paulilatino e Abbasanta comandante da
don Salvatore Madau e Giovanni Mameli. La morsa dei sardi fu talmente tempestiva
che a nulla valsero i diciannove lancioni carichi di cannoncini e fucilieri
francesi che, risalendo il fiume Tirso, cercavano di sbaragliare le bande
sarde.
- Nella battaglia le perdite furono rilevanti
per ambo le parti. I francesi perdettero diverse centinaia di uomini, trentasei
prigionieri, diversi cannoni, armi, undici lancioni e parte del bottino, e
in più otto bandiere di cui quattro sono andate alla Spagna e le altre ai sardi.
Quattro di questi vessilli figurano ancora oggi nelle pareti del “transetto” del
Duomo di Oristano.
- Ai prigionieri di guerra francesi,
impiegati successivamente per le riparazioni delle mura di Oristano, fu
assegnata la paga giornaliera di ventiquattro centesimi; al nobile ufficiale
Carlo de Roussaay, comandante di uno dei lancioni, quella di novantasei
centesimi “dopo aver ricevuto le cure mediche dal chirurgo maggiore del
reggimento”.
-
 Duomo di Oristano (esterno ed
interno)
Duomo di Oristano (esterno ed
interno)
-

- Fino a qualche decennio, la sera del 26
febbraio nell’anniversario di questa vittoria, nell’interno del duomo di
Oristano si eseguiva una processione di ringraziamento accompagnata dal
suono delle campane.
- Nei
“eomentarios” spagnoli dell’epoca, fa spicco il racconto di un certo
“Fra Giusto” dell’ordine degli ospedalieri che ebbe un ruolo importante
nella battaglia contro gli ugonotti, offrendo anche il suo coraggioso contributo
nell’atterrare personalmente una cinquantina di avversari, Questa impresa, in
contrasto del resto con l’abito del religioso, trova spiegazione seguendo
la lettura avvincente delle sue peregrinazioni.
- Fra Giusto era un nobile di Toledo, Don Diego
Duca de Estrada, un nobile hidalgo che si fece religioso dopo tante avventure
costellate di incontri galanti, duelli e uccisioni, ma sfuggì sempre al
capestro.
- Come principe fu a Venezia nel 1627 e dopo a
Padova dove frequentò quella Università dedicandosi poi a scritti letterari
e filosofici.
- Ebbe quindi grandi incarichi di comando
e combatté in
Africa, in Italia, nel mediterraneo contro i pirati e poi in Germania,
coprendo anche l’incarico di governatore della città di Frauenberg.
- Dopo l’amara e improvvisa perdita della
moglie e dei sei figli, entrò in crisi e si fece religioso.
- È in questa veste che lo troviamo quindi a
Cagliari come consigliere del viceré nell’anno corrispondente allo sbarco degli
ugonotti ad Oristano. E fu proprio lui a suggerire l’attacco a sorpresa della
cavalleria miliziana partecipando di persona.
- Una delle tante descrizioni
spagnole su questa impresa di Oristano, porta la firma di Fra Giusto Duca de
Estrada, con una particolare dedica al suo sovrano di Spagna.
- L’attacco
francese contro Oristano, aveva allarmato la Spagna, tanto da indurla a
progettare adeguate azioni di difesa.
- Si pensò subito ad una flotta sarda, e lo
stesso Aragall, capitano generale del Regno di Sardegna, avanzò proposte
operative dando l’incarico di progettazione all’ingegnere militare Alongo
de Cisneros che pensò ad una costruzione di un forte presso la foce del Tirso e
ad uno sbarramento a mare per impedire eventuali invasioni, (G.
Sorgia, op. cit.).
- Ma l’episodio di Oristano ripropose
soprattutto l’urgenza di assegnare alla Sardegna una propria flotta di
almeno otto galee.
- Purtroppo, le lungaggini burocratiche e le
divergenze sorte tra il sovrano, l’ammiragliato genovese e gli Stamenti
sardi lasciarono tale opera sulla carta.
- Il progetto, che stabiliva un onere per la
Sardegna di una “fornitura annua di 25.000 starelli di grano, di 18.000libbre
in moneta per il vettovagliamento delle navi, consistente in biscotto, vino,
carni salate, tonno, legumi, olio, aceto e sale”
non prevedeva, purtroppo,
l’imbarco su ogni galea di allievi isolani atti ad apprendere l’arte della
navigazione e non rispettava neppure le altre richieste degli Stamenti sardi che
prescrivevano l’autorizzazione al trasporto di passeggeri dell’isola.
- Soltanto nel 1639, dopo che Filippo IV dava
l’investitura a Giovanni Andrea Doria di luogotenente e capitano generale del
Regno di Sardegna, con giuramento a Cagliari, si vide la realizzazione dello
allestimento delle prime due navi della flotta, come aveva prescritto il
Consiglio di Aragona.
- Ma dovettero, purtroppo, passare quasi altri
vent’anni per vedere in attività la terza nave, con la comprensibile
delusione dei sardi che avevano sognato una marineria propria.
-
-
- Sotto il Regno di Carlo II di Spagna due delitti scuotono
l’isola
-
- Sotto il regno di Carlo II(1665-1700) si
avvertono nuovi dissapori tra la nobiltà sarda e la Spagna per le continue e
inutili richieste relative alle cariche e agli impieghi del regno che
escludevano i sardi. In questo clima di tensione il Parlamento sardo doveva
decretare nel 1665 la richiesta di
un “donativo” di
settantamila scudi al re di Spagna, ma don Agostino di Castelvì teneva testa al
Viceré sottolineando le gravi condizioni di povertà della Sardegna e
l’assurda pretesa di un “donativo extra” al sovrano. Gli stamenti, dopo tante
resistenze, erano giunti ad una proposta che pareva accettabile: un
donativo ridotto al re in cambio dell’impegno di riservare ai sardi gli impieghi
pubblici. Il Parlamento venne sciolto senza alcuna soluzione dei problemi
trattati.
- Dopo alcuni giorni, nella notte del 20
giugno del 1668, il Castelvì, ormai noto come difensore dell’Isola, fu
assassinato. Il delitto fu attribuito alla giovanissima sposa del Castelvì,
Francisca Zatrillas, ultima feudataria del Montiferru, signora del castello
di Cuglieri, e al presunto amante don Silvestro Aymerich.
- Dopo quattro settimane il Viceré don Emanuele
de los Cobos marchese di Camarassa, cadeva a sua volta assassinato con venti
colpi di archibugio. Questo fatto inchiodava le famiglie degli indiziati e dura
fu la rappresaglia della Spagna. E come in tutte le tragedie, ecco la fatalità a
premere ancora sul triste epilogo con l’affrettato matrimonio del 1669 tra
Franzisca Zatrillas e l’Aymerich che, oltre a rimarcare i sospetti,
incoraggiava i giudici ad emettere anche il secondo capo di accusa di
“cospirazione organizzata” contro il Viceré. Feroce quindi la sentenza
con la condanna a morte degli amanti e la caccia spietata a tutto il parentado
del Castelvì che, in parte, trovava rifugio a Nizza, assieme alla Zatrillas
condannata in contumacia e ormai priva del suo feudo. Ma il vecchio
marchese di Cea, don Giacomo Artal di Castelvì e l’Aymerich non sfuggivano
alle milizie e venivano presto giustiziati con la decapitazione.
- Il primo a cadere fu l’Aymerich la cui testa
mozzata, infissa ad una picca fu portata in un macabro corteo lungo i paesi
dell’isola come segno ammonitore, preceduto dal lugubre rullare dei tamburi.
Seguiva il boia a cavallo, quindi il vecchio marchese di Cea trascinato in
catene. Poi, la sera del 15giugno 1671, nella piazzetta della Torre di San
Pancrazio, la mannaia staccava la testa del marchese.
- Per circa 20 anni le teste dei poveri
sventurati rimasero esposte nella Torre dell’Elefante, in una gabbia
di ferro agitata dal vento.
- Il “seicento” è un secolo amaro per Oristano.
Si assiste ad un preoccupante calo demografico, del resto iniziato assai prima
della fine del marchesato.
- Le continue carestie sono rese ancor più gravi dalle
invasioni di cavallette che piombano dal mare distruggendo le
campagne.
- È nota quella del 1647 dove “un immenso nembo
di cavallette portato dal vento dell‘Africa cade sopra la Sardegna
meridionale donde poi diffondersi nell‘altre parti. La quantità era così grande
che nelle campagne coprivano i campi, le vie, i pantani, i tetti, i pozzi, le
pareti e l’interno delle case, e quando riscaldatasi l’atmosfera si levavano a
volo facean ombra sopra il suolo sul quale portavansi in grandissimi
sciami. Il danno che fecero sopra i seminati, le vigne, i verzieri fu
incalcolabile”.
- Questo flagello, che perdurò per ben
cinque anni, fu talmente grave da indurre gli abitanti a panificare con la
farina ottenuta dalle ghiande del monte Arci. (R. Bonu, op. cit.).
- A questo male, si aggiungeranno, poi, le
scorrerie improvvise e continue dei mori barbareschi e dei briganti dei monti di
Arbus, che rendevano insicuri i paesi e pericolosa la vita delle campagne.
- Poi, infine, la peste bubbonica del 1652 che,
perdurando per quattro anni, spolperà letteralmente la città e molti altri
centri, riducendo la popolazione sarda ad un terzo dei suoi abitanti.
- Nonostante la gravità di questi eventi, a cui
si aggiunge anche l’assalto degli ugonotti del 1637, Oristano è come
percorsa da un febbrile desiderio di rinascita, quello stesso che ispira i
sardi con i suoi stamenti a migliorare le condizioni dell’isola.
- Nel 1676, sotto il regno di Carlo II di
Spagna, sorgono le scuole Pie Calasanziane curate dagli Scolopi grazie alla
munificienza del mercante oristanese Michele Pira che elargiva l’enorme
somma di cinquantamila scudi per tale opera bene-merita.
- Le scuole Calasanziane andavano ormai
diffondendosi, dando un notevole contributo alla formazione dei cittadini e
costituirono proprio la base storica dei futuri ginnasi dell’isola.
-
-
Comune di oristano & statua di
Eleonora
-
 Quella di Oristano, funzionante
nell’antico edificio degli scolopi, oggi sede del Comune, perdurerà
fino al 1866 dopo la soppressione che darà luogo al Regio
Ginnasio.
Quella di Oristano, funzionante
nell’antico edificio degli scolopi, oggi sede del Comune, perdurerà
fino al 1866 dopo la soppressione che darà luogo al Regio
Ginnasio. - Questo
tipo di scuole, caratterizzate dal rigore degli studi, formeranno studiosi come
Vittorio Angius e Tomaso Napoli.
- Come si ricorderà, le Scuole Pie
Calasanziane erano sorte a Roma dopo la peste del 1590 che aveva falciato
la città lasciando sul lastrico una moltitudine di ragazzi sbandati. Un
umile monaco spagnolo di grande cultura e umanità, Giuseppe Calasanzio, figlio
di un “hidalgo”, don Pedro de Calasanz, giudice Conciliatore di Peralta de la
Sal, li aveva raccolti amorevolmente in collegio, creando le Scuole Pie e
avviando così i giovani ad un avvenire sicuro.
- Oristano già vantava scuole di istruzione
popolare di discreto rilievo, come la “Scuola di grammatica” annessa al
convento francescano di S. Giovanni Evangelista la cui sede si trovava
proprio di fronte al palazzo giudicale.
- L’edificio fu abbandonato dai frati nel 1866,
con la legge dell’incameramento dei beni ecclesiastici, stabilendo la nuova
sede, su bolla dell’arcivescovo Bua, nel convento della Maddalena, anch’esso dei
minori osservanti già dal 1459 con bolla del Pontefice Pio II su richiesta del
marchese Salvatore Cubello e indirizzata all’Archiepiscopo Arborensi Jacobo
De Albareale.
-
-
-
-
-
- La storia di Oristano è
inglobata in quella della Sardegna.
- (autore: Giorgio
Farris; tratto da
“Oristano la storia, le immagini”; editrice
S’alvure Oristano 1994)
-
-
-
- La breve dominazione austriaca in Sardegna
-
-
- Complessi gli avvenimenti che hanno
favorito l’ingresso della Signoria austriaca in Sardegna.
- Deceduto Carlo II di Spagna e privando il regno di eredi diretti, si
scatena la guerra di successione (1700-1713).
- Tutto partì da Vienna, quando l’arciduca
Carlo d’Asburgo, secondogenito dell’Imperatore Leopoldo, facendosi forte
del diritto dinastico, si proclamava re di Spagna col riconoscimento di
importanti stati come la Germania, l’Inghilterra, e i Paesi Bassi.
- La Spagna contestava la pretesa dell’Austria
sostenendo il diritto alla successione di Filippo di Borbone, nipote del Re
Sole, perché designato alla successione per testamento inviolabile. La guerra
divise anche la nobiltà sarda, specie per i rapporti sempre tesi tra
Capo di Sotto e Capo di
Sopra. Ma Carlo III, che nel frattempo era passato in Spagna, occupò la Sardegna
il 13 agosto 1708 dopo un bombardamento su Cagliari della flotta
anglo-olandese al comando dell’ammiraglio Lake.
- Le ferite della battaglia sono ancora visibili
nelle facciate dei grossi palazzi del Castello che guardano al mare, La
pace di Utrecht (1713) ed il successivo trattato di Rastadt (1714) decisero
della sorte dell’isola che passerà all’Austria.
- La Signoria Austriaca nulla diede in otto
annidi governo alla Sardegna, se non altre tasse.
- Nel frattempo Filippo V, che dai
precedenti trattati aveva ottenuto la Spagna, occupò nuovamente l’isola, ma
nel 1718 il Trattato di Londra che poneva fine alla guerra, stabiliva una
definitiva suddivisione: la Spagna restituiva la Sardegna all’Austria che
doveva a sua volta cederla alla Casa Savoia in cambio della Sicilia assegnata
all’Austria.
- Per la Sardegna, così lacerata e contesa,
doveva iniziare un ennesimo calvario sotto un regno ancora diverso. L’umore
dei sardi non era certamente alto poiché la speranza si mischiava alla
diffidenza, sebbene il “Trattato di cessione” si presentasse garante
per i sardi in quanto sanciva il rispetto assoluto di tutti gli ordinamenti e i
privilegi che la Spagna in quattro secoli di dominazione aveva concesso
all’isola.
-
-
-
- Il Duca di Savoia assume il titolo di Re di Sardegna
-
- Vittorio Amedeo II, duca di Savoia,
conformemente al Trattato di Londra prende possesso dell’isola assumendo il
titolo di Re di Sardegna. È l’otto agosto del 1720. L’undici settembre, Don
Filippo Guglielmo Pallavicino, barone di S. Remy, prende possesso dell’isola con
la carica di primo Viceré Sabaudo.
- Il Viceré ereditava una Sardegna in preda
all’anarchia, lacerata dalle discordie e dalle fazioni generate dall’odio
politico. I paesi erano in preda a bande armate che saccheggiavano
e uccidevano per rancori personali in nome di occasionali e assurdi
pretesti politici.
- Sotto questo clima languiva la classe
emarginata dei pastori e dei contadini, impoveriti dalle rapine dei
“donativi” straordinari per spese di guerra e dalle “decime” al clero.
- Il nuovo governo iniziò con una amnistia e
con una amministrazione saggia e di tutela del cittadino, tanto da placare gli
animi e riportare la serenità nelle campagne e nei villaggi.
- Anche Carlo Emanuele III (1730-1773), nei
suoi 4 anni di regno continuò la medesima politica del padre promuovendo riforme
e inviando in Sardegna due Viceré: i marchesi Rivarolo e Valguarnera, per
combattere le bande che spadroneggiavano nell’ isola.
- È nota l’ordinanza del Viceré marchese di
Rivarolo contro l’uso della barba pena il pagamento di quattro scudi o un mese
di carcere.
- Tale ordinanza del 1738, doveva
agevolare i gendarmi piemontesi nella individuazione dei banditi resa
assai difficile, appunto, dalle foltissime barbe, dall’uso delle lunghe
capigliature e del costume maschile uguale dappertutto.
- L’argomento meriterebbe più spazio per
comprenderne il problema del banditismo che non era un fenomeno
esclusivamente sardo, ma che nasceva dalla sfiducia dei sudditi verso
lo stato e la giustizia, e dalla miseria dilagante.
- Fu soprattutto il ministro Bogino a prestare
maggiore attenzione ai problemi della Sardegna, nonostante la sua fermezza nel
combattere la delinquenza, con la ricostituzione dei Consigli Civici e
Comunali onde renderli più operativi nell’interesse dei cittadini che
volevano uno stato più premuroso. Ricostituì anche le due Università con
l’aggiunta di nuove cattedre e rinomati docenti. Pose mano
all’istituzione scolastica con l’uso obbligatorio della lingua italiana.
Favorì l’agricoltura e pose il riordino dei Monti Frumentari. Incoraggiò
l’affluenza nell’isola di coloni italiani dalla cui opera sorsero i centri
cittadini di Calasetta, Carloforte, S. Antioco, Montresta e l’Asinara.
- La popolazione dell’isola in 62 anni
passerà da 300.000 a 436.000 abitanti.
-
-
- La forca piemontese contro i ribelli e i banditi
-
- Per meglio comprendere la grave
dimensione che aveva assunto il banditismo in Sardegna, sono sufficienti
ricordare, tra i tanti, due soli episodi. Quello dell’ 734 che vede entrare in
azione, dopo i diversi tentativi dal 1722 in poi, un esercito di truppe
regolari chiamato ad assediare il Monte Cuccaro presso Aggius in Gallura, teatro poi di tante
battaglie.
- In questo monte granitico, stupendo nel suo
paesaggio, caratterizzato da grotte, labirinti e anfratti naturali, si erano
rifugiati duecento banditi con le rispettive famiglie provenienti dai centri del
Logudoro, Goceano e Gallura. Vivevano di contrabbando con la vicina
Corsica, L’episodio del 1734, frutto della politica del Rivarolo, vide gran
parte dei banditi impiccati sul posto.
- Ma nel 1745 i dragoni piemontesi
venivano disastrosamente sbaragliati lasciando sul terreno un centinaio di
morti, anche grazie all’intervento degli abitanti di Aggius in favore dei
ribelli. Tra questi si segnalava la presenza di diversi esponenti della nobiltà
sarda ostile alla dinastia sabauda: donna Lucia Delitala di Nulvi con i fratelli
don Pietro, don Antonio e don Francesco, poi Giovanni Fois di Chiaramonti,
Pietro Mulas di Orosei e Leonardo Marceddu di Pozzomaggiore. Questo aspetto,
tanto discusso dagli storici, mette in rilievo la ampiezza del
problema perché vede un “movimento” organizzato di opposizione (non
soltanto popolare) allo Stato Sabaudo. Secondo il Costa il centro
operativa del “movimento” contro lo Stato era Nulvi (Logudoro) dove la famiglia
Delitala, avversa ai Savoia, aveva entusiasmato i villici tanto da creare un
piccolo esercito disposto a lottare. Rimane, quindi, aperto il problema se
quelli del monte Cuccaro appartenessero al banditismo o ad un “movimento
antipiemontese”.
- Nel 1749 il “pregone” del Viceré
VaIquarnera metteva al bando i capi nobili, invitando i sardi alla loro
cattura. L’attacco decisivo al Monte Cuccaro, sempre teatro della feroce rappresaglia,
fu infetto grazie alla strategia di due esponenti della borghesia sarda:
Gerolamo Dettori di Pattada e don Giovanni Valentino di Tempio, entrambi
funzionari di polizia fedeli ai Savoia.
- Furono impiegate truppe regolari con
l’appoggio di tre galeotte armate a guardia delle coste settentrionali, La
feroce repressione costò la vita ad oltre trecento ribelli, tra cui molte donne,
che furono impiccati lungo la strada che da Aggius conduce a Tempio.
- Ma il banditismo in Sardegna era fatto anche
di altri tristi episodi: frequenti le scorribande, dette “bardane”,
con decine e decine di briganti
armati di archibugio e a cavallo, che scendevano dai monti seminando il
terrore nei villaggi, con spari a salve, e poi assaltando le abitazioni di
personaggi facoltosi o ritenuti ricchi con lo scopo di sottrarre loro “s
‘ischisorgiu”, cioè il denaro in contanti custodito
frequentemente in piccoli forzieri o in astucci di latta murati nelle
pareti o sotto il pavimento. E per scoprire i nascondigli i banditi non
esitavano a torturare i malcapitati con tizzoni accesi o spiedi roventi.
Frequenti le incursioni alle canoniche perché spesso assicuravano un buon
bottino.
- Rubare in questo modo o in tanti altri era
ormai cosa frequente, quasi un passaggio obbligato, una abitudine per
“sopravvivere” ed il fenomeno scaturiva indubbiamente dallo stato di
abbandono e dimiseria. Purtroppo le “bardane” erano definite dal popolo anche imprese
coraggiose dette appunto “ominias”, cose da uomini, e divennero presto materiale
prezioso per i racconti dei nonni e dei padri nelle serate invernali, attorno al
focolare domestico, per tenere desta l’attenzione del solito ed immancabile
uditorio composto di fanciulli.
- Durante il regno di Vittorio Amedeo III
(1773-1796), vengono potenziate le riforme introdotte in Sardegna dal
Bogino, anche dopo il suo allontamento dalla carica di ministro. È un
periodo di regresso e di malcontento per l’isola anche per la carestia del
1780 che aveva visto la perdita dei raccolti e una immensa moria di bestiame.
Perla fame a Sassari vi fu un saccheggio ai magazzini frumentari e al Comune che
subito il governo represse violentemente. È di questo periodo la fondazione
delle colonie della Maddalena e di Gonnesa e l’istituzione dei Monti Nummari per
favorire il credito agricolo.
- Ma il regno di questo sovrano fu turbato
dagli eventi francesi della Rivoluzione che, dopo aver detronizzato Luigi XVI e
istituita la Repubblica, l’esercito aveva invaso il Piemonte.
- Le mire di conquista della Francia
rivoluzionaria colpirono conseguentemente anche la Sardegna.
- L’albero della libertà repubblicana
francese, piantato a Carloforte dopo lo sbarco nell’isola di S. Pietro
dell’8 gennaio del1793, ebbe una brevissima durata per il divampare di una
guerra che ebbe quasi un carattere religioso e che vide i paesi dell’isola,
soprattutto costieri, impegnati sotto l’incitamento del clero locale, con
iniziative organizzative ed anche strategiche, improvvisate ma
efficaci.
- Tale resistenza ai francesi, in contrasto con
le nuove idee europee, è da ricercarsi soprattutto nella paura della
penetrazione nell’isola delle idee illuministiche che tanto avevano
influito nella nuova coscienza delle masse desiderose di eguaglianza, fraternità
e libertà ed in questo frangente la voce carismatica dei vescovi di Cagliari e
di Alghero, appartenenti entrambi alla aristocrazia piemontese, ebbe notevole
rilevanza nell’incoraggiare i sardi alla “resistenza”.
- L’Episcopato ed il Clero non
elemosinarono offerte cospicue per contribuire alle spese militari; si
scomodarono persino i “santi patroni” chiamati a protezione delle azioni
belliche, non mancarono “simboli religiosi” e canti di “laudi sacre” ad
accompagnare le milizie e si videro persino parroci e monaci partecipare
direttamente ai combattimenti come semplici reclute o a posti di comando perché
acclamati dai soldati.
- Tutti aspetti significativi, questi, circa il
ruolo della Chiesa Sarda in quel clima culturale-politico che
“facilità ai Savoia di mantenere l’isola come riserva ben
controllata e isolata dal resto della cultura europea e dai suoi fermenti più
vivi che la Restaurazione aveva repressi ma non soffocati”.
- Cagliari subì a più riprese dei
bombardamenti navali, il 28gennaio del 1793 ed il 14 e 16febbraio, mentre a
Quartu S. Elena sbarcavano cinquemila repubblicani respinti duramente dai
miliziani. Vista la resistenza, la flotta francese riprendeva il largo
rinunciando all’impresa.
- Lo stesso Napoleone Bonaparte, allora
ancora capitano, dovette subire l’umiliazione della sconfitta
nell’isola della Maddalena gloriosamente difesa dagli abitanti guidati da
Domenico Millelire.
- L’eroismo dei sardi dimostrato contro
l’incursione francese non valse a far cambiare la politica piemontese in
Sardegna, e molte richieste degli Stamenti, compresa quella relativa
all’assegnazione degli impieghi ai cittadini sardi, nonché il rispetto degli
antichi privilegi e la convocazione periodica dei Parlamenti Sardi,
che mai fino allora erano stati riuniti, vennero clamorosamente e
arrogantemente respinte dal sovrano.
-
-
- I
moti angioiani
-
- Dopo le disperate richieste degli Stamenti
Sardi respinte dal Sovrano sabaudo, il malcontento doveva presto condurre il
‘popolo alla esasperazione tanto da giungere ad una rivolta generale.
- Cagliari insorse per prima, disarmò le truppe
e costrinse il viceré ed il suo seguito a lasciare precipitosamente la
capitale. A questo punto gli episodi si moltiplicarono in tutta l’isola.
Tra gli insorti si crearono purtroppo due schieramenti distinti con orientamenti
diversi: il Pitzolo, successivamente nominato con astuzia dal Sovrano
Intendente Generale, uomo capace e sostenuto dal popolo, intendeva
continuare il moto di rivolta in una “ferma ma ordinata
contestazione”.
- Giovanni Maria Angioy, nativo di Bono,
giudice della Reale Udienza, figura carismatica sostenuto dalla milizia
popolare, incoraggiava invece ad una azione oltranzista, Purtroppo il Pitzolo, diventato capo dei
conservatori dopo la
nomina a Intendente Generale, pagherà con la vita questo suo atteggiamento non
condiviso dal popolo.
- Gli eventi precipiteranno, perché ancora una
volta sorgeranno divergenze tra Capo disotto e Capo di sopra per quella antica e
cronica rivalità tra le due importanti città opposte.
- Sassari pretendeva l’indipendenza da
Cagliari perché il” Capo di sopra” si sentiva emarginato e quindi, in un momento
favorevole e di grande esaltazione, si proclamava indipendente con
proprio Parlamento, In questo frangente, il Viceré, che già si era
insediato a Cagliari, usa la strategia di “fomentare” una rivolta del Capo di
sopra contro i feudatari sassaresi. L’insurrezione attecchisce e Sassari viene
presto occupata dalle bande antifeudali nel dicembre del 1795.
- Il problema, diventato ora assai più grave,
spaventa il governo che invia a Sassari Giovanni Maria Angioy come Alter Nos,
cioè con pieni poteri, come rappresentante dell’ordine legalmente
costituito.
- Ma la sensibilità dell’Angioy ai problemi
della Sardegna lo porterà presto a schierarsi con i rivoltosi del Capo di
sopra intenzionati a liberarsi finalmente dei feudatari che affliggevano i
paesi con impossibili “balzelli”.
- Da quel momento la rivolta
antipiemontese che aveva interessato tutta l’isola, diventerà antifeudale
e la forte personalità dell’Angioy infiammerà i sardi che
costituiranno in breve tempo un vero esercito di cavalieri armati e decisi
ad occupare Cagliari.
- Questa rivolta generale era stata
preceduta nel tempo da numerosi episodi di sporadiche rivolte popolari
contro gli abusi continui dei feudatari a cui non mancava il grano e
speculavano, arricchendosi alle spalle di famiglie ridotte alla fame dalle
conseguenze della carestia. E queste rivolte avevano mteressato molti
paesi: dalla Marmilla al Logudoro, dall’Anglona al Campidano, con i centri di
Baressa, Ittiri, Thiesi, Sennori, Osilo, Ploaghe, Donigala, Nulvi Sedini,
ecc.
- Forte dell’adesione popolare, l’esercito
dell’Angioy si ingrossa di bande di rivoluzionari e percorre la Sardegna
infiammando i sardi come ai tempi dei giudici arborensi e
dell’Alagon.
- Ma per una mala sorte questo esercito
composto non di fanatici, ma di autentici sardi decisi a sradicare il
malcostume, le ruberìe e l’arroganza, sarà irreparabilmente sconfitto
proprio ad Oristano. Le forze Piemontesi passeranno senza indugiare alla
spietata rappresaglia, braccando i rivoluzionari e spingendosi fin
sotto al paese di Bono, roccaforte rivoluzionaria del Goceano, che
dovrà subìre un pesante cannoneggiamento ed il saccheggio. L’Angioy
riparerà in Francia ove morirà esule a Parigi il 17giugno del 1797. Dopo la
morte di Vittorio Amedeo III (1796), sale al trono Carlo Emanuele IV, uomo
fragile, più dedito alle pratiche religiose che alla politica. Sotto il suo
regno Torino fu occupata dai francesi che concedevano al sovrano di
trasferirsi in Sardegna. Ma l’isola non lo attira e nomina il fratello
Carlo Felice Viceré di Sardegna abdicando dopo appena due anni, nel 1798,
lasciando il trono al fratello secondogenito Vittorio Emanuele I (1802-1821) che
prenderà dimora a Cagliari vivendo nella Corte di Castello dal 1806 al
1814, fino alla caduta di Napoleone. Per i Savoia scacciati dal Piemonte fu un
momento assai difficile e preoccupante e, per i sardi, di vero squallore. In
questa fase la Sardegna dovrà subire un blocco navale operato dagli inglesi con
gravi conseguenze nel commercio. Durante una epidemia di vaiolo, muore a
Cagliari il principino sabaudo Carlo Emanuele di soli 3 anni che verrà sepolto
nel Duomo. Poi morirà il duca di Monferrato Maurizio Giuseppe di 37 anni che
verrò tumulato nel Duomo di
Alghero. Poi toccherà al conte di Moriana principe Benedetto Placido
sepolto nel Duomo di Sassari, e infine a Giuseppina Maria Luigia, regina di
Francia, deceduta a Londra e sepolta a Cagliari. Il suo monumento funebre nella
cripta del Duomo è opera di un artista discepolo del Canova.
- E di questo periodo (1802-1821) la tassa
dello “spillatico” in
base allo spazio abitativo a disposizione imposta ai sardi. Nella misurazione i
gendarmi o i funzionari preposti includevano anche gli angusti
“sottani” delle povere case. Lo spazio veniva misurato con una pertica graduata
da cui il detto arguto cagliaritano: “sa pettia misura fammi”.
Il “balzello” escogitato, suggerito
alla regina reggente Maria Teresa l’austriaca, moglie del sovrano Vittorio
Emanuele I, che assicurava alla stessa un appannaggio per la vita di corte e per
l’avvenire, era opera del Sisternes, un prelato senza scrupoli che aspirava con
l’appoggio della sovrana alla nomina di vescovo.
- Questa sovrana non era bene accetta dal
popolo per il suo carattere di superbia e di disprezzo verso tutti i sardi.
Odiava a tal punto Napoleone che lo fece raffigurare sul fondo del suo
“pitale” d’oro. Racconta il
Manca che Maria Teresa: “malgrado il pitale d’oro era sempre a secco
di contanti”. Figurarsi se non accolse con entusiasmo l’idea dello spillatico,
incurante delle condizioni del
popolo.
- Era l’anno 1812, paurosamente ricordato come
“s ‘annu dosci” per la
grave carestia che aveva colpito la Sardegna. Mancava la farina di grano, ed il
pane, specie in Ogliastra, veniva impastato mischiando alla farina della
finissima argilla. Questo ripiego rimase poi come usanza, tanto che in Ogliastra
lo si usa ancora oggi per la preparazione di un dolce squisito che non tutte le
donne sanno confezionare.
- Dopo l’abdicazione di Vittorio Emanuele I
(1821) sale al trono Carlo Felice (1821-1831), già Viceré di Sardegna in due
distinti periodi 1799-1806; 1815-1816.
- Come Viceré eseguì le seguenti opere:
realizzazione di una amministrazione più funzionale, restaurazione
dell’ordine pubblico; incremento delle colture; promozione degli
studi; fondazione nella capitale di una società agraria di economia; creazione
del Museo archeologico; fondazione, a spese del viceré, del Collegio “Carlo
Felice” per l’avvio agli studi dei giovani poveri e
meritevoli, Durante questo suo
mandato, si era circondato di sardi come consiglieri e per meglio
conoscere le realtà dell’isola.
- Come sovrano pose mano a molte riforme che
segnarono momenti di vero risveglio in Sardegna: ampia attuazione dell’Editto
delle Chiudende, opera del predecessore Vittorio Emanuele I e mai
attuato, che mirava a diffondere l’agricoltura mediante l’introduzione
della piena proprietà privata con la libera recinzione di fondi demaniali.
Purtroppo questo editto generò gravi disordini soprattutto in Barbagia e
nel Goceano per gli abusi dei grossi proprietari che penalizzavano i
poveri pastori costretti a vagare in cerca di pascoli. Istituì in tutti i comuni
le scuole primarie. Favori il sorgere di fabbriche di manufatti; diede mano alla
politica stradale con i lavori dell’arteria principale CagliariPortotorres
che divenne poi la “Carlo Felice”. Pubblicò il codice unico
“Leggi civ. e crim. del Re Carlo Felice per il Regno di
Sardegna”, raccogliendo in
esso tutta la legislazione civile e penale sarda escludendo tantissimi istituti
medievali. Negli anni della vicereggenza aveva toccato dal vivo i problemi veri
dell’isola e da sovrano era riuscito in parte a risolverli. Per questo Carlo
Felice fu amato dal popolo e Cagliari gli dedicò il suo monumento.
- L’età di Carlo Alberto (1831-1848) fu ugualmente
proficua anche perla presenza di una classe dirigente sarda che si era
formata. Dei 24 deputati eletti dalla Sardegna alla prima Camera Subalpina,
quasi tutti appartenevano alla nuova classe che andava prendendo coscienza.
Erano questi, uomini come il Manno, il Martini, l’Angius, l’Asproni, il
Siotto Pintor, il De Castro, il Tola.
- Carlo Alberto favorì l’agricoltura,
l’industria, il commercio, la sanità; riordinò il sistema giudiziario;
realizzò la riforma dei Comuni, il sistema monetario e quello dei pesi e misure.
Riconobbe la proprietà privata ed incoraggiò iniziative atte a
svegliare l’economia. Scompare così la proprietà collettiva che tanto
aveva caratterizzato la società sarda. Purtroppo durante il regno di questo
sovrano, nel 1847, un avvenimento imprevisto toglierà ai sardi ogni
possibilità di autonomia: un plebiscito popolare di spontanea rinuncia
all’autonomia, e i sardi ci rinunciano non tanto per le manifestazioni
studentesche delle città inneggianti all’unione col Piemonte e che esaltavano
gli ideali di unità nazionale, quanto per la paura di rimanere soli come
regno autonomo e senza alcuna possibilità di riforme.
- La deputazione sarda pressata anche e
soprattutto dai problemi dell’isola stremata dai cattivi raccolti, chiedeva
al sovrano “perfetta eguaglianza e fusione della Sardegna con gli
stati sabaudi”. Così il 1 ottobre
del 1848, finiva di esistere il Regno di Sardegna e la figura costituzionale del
viceré interrompeva per sempre il suo mandato autonomo. All’esempio di
fratellanza dei sardi il ministro Cesare Balbo aveva esclamato:
- “Tra i meravigliosi fatti del Risorgimento
italiano, questo è uno dei più belli”.
- Ma questa fusione al Regno Sabaudo,
lasciava la Sardegna ancor più lontana, in balia di se stessa, con
l’aggiunta di tasse sempre gravose: basti pensare che nel 1860 l’isola era
debitrice verso lo Stato, per imposte non versate, della impressionante cifra di
quattromilioni e mezzo di lire, L’iniziativa privata senza l’intervento
dello Stato non poteva essere sufficiente a superare la crisi del
“trapasso” ad una
realtà diversa.
- Soltanto nel 1857, Cagliari salutava il
sorgere della prima filiale della Banca Nazionale con immediato
successo nel settore commerciale. Ma il problema fondiario rimaneva ancora
un grosso problema. Torme di forestieri prendevano in mano le risorse dell’isola
intascando i profitti senza nulla lasciare alla Sardegna.
- L’isola rimaneva ancora con le sue inutili
ricchezze e priva di capitali.
- Per meglio inquadrare i “momenti” che
animarono la vita dei parlamentari sardi tesi tutti a difendere la Sardegna,
sono sufficienti due soli nomi presi tra i tanti del panorama politico
dell’ottocento: il primo è quello di Giorgio Asproni, l’ex canonico di Bitti e
poi deputato della sinistra, sostenitore accanito della democrazia
repubblicana del Risorgimento. Nel suo Diario Politico si staglia una Sardegna
ancora mortificata da uno stato sordo alle suppliche e lontano e distratto
per i suoi grossi problemi interni da risolvere: la crisi dello stato, le
ruberie dei ministrt l’arroganza di chi detiene il potere e le
ingerenze sottili e minacciose delle forze economiche.
- La seconda figura di parlamentare che merita
essère ricordata, anche per il contributo offerto alla nostra città, è
quella dell’oristanese Salvator Angelo De Castro, eletto deputato.
- Sono gli anni dell’esplodere in Sardegna
delle ribellioni contro lo Stato (1847-1848), con più focolai di rivolta
che vedevano coinvolte svariate classi sociali, dai pastori ai contadini,
dai piccapedres agli artigiani, ecc.
- Oristano stessa, esasperata dalla fame,
insorge contro il Reggente per chiedere la distribuzione del grano
ammassato nel Monte Granatico.
- Il De Castro durante questi frangenti è eletto
deputato, e in Parlamento, dal suo scanno di Centro Sinistra, leverà
frequentemente la voce a favore dell’isola sempre più afflitta da immensi
problemi e carestie.
- Era uomo instancabile, zelante religioso,
pensatore, pubblicista, difensore del patrimonio storico e culturale della
sua isola.
- Racconta Giuseppe Murtas che il De
Castro faceva parte della schiera dei “preti rivoluzionari”, come venivano spesso
chiamati i preti liberali
e quanti erano solidali con i vari movimenti indipendentisti. Essi tentavano una
distinzione tra Stato Pontificio e Chiesa di Cristo, rischiando la scomunica cui
era condannato chi avversava il potere temporale del Papato. Il De Castro,
come altri religiosi, si limitavano, per esprimere le loro idee liberali, ad
abbracciare il programma politico-democratico del Gioberti che includeva
una rivalutazione del ruolo del Papato come segno di unità”.
- E ancora il Murtasa sottolineare il faticoso
cammino politico dell’AsproniI la cui azione è insidiata ingenerosamente dallo
stesso Clero sardo, e, soprattutto, da “una fazione di canonici
nuoresi, come il Ghisu, che avevano iniziato a perseguitarlo già dal 1847, e poi
continuarono a combatterlo ed a proclamarIo “a postata” per le sue idee, ma
soprattutto per la sua parola severa di censore del Parlamento subalpino
italiano”.
- “In molte lotte parlamentari il De Castro è
al fianco di A/proni che sentiva vicino e sempre amico malgrado la sua
collocazione di estrema sinistra”. E tale amicizia si mantenne integra
anche dopo il mandato parlamentare del De Castro.
- Insomma, il De Castro si fece sostenitore
delle tensioni democratiche del suo tempo, contribuendo all’Unità d’Italia
con i suoi tempestivi ed intuitivi interventi scritti, aprendo la strada, nel
contempo, alla valorizzazione della cultura e della storia della Sardegna.
- Difensore strenuo della democrazia, si
faceva forte come deputato del programma del Gioberti e
in più “aggiungeva di suo
una viva partecipazione ai drammi della propria gente, alla quale voleva
sentirsi legato, e solo di essa si considerava rappresentante”. (Cfr. G.
Murtas, op. cit.).
- Alcune frasi di un discorso del De Castro
agli elettori di Oristano, evidenziano questa sua fede nella
“democrazia” e
l’attaccamento alla sua gente: “io sono l’ultimo dei vostri
deputati, né do torto a quelli che mi tacciano per questo verso, o a quegli
altri che mi dicono uomo di poca esperienza, se per questa intendono
l’esperienza del malfare. Ho però un cuore che sente profondamente le miserie
del popolo, schiavo una volta, poi servo molti anni, ma sempre oppresso, ma
sempre taglieggiato, ma sempre munto;e quando si tratta di proteggere la
sua causa, il sentimento supplisce all’ingegno, mi addoppia il coraggio, e mi è
di lieve momento qualunque sacrificio. Ho un cuore sinceramente democratico, se
per democrazia si intende un governo indirizzato con sicure e stabili
istituzioni al maggior bene del maggior numero dei cittadini..”.
- Coerente nella linea politica scelta, e forte
dell’amicizia con Gioberti, Lineo e Rattazzi, ha più occasioni in Parlamento di
parlare di giustizia e di libertà.
- E molteplici sono i suoi interventi sulle leggi
in discussione: da quella dell’insegnamento universitario in Sardegna alla
legge per l’abolizione delle decime al clero sardo, a quelle del lavoro, a
quelle dell’isolamento, a quella della disastrosa situazione economica
della Sardegna con le intollerabili imposizioni fiscali che avevano fatto
esplodere nel 1849-50 la rivolta di Sedilo e poi quella del nuorese e del sassarese.
- Come tuffi i parlamentari sardi, il De
Castro viveva in Sardegna e si muoveva in un ambiente seminato di
spie regie. Ma la sua vocazione
alla libertà e alla
verità lo portava ad
essere sempre più in “prima linea”, collaborando con la stampa locale e
nazionale.
- Ecco sulla “Meteora” apparire i suoi saggi
sui problemi della scuola sulla diffusione della cultura, sul lavoro, che lo
trova sempre intuitivamente pronto e impegnato. Poi l’enorme dispiacere per la
sospensione del visto di stampa della “Meteora”, per la sua “ode” a Eleonora
d’Arborea, considerata dallo Stato “poesia estremamente
pericolosa per lo spirito politico dominante in essa” che poteva favorire la diffusione di idee
miranti al “sovvertimento dell’ordine sociale”.
- Perseguitato dalle censure regie del potere
sabaudo, continua indifferente la sua strada e fonda nel 1857 “La Gazzetta
di Oristano” ottenendo la solidarietà di uomini insigni della cultura.
- La sua attività di pubblicista non lo distrae
dai suoi impegni di Cattedra dove, presso l’Università di Cagliari, tiene
lezioni di Diritto Canonico.
- Purtroppo, negli ultimi anni della sua vita
si troverà coinvolto nella vicenda oscura delle “Carte false d’Arborea). E la
sua proverbiale buona fede lo porterà fino alla morte a difendere questi “Nuovi
codici d’Arborea” da lui considerati la più grande scoperta
storico-letteraria che molto poteva far sperare alla Sardegna.
-
-
- Il
Regno d’Italia
-
-
- Solo nel 1862 si ebbe la legge per il completamento
della rete stradale cui seguì nel 1863 quella per la costruzione della
linea ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci, ma furono le uniche cose poco
appaganti:
- i problemi di fondo rimanevano insoluti. La
“questione sarda” premeva con urgenza: il frazionamento della terra creava
dispendio di forze e di moneta ma non produceva un bene sostanziale.
Miseria, quindi, e malcontenti, con tante commissioni di inchiesta e
problemi insoluti e sempre più gravi. La proclamazione del Regno d’Italia, con
tante regioni annesse, aveva tanto preoccupato il re Vittorio Emanuele II per
il pericolo di nostalgie e conseguenti focolai di rivolta, per cui la
Sardegna così lontana doveva essere la prima a pagarne le conseguenze, in uno
Stato più attento invece alle altre regioni più vicine, Da questa incredibile
situazione scaturiva la violenta reazione dei parlamentari sardi: nel
1867 Giovanni Battista Tuveri lanciava una violenta accusa allo Stato, ponendo,
con la sua nota e nobile oratoria, la mano sulla piaga dell’isola,
sostenendo: “un ‘isola qualunque non può prosperare ove non si
governi da sé e non abbia tutta l’indipendenza che può conciliarsi con le
prerogative del potere centrale” il più limitato”.
- E ancora: “Però la Sardegna non è
allo stato in cui si trova solo perché dipende da un governo che né è, né
vuole essere col popolo, ma perché questo governo ne dista le centinaia di
miglia, e non conoscendoci e disdegnando conoscerci, vuole imporsi su tutto
e su tutti, parte per gelosia di potere, parte per avidità di
pecunia”.
- Già dal 1856 Garibaldi è a Caprera dove
stabilisce la sua dimora. Eletto deputato nel Collegio di Ozieri, aveva
ripetutamente in Parlamento levato la sua voce a difesa della Sardegna
mettendone in risalto l’indigenza, le doti di ospitalità, di
intelligenza, di fedeltà, di laboriosità e di coraggio dei sardi.
- La stampa sarda andava mostrando la sua
ostilità a Cavour colpevole di aver fatto poco o nulla per la Sardegna, anzi lo
additava come responsabile di aver peggiorato la precaria situazione
esistente con quella imposta fondiaria che colpiva la proprietà di fondi
improduttivi e di nessun valore.
- In queste misere condizioni la Sardegna
veniva colta allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. E dopo la vittoria, che
tanto aveva pesato nell’isola per il sacrificio di tante forze giovani,
doveva ancora gravare l’amara delusione dell’indifferenza dello Stato: la
miseria dilagante, la fame, lo spopolamento, la solitudine.
- Tutti elementi non marginali, ma che
fecero nascere e maturare gli ideali di aspirazione autonomistica,
quegli ideali di sempre rimasti sopiti, dove ora il Bellieni, Lussu e tanti
altri andavano conducendo una battaglia democratica per il giusto riscatto
dell’isola.
-
-
- I momenti della creatività artistica
-
- Durante il settecento e l’ottocento, sotto il
governo piemontese, Oristano, nonostante i problemi che l’affliggono, è
come percorsa da un desiderio di rinnovamento edilizio che ha interessato
non esclusivamente l’edilizia religiosa.
- Nel 1729 si dà mano alla demolizione
della basilica romanico-gotica di Santa Maria le cui condizioni strutturali
ormai fatiscenti avevano allarmato l’arcivescovo Antonio Nin e tutto il Capitolo
arborense, trovando la piena disponibilità e la prontezza delle autorità
regie per la costruzione di una nuova e imponente cattedrale. Il regio
architetto Antonio De Vincenti non solo approvò il progetto, ma suggerì la
soluzione a unica navata che trovò il consenso di altri operatori, in parte
architetti militari che avevano il controllo del settore cui fanno spicco
per il loro molo nella fabbrica i nomi del generale Castellalfiere, del conte
Moretta, del Garrucciu e dell’Arieti.
- Dell’antica basilica furono risparmiati la
Cappella del Rimedio, il Battistero e il Coro che divenne più tardi archivio del
capitolo. Lo schema planimetrico a pianta latina con transetto, tiburio e
sovrastante cupola trova lo spunto dai canoni barocchi del Vignola ormai
diffusi e frequenti in tutta Italia.
- Il campanile ottagono è l’altro elemento
superstite, anche se poi coronato da una cupola, rivelando nelle sue linee
essenziali il momento felice dell’architettura del XIV secolo in Sardegna. Molte
altre opere, come le cappelle delle testate del transetto, furono eseguite molto
più tardi ad opera del Cominotti. Per le dettagliate notizie e i raffronti si
rimanda all’interessante testo di Maria Manconi “La Chiesa di S. Maria
Cattedrale di Oristano”.
-
- La Chiesa di
S. Maria Cattedrale di Oristano.
-
 Non desidero entrare nel merito di questa
grave decisione dell’Arcivescovo Nin nel 1729 di demolire totalmente l’antica
basilica, ma il desiderio del nuovo a tutti i costi cancellando totalmente
il passato, è un aspetto che ha fatto perdere la testa più volte, nella storia
di tutti i tempi, a coloro che in determinati momenti erano chiamati a
decisioni immediate di scelta.
Non desidero entrare nel merito di questa
grave decisione dell’Arcivescovo Nin nel 1729 di demolire totalmente l’antica
basilica, ma il desiderio del nuovo a tutti i costi cancellando totalmente
il passato, è un aspetto che ha fatto perdere la testa più volte, nella storia
di tutti i tempi, a coloro che in determinati momenti erano chiamati a
decisioni immediate di scelta. - La Basilica di S. Maria,
comunque, nel suo scrigno di innesti felici ed armoniosi, custodisce
preziosi cimeli artistici che rimarcano gli incontri culturali dell’Arborea
avvenuti nei secoli con la Toscana e la Spagna. E sono opere varie: dalle
statue litiche policrome a quelle lignee, dai peducci pensili alle edicolette,
ai plutei marmorei; dalle tavole pittoriche agli arredi in argento; dai
preziosi antifonari miniati agli arazzi, alle pergamene, ai leggii
intarsiati. Tutte opere ancora integre, protette gelosamente nei secoli dalla
furia degli eventi bellici e dai saccheggi, sotto la custodia di quel “Capitolo
Arborense” consapevole della sua funzione di istituto depositano.
- Il fervore edilizio in Oristano continuerà
poi grazie alla munificenza di don Damiano Nurra Conca, un facoltoso signorotto
scaltro e capace nella amministrazione feudale sia nel Mandrolisai che nel
Campidano, tanto da ottenere nell’ 762 il titolo di marchese della peschiera
d’Arcais, da cui il titolo gentilizio, dietro il pagamento annuo allo stato di
54 mila scudi sardi e in più uno sborso di 176 mila lire all’atto
dell’approvazione della “patente”, più 40 mila dopo due anni di attività
amministrativa.
- Ma il marchese già dal 1748 era uomo di
spicco nei campidani con tanto di contratto di acquisto e diploma regio per
l’esercizio di curadore dell’alto ufficio della
“insinuazione” che
assolveva giuridicamente ai problemi relativi ai passivi fallimentari
e alla autenticità e validità dei
“trapassi immobiliari”. E ad Oristano il marchese apparirà come
“mecenate” quando nel 1776 darà il mandato all’architetto Giuseppe Viana di
costruire, accanto ad un suo preesistente palazzo di cui ancora si conserva
lo stemma gentilizio nel vicolo Arcais, il monastero che darà ai carmelitani.
Prosegue quindi alla edificazione del bel palazzo residenziale del marchese
(oggi della Provincia), con l’aereo lucernario a cupola.
- E lo stesso modellato a “calice
moresco” lo ritroviamo nelle due
cupole della Chiesa del Carmine innalzata dallo stesso Viana negli anni
1783-85.
- È un’opera felice, questa del Carmelo, di
grande respiro, che mette in rilievo la sensibilità dell’architetto
piemontese.
- Qui l’arte Rococò raggiunge la sua
delicatezza aristocratica nei dosati e pacati toni del colore a
tempera e nel modellato delle partiture che ricamano gli spazi dando sfogo alla
luce che precipita (G. Farris, op. cit.), mentre “caratteri di capriccio
hanno le quattro tribunette che alte si affacciano sul presbiterio e le due che
compaiono in ciascuna cappella”.
- La Chiesa del Carmine è quindi opera rococò
straordinaria e, dice il Pau: “... oggi con tanta indifferenza verso i
monumenti architettonici e con tanti pervertimenti nella percezione dell’arte,
si passa spesso frettolosi e indifferenti di fronte a edifici che da soli
costituirebbero il vanto di una città”.
- Riferendosi alla personalità e alle
esperienze del Viana come architetto, Mario Loi nelle sue interessanti
“Note” sul “Complesso del Carmine, riferisce: “la sua attività
professionale denota una matrice juvarriana (partecipò ai lavori di
completamento della palazzina di caccia di Stupinigi) cui sovente si aggiungono
apporti e richiama neopalladiani e classicisti”.
- E su quanto scritto dal Loi, io
aggiungo senza alcun timore: nella fabbrica del Carmine, in quel già ridotto
spazio a disposizione, l’architetto doveva pur dosare rapporti ed
equilibri, e nella riuscita soluzione compositiva dove tutti gli elementi
si dipartono in una fuga lirica verso l’alto, intessendo una trama di delicati
raccordi, il Viana compie qui il suo capolavoro e si rivela maestro del
“rococò”.
-
Portale di
Vitu Sotto
-
 Questo filone culturale del “rococò” in
Oristano, trova ancora la sua alta espressione nel bellissimo portale che
porta il nome del suo signore, il marchese Vitu Sotto, contemporaneo dell’Arcais
e deceduto nel 1783.
Questo filone culturale del “rococò” in
Oristano, trova ancora la sua alta espressione nel bellissimo portale che
porta il nome del suo signore, il marchese Vitu Sotto, contemporaneo dell’Arcais
e deceduto nel 1783. - Non si hanno notizie certe di questo
signore, ma il portale principesco che segnala l’ingresso ad una
grossa proprietà certamente dotata di “foresterìa”, in territorio di Donigala, indica la
potenza del principe e la sensibilità all’arte. Il portale, costruito
in arenaria, è a forte strombatura con cancellate ben ricamate, appare
imponente nella sua mole ben modellata. Il frontone curvilineo terminante a
spirale offre lo spazio allo stemma araldico intervallato da una croce a
raggera apicale. Ai lati due strette paraste, una a bugnato e la seconda scanalata,
decorate entrambi da rosette intervallate. Due graziose volute laterali ne
racchiudono il prospetto che appare coronato da quattro elementi cuspidati con
cariatidi. Tutti gli
elementi decorativi sono modellati in trachite rossa mentre il resto della
struttura è in bionda arenaria.
- Questo bel portale, che non trova
riscontri, meriterebbe di essere inserito nei testi di storia dell’arte,
perché nel suo insieme rappresenta l’esempio più classico del gusto
“rococò” rivolto alla
architettura rurale. E nella sua oasi di verde costituisce una immagine di rara
bellezza stilistica.
- Vertilicalismo e virtuosismo si fondono e si
armonizzano nel morbido plasticismo che modella i passaggi dei molteplici
contenuti decorativi, e la luce si infrange pacata e soffusa insieme,
nelle stemperate apparecchiature dal coloro nostrano. Non sembra proprio un
portale di un semplice fondo rustico, ma l’emblema di una dimora
principesca, l’ingresso di un parco aristocratico, raffinato, adatto ad un
costume di vita mondana e lontano nel tempo che prende l’avvio da
Versailles, poi percorre Stupinigi e quindi l’eco giunge qui ad Oristano
dove evidentemente l’alta nobiltà piemontese aveva trovato tra le
lagune ed il verde dei prati il suo mondo ideale legato indubbiamente, il
tutto, a grandi interessi commerciali i cui momenti aurei sono così
sporadicamente espressi in questi esempi di architettura
“rococò”. Dopo il “rococò” la
cui presenza è modellata negli angusti spazi di quel centro storico
prescelto e nulla stravolge, ma si adatta nella sua pacata grafia
architettonica al colore locale, ecco più tardi apparire nel 1847 in Oristano la
corrente neoclassica guidata da Gaetano Cima che trasformerà totalmente la
preesistente basilica gotica di S. Francesco, avviando nel contempo la
topografia urbana a soluzioni più spaziose e scenografiche che, con
l’armonia della “rotonda” neoclassica della Casa Corrias ed il rifacimento della
Chiesa di S. Vincenzo caratterizzata dalla sua “meridiana”, aprono la
piazza verso due direttrici che hanno come fondali il S. Francesco ed il Duomo
ed armonizzano insieme l’ambiente così raccolto e salottiero. Non entriamo
anche qui nelle complesse vicende che hanno indotto nel 1835 alla demolizione
della cadente basilica gotica di S. Francesco, come non vogliamo soffermarci
troppo sulle tormentate fasi della nuova fabbrica funestata dal crollo della
cupola per imprecisi o affrettati calcoli delle “spinte” ad opera del Cano,
episodio presto dimenticato per il successivo e felice intervento del Cima
che portò a termine l’opera neoclassica.
- Quel frangente rese ancor più povero quel
glorioso Cenobio per le ingenti spese, tanto da indurlo a svendere e
privarsi di pregevoli opere d’arte come la bellissima tavola della
“deposizione della croce” di Pietro Cavaro oggi nella pinacoteca
cagliaritana.
- In quest’ultimi secoli, Oristano è immersa in
grossi problemi anche di sopravvivenza per l’abbandono del territorio e la
insalubrità del luogo che portarono anche come conseguenza, alla
soppressione nel 1807 della Prefettura trasferendola per oltre vent’anni a
Busachi.
- Pur afflitta da tante difficoltà, la città
ebbe la forza di reagire avviandosi verso il progresso. Soltanto alla fine
del secolo verranno portati avanti i lavori di bonifica delle paludi.
- Dal Cinquecento all’Ottocento sorgono nuovi palazzi
dall’impronta signorile e si moltiplicano le chiese anche fuori le mura. Così la
bionda arenaria della seicentesca chiesa di S. Efisio darà tono alla piccola
piazza e al borgo che si dilata fuori le mura. E la città, pur rispettando in
parte l’assetto urbano giudicale, assume via via una nuova fisionomia che
nell’Ottocento la ve de più dinamica e funzionale. Sorge il Seminario
Tridentino, sobrio nelle sue linee e caldo nel colore dei suoi paramenti
invecchiati.
- La città sarà caratterizzata e servita in
questo ultimo secolo da tante caratteristiche fontanelle pubbliche e non
mancano nei dintorni gli abbeveratoi, ma la gente continuerà a servirsi
dell’acqua contenuta nelle ampie cisterne perla grande comodità che esse
rappresentavano. Ecco il pubblico lavatoio, ecco i selciati delle strade e
dei vicoli interni della città.
- E l’impronta del Cima aggiungerà ancora una
nota signorile in tutto il contado della città, con gli eleganti portali
neoclassici a timpano, completi di garitte interne incorporate e
sopraelevate, che aprivano i viali alberati dei fondi rustici e si
aggiungevano così ai già preesistenti portali barocchi, eleganti anch’essi
nelle armoniose volute, costituendo insieme un ricco patrimonio di architettura
rurale che evidenziava non; unicamente l’antica vocazione all’agricoltura,
ma soprattutto il prestigio economico della Città.
- Una pennellata di civetteria mondana e
culturale sarà offerta dal Teatro San Martino, un piccolo scrigno neoclassico,
col suo timpano, l’interno ovattato con i minuscoli e armoniosi palchetti
decorati:
- esempio, questo, significativo ed
eloquente del nuovo fervore di vita.
- A caratterizzare ancora la città saranno i
cortili e i giardini sopraelevati ravvivati dalle chiome dei mandarini sporgenti
dai recinti murari, lungo i labirinti tortuosi della topografia urbana, e ancora
i balconcini arabescati in ferro battuto, testimoni di un’arte ormai
scomparsa.
- Oristano era questa, non una grande città, ma
piccola, ancora giudicale nel suo perimetro irregolare, signorile e
civettuola, aperta agli influssi culturali, animata da una profonda anima
contadina orgogliosamente ostentata nelle sagre, nella sua Sartiglia, nel
fervore dei suoi sobborghi, nelle sue ampie case di fango o di pietra dagli ampi
cortili che ricordavano il “patio” spagnolo, dove i cavalli riposavano e
trovavano ristoro all’ombra delle arcate e dei pergolati.
- Una città un tempo capitale di un regno,
lacerata dalla stremante lotta contro le grandi potenze medievali per i più alti
ideali di libertà.
- Una città che ha tanto sofferto, scampata all’egoismo e
poi alla incuria, e del lento suo morire mostra ancora le ferite che
parlano di una straordinaria storia che ha ora il sapore tutto di una
leggenda.
 La rivendicazione di Leonardo Alagon fu
ben presto osteggiata dal Viceré Nicola Carroz, discendente di Ugone II
d’Arborea per parte di madre, ma Leonardo si impose con la forza delle armi
nella battaglia di Uras. L’entusiasmo in favore di Leonardo fu tale da dare lo
spunto ad una rivolta nazionale che si estese dalla Barbagia al Goceano, dal
Marghine al Campidano al grido di “Arborea vaia suso Aragona vaia
juso”. La stessa capitale,
Cagliari, sede del Viceré Carroz fu minacciata dalle truppe di Leonardo. Ma la
Spagna, temendo un ritorno del nazionalismo giudicale cercò di arginare la
riscossa con forti contingenti. La battaglia di Macomer del 19 maggio 1478,
doveva purtroppo segnare disastrosamente la fine e a nulla valsero
l’entusiasmo e i tentativi di rivolta nazionale. Le soverchianti forze
aragonesi con contingenti di “spingarderos” e altre potenti armi di artiglieria giunte
dalla Sicilia, lasciarono sul campo di Macomer, dopo una dura battaglia,
una scena agghiacciante e desolante con settemila o diecimila morti
secondo le diverse fonti.
La rivendicazione di Leonardo Alagon fu
ben presto osteggiata dal Viceré Nicola Carroz, discendente di Ugone II
d’Arborea per parte di madre, ma Leonardo si impose con la forza delle armi
nella battaglia di Uras. L’entusiasmo in favore di Leonardo fu tale da dare lo
spunto ad una rivolta nazionale che si estese dalla Barbagia al Goceano, dal
Marghine al Campidano al grido di “Arborea vaia suso Aragona vaia
juso”. La stessa capitale,
Cagliari, sede del Viceré Carroz fu minacciata dalle truppe di Leonardo. Ma la
Spagna, temendo un ritorno del nazionalismo giudicale cercò di arginare la
riscossa con forti contingenti. La battaglia di Macomer del 19 maggio 1478,
doveva purtroppo segnare disastrosamente la fine e a nulla valsero
l’entusiasmo e i tentativi di rivolta nazionale. Le soverchianti forze
aragonesi con contingenti di “spingarderos” e altre potenti armi di artiglieria giunte
dalla Sicilia, lasciarono sul campo di Macomer, dopo una dura battaglia,
una scena agghiacciante e desolante con settemila o diecimila morti
secondo le diverse fonti. Difficile oggi giustificare quel documento di
demolizione redatto in data 27 settembre 1906 che inchioda molti illustri
nomi del tempo sulla responsabilità dell’abbattimento affrettato per dar
luogo ad una piazza e lo sbocco diretto alla via per Cagliari, già del
resto allora esistente attraverso l’ampia porta giudicale.
Difficile oggi giustificare quel documento di
demolizione redatto in data 27 settembre 1906 che inchioda molti illustri
nomi del tempo sulla responsabilità dell’abbattimento affrettato per dar
luogo ad una piazza e lo sbocco diretto alla via per Cagliari, già del
resto allora esistente attraverso l’ampia porta giudicale.
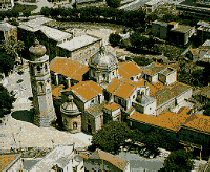
 (1336)/S. CHIARA (1343).
(1336)/S. CHIARA (1343). Il discorso
vale anche per i manoscritti appartenenti alla Basilcia di Santa Maria. Grande
attenzione merita il Crocifisso ligneo detto di Nicodemo della stessa
basilica di S. Francesco. E l’opera scultorea sacra più impressionante
dell’arte italiana medievale, per il suo profondo realismo che prelude già al
Rinascimento: il “pathos” dell’atroce agonia è espresso qui con rigore
e l’ignoto artista crea la più rara immagine plastica del “trapasso”: la cassa
toracica del Cristo si dilata, gli arti si con-traggono in un ultimo sforzo; gli
occhi si velano, la bocca si dischiude per esalare l’ultimo respiro. Una
immagine commovente, di straordinario valore artistico. E attribuita alla
scuola spagnola, ma secondo Remo Branca rivela riscontri renani (Farris,
op. cit.).
Il discorso
vale anche per i manoscritti appartenenti alla Basilcia di Santa Maria. Grande
attenzione merita il Crocifisso ligneo detto di Nicodemo della stessa
basilica di S. Francesco. E l’opera scultorea sacra più impressionante
dell’arte italiana medievale, per il suo profondo realismo che prelude già al
Rinascimento: il “pathos” dell’atroce agonia è espresso qui con rigore
e l’ignoto artista crea la più rara immagine plastica del “trapasso”: la cassa
toracica del Cristo si dilata, gli arti si con-traggono in un ultimo sforzo; gli
occhi si velano, la bocca si dischiude per esalare l’ultimo respiro. Una
immagine commovente, di straordinario valore artistico. E attribuita alla
scuola spagnola, ma secondo Remo Branca rivela riscontri renani (Farris,
op. cit.). Duomo di Oristano (esterno ed
interno)
Duomo di Oristano (esterno ed
interno)

 Quella di Oristano, funzionante
nell’antico edificio degli scolopi, oggi sede del Comune, perdurerà
fino al 1866 dopo la soppressione che darà luogo al Regio
Ginnasio.
Quella di Oristano, funzionante
nell’antico edificio degli scolopi, oggi sede del Comune, perdurerà
fino al 1866 dopo la soppressione che darà luogo al Regio
Ginnasio. Non desidero entrare nel merito di questa
grave decisione dell’Arcivescovo Nin nel 1729 di demolire totalmente l’antica
basilica, ma il desiderio del nuovo a tutti i costi cancellando totalmente
il passato, è un aspetto che ha fatto perdere la testa più volte, nella storia
di tutti i tempi, a coloro che in determinati momenti erano chiamati a
decisioni immediate di scelta.
Non desidero entrare nel merito di questa
grave decisione dell’Arcivescovo Nin nel 1729 di demolire totalmente l’antica
basilica, ma il desiderio del nuovo a tutti i costi cancellando totalmente
il passato, è un aspetto che ha fatto perdere la testa più volte, nella storia
di tutti i tempi, a coloro che in determinati momenti erano chiamati a
decisioni immediate di scelta. Questo filone culturale del “rococò” in
Oristano, trova ancora la sua alta espressione nel bellissimo portale che
porta il nome del suo signore, il marchese Vitu Sotto, contemporaneo dell’Arcais
e deceduto nel 1783.
Questo filone culturale del “rococò” in
Oristano, trova ancora la sua alta espressione nel bellissimo portale che
porta il nome del suo signore, il marchese Vitu Sotto, contemporaneo dell’Arcais
e deceduto nel 1783.