
 |
L'A B C della Musica |
| A lezione di solfeggio | A lezione di ritmica |
Gli strumenti |
Cos'è |
|
|
Benvenuti
a tutti. Questo corso è diviso in sei lezioni, ed esattamente Le note e il pentagramma La durata dei suoni Il ritmo Altri simboli per il ritmo Gli arricchimenti per l'espressione Il tono e il semitono Alla fine di ogni sezione sarà possibile sostenere una verifica sulla bontà del vostro apprendimento. Questa prova verrà effettuata attraverso una serie di programmini che sono in corso di ultimazione. Con questo corso vogliamo darvi le informazioni essenziali per leggere la musica. Chiaramente non vorrà essere esaudiente tutto quello che vi spiegheremo, ma sicuramente quando vi troverete davanti ad un spartito sarete in grado di capire qualcosa di più. Spesso userò l'espressione "notazione musicale in nero", questo per distinguere questa scrittura con quella della "notazione musicale in braille", un altro modo di scrivere la musica. Buon divertimento e buon studio. |
Con
la musica l'uomo ha sempre avuto la possibilità di esprimere i propri sentimenti,
comunicare i propri pensieri, oppure avere un piacevole modo per passare il tempo. Fin
dall'antichità, la musica ha avuto un ruolo importante nella vita culturale, religiosa,
sociale e perchè no, nella vita sentimentale.
|
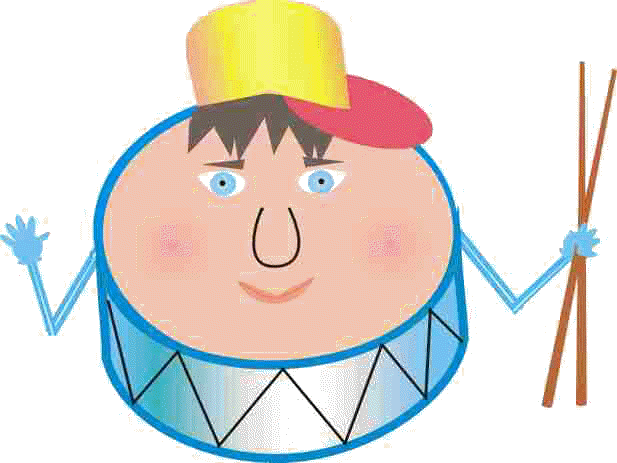 |
|
Come
la scrittura riesce a tramandare ai posteri il sapere, la cultura, il
messaggio, il sentimento, la conoscenza ed altro di chi scrive, così con
le notazioni musicali (ovvero il sistema con cui si scrive la musica)
l'autore non solo riesce a tramandare il suo estro musicale, ma ci fa
suscitare sentimenti, vivere e rivivere emozioni. Ognuno
di noi ha un proprio nome che ci distingue dagli altri. La stessa cosa
accade nella musica che è composta da diversi suoni, dove ognuno
ha un suo preciso nome per distinguerlo dagli altri. Il nome a questi
suoni non è dato a caso ma è costruito in base a precise
regole che andiamo a scoprire. DO RE MI FA SOL LA SI
|
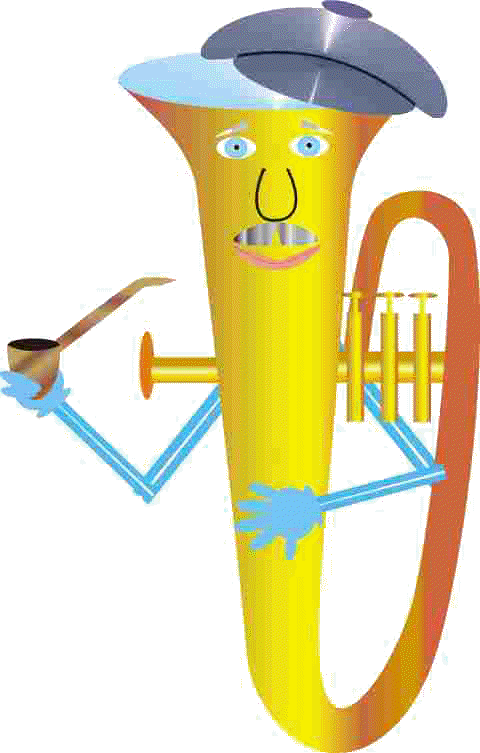 |
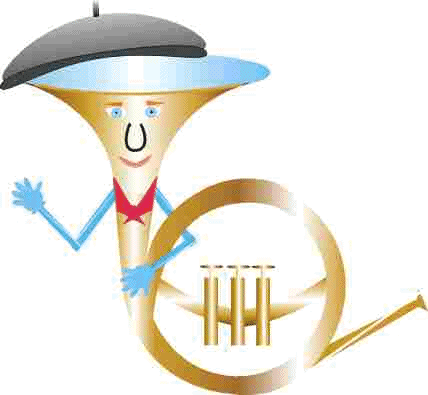 |
Queste sette note
in successione formano una famiglia chiamata ottava, nella
musica di queste famiglie ce ne sono sette e sono una di seguito all'altra.
Se volete vedere tutte queste famiglie insieme, guardate la tastiera di
un pianoforte. Partendo da sinistra abbiamo la prima ottava, poi continuando
verso destra incontreremo la seconda e così via fino ad arrivare
alla settima posizionata tutta a sinistra. Immaginate una scala dove a sinistra
ci sono i gradini più bassi, l'inizio della scala che corrisponde
alla note della prima ottava, e a destra quelli più alti, che corrispondono
alle note della settima ottava. Questa scala o estensione si divide in tre parti o registri: Acuto, Medio e Grave. Il pianoforte e l'organo sono gli strumenti per eccellenza che possono vantare di intonare tutti e tre i tipi di registri. Bene ma ora cominciamo a vedere dove si scrive la musica. |
Il
pentagramma è un sistema costituito da righi e spazi che si alternano tra
loro e più precisamente da cinque righi e quattro spazi.
Partendo dal basso verso l'alto incontriamo il primo rigo, poi il primo
spazio, subito il secondo rigo e via via fini ad arrivare al quinto rigo.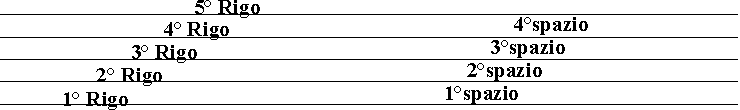
Sul rigo
e nello spazio trovano posto le note, dalla più grave (collocata in basso)
alla più acuta (collocata più in alto): |
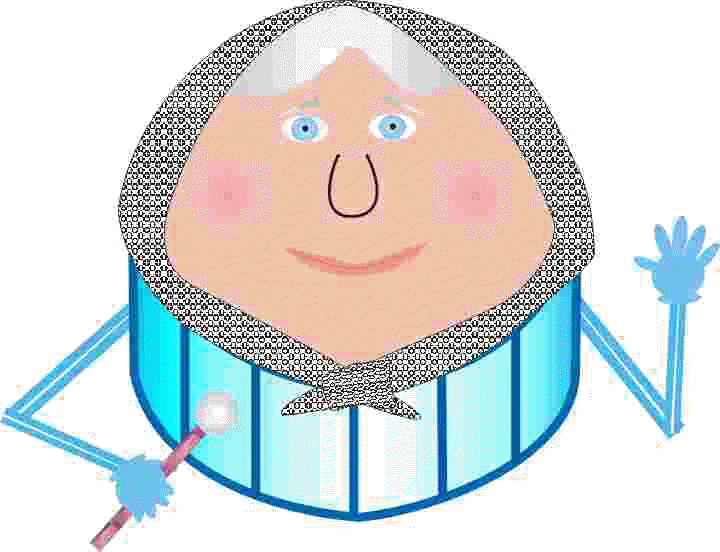 |
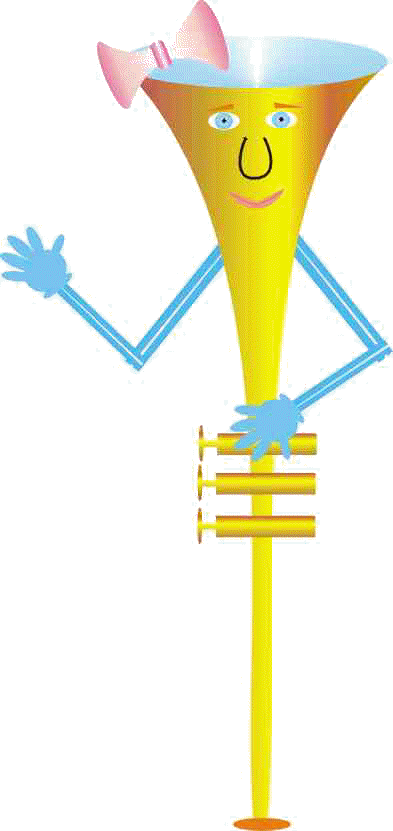 |
Ogni
nota sul pentagramma, raffigurata da un pallino, per farsi riconoscere prende
un
preciso posto
sul rigo o sullo spazio, collocazione determinata dalla chiave musicale
(più
avanti ti spiegherò la sua importanza e funzione) che
è presente all'inizio del rigo musicale o pentagramma. La più usata
di queste chiavi è quella di Sol o chiave di Violino. Questa chiave
stabilisce che un DO si trova nel terzo spazio, il DO successivo (o più
acuto) lo troviamo oltre il quinto rigo. Per raffigurarlo si utilizza un
arteficio grafico, cioè si aggiungono dei piccoli trattini sopra
il quinto rigo, chiamati tagli addizionali, che simulano altri righi e spazi.
Tornando alla nostra nota, questa è raffigurata aggiungendo due tagli
dove sul secondo (quello più in alto) prende posto il DO. In questo
caso si dice che la nota ha un taglio in testa ed uno in gola. In altre
parole è come se avessimo aggiunto al pentagramma un sesto e settimo
rigo e di conseguenza un quinto e sesto spazio. Per farti capire meglio
osserviamo la nota successiva, il RE, che si posiziona sopra il secondo
taglio addizionale, cioè nell'ipotetico settimo spazio. In questo
caso si dice che la nota ha due tagli in gola, il MI avrà un taglio
in testa e due in gola e così via. Per raffigurare il DO che si trova prima di quello che stà nel terzo spazio (quindi con un suono più basso), va fatta la stessa operazione che abbiamo imparato per le note sopra il pentagramma. In questo caso la nostra nota viene raffigurata con un taglio in testa, cioè si utilizza un solo taglio addizionale al di sotto del primo rigo. Se proseguiamo in questa discesa troviamo il SI con un taglio in gola, il LA con un taglio in testa ed uno in gola e così di seguito. |
|
|
|
|
Dunque nella notazione musicale in nero le note prendono posto sul pentagramma. Ma se dovessimo raffigurare tutte le note della scala musicale su questi cinque righi, saremmo costretti ad usare molti tagli addizionali. La naturale conseguenza è che la lettura risulterebbe assai complicata. Per ovviare a questa difficoltà si è ricorsi a un arteficio grafico, appunto la CHIAVE MUSICALE. Questo simbolo, in qualche modo, cerca di far rientrare la maggior parte delle note sul pentragramma in base alla quantita di suoni, che lo strumento o la voce umana, riesce a riprodurre. Questa quantità di note si chiama ESTENZIONE MUSICALE, normalmente comprende circa tre ottave sia per la voce umana che per la gran parte degli strumenti. In musica se ne contano sette di queste chiavi e ognuna ha una sua precisa caratteristica, ma hanno tutte la stessa funzione, quella di semplificare sia la scrittura che la lettura della notazione musicale in nero.Questi sette simboli si definiscono SETTICLAVIO |
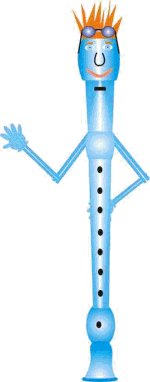 |
|
Chiave
di Sol |
Chiave
di Do
Soprano 
|
Chiave
di Do
Mezzo Soprano 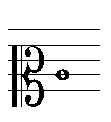 |
Chiave
di Do
Contralto 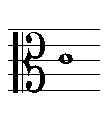
|
Chiave
di Do
Tenore 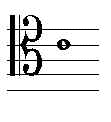
|
Chiave
di Fa
Baritono 
|
Chiave di
Fa
|
|
La nota segnalata in ogni chiave corrisponde al DO, partite da questa e costruite la scala per ogni chiave. Il sistema di scrittura della musica nella nostra civiltà è quello che ti sto esponendo su questa pagina, ma alcuni Paesi si differenziano per il diverso modo di chiamar le note, infatti questi suoni vengono chiamati con le lettere dell'alfabeto. |
| Nel resto del mondo le note sono | LA | SI | DO | RE | MI | FA | SOL |
| Nei paesi di lingua inglese (Gran Bretagna e Stati Uniti) partendo dal LA | A | B | C | D | E | F | G |
| Mentre nei paesi di lingua tedesca (Germania e Austria) partendo sempre dal LA | A | H | C | D | E | F | G |
| Come avrete notato nei paesi di lingua tedesca, al posto della B, per indicare il SI usano la H e questo perchè con la lettera B indicano il bemolle (che incontreremo più avanti nella sezione Il tono e il semitono). |
| TORNA A INIZIO PAGINA | AVVISO |
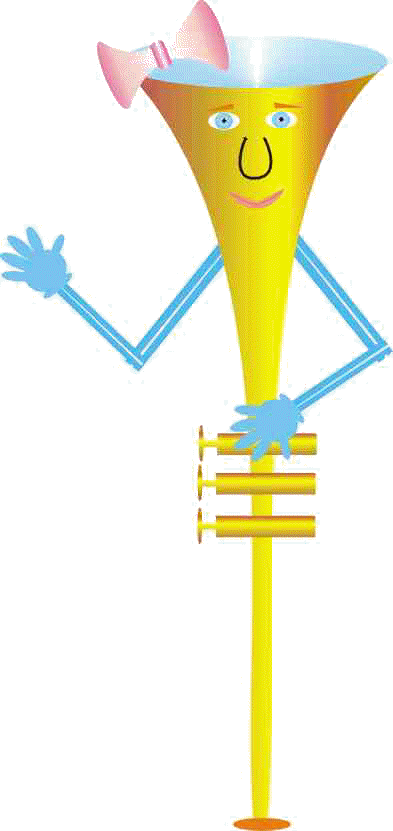 |
Fino a qui abbiamo
visto dove si collocano sul pentagramma (chiamata anche ALTEZZA), ma ancora
non basta per completare quel nome che lo distingue da un'altro. I suoni
hanno una durata, in un brano musicale ci può essere un un DO lungo,
per esempio DOOOOOOOOOOOO, oppure si può incontratre un DO corto,
per esempio DO. Allora come si indica il tempo che deve durare una nota?
Qui intervengono dei segni grafici, per la notazione musicale in nero,
che ci fanno capire quanto il suono è lungo o meglio, dura una
nota. |
|
FIGURA |
Semibreve |
Minima |
Semiminima |
Croma |
Semicroma |
Biscroma |
Semibiscroma |
|
PAUSA |
Semibreve |
Minima |
Semiminima |
Croma |
Semicroma |
Biscroma |
Semibiscroma |
| VALORE | intero |
metà del valore intero |
1/4 del valore intero (oppure la metà della figura precedente) |
1/8 del valore intero (oppure la metà della figura precedente) |
1/16 del valore intero (oppure la metà della figura precedente) |
1/32 del valore intero (oppure la metà della figura precedente) |
1/64 del valore intero (oppure la metà della figura precedente) |
|
Riepilogando:
la semibreve ha la durata intera, la minima è la metà della
semibreve; la semiminima dura la metà della minima ma a sua volta
dura un quarto rispetto alla semibreve; segue la croma che dura la metà
della semiminima, un quarto il tempo della minima e un ottavo di quello
della semibreve; a questo punto prova tu ad andare avanti nel riepilogo.
Tenendo
d'occhio la matematica si ha che 2/4=1/8+1/4+1/16+1/16. E tante altre
combinazioni. |
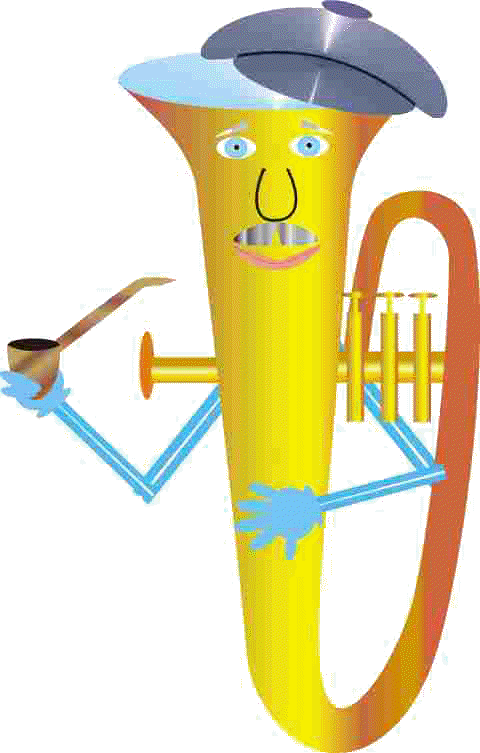 |
| TORNA A INIZIO PAGINA | AVVISO |
|
|
Fino ad ora abbiamo
visto la durata e l'altezza delle note, ma da sole queste due componenti
non sono sufficenti per formare una melodia. L'altro elemento importante
è la misura della musica. Come per le distanze esiste l'unità
di misura che è il metro, per i pesi c'è il kilogrammo,
per i liquidi il litro, ecc., per la musica sono diverse le unità
di misura che tra un pò andremo a conoscere. |
| Queste
tre misure musicali sono i tempi semplici su cui si costruiscono le melodie:
2/4 quattro quarti, 3/4 tre quarti e 4/4 due quarti. Ce ne sono degli altri,
detti "tempi composti", dei quali ce ne occuperemo in un alto
momento. Prendiamo un tempo qualsiasi, quello di 2/4, il numeratore (quel numero che stà sopra) indica che i movimenti sono due, mentre 3/4 stà ad indicare che i movimenti sono tre e per 4/4 sono quattro. Ma attenzione questa frazione, che nella notazione musicale in nero è posta subito dopo il segno di chiave, indica anche quanti spicchi di quella mela che abbiamo tagliato nella precedente lezione possono entrare nei movimenti. Osserviamo con attenzione questa notazione 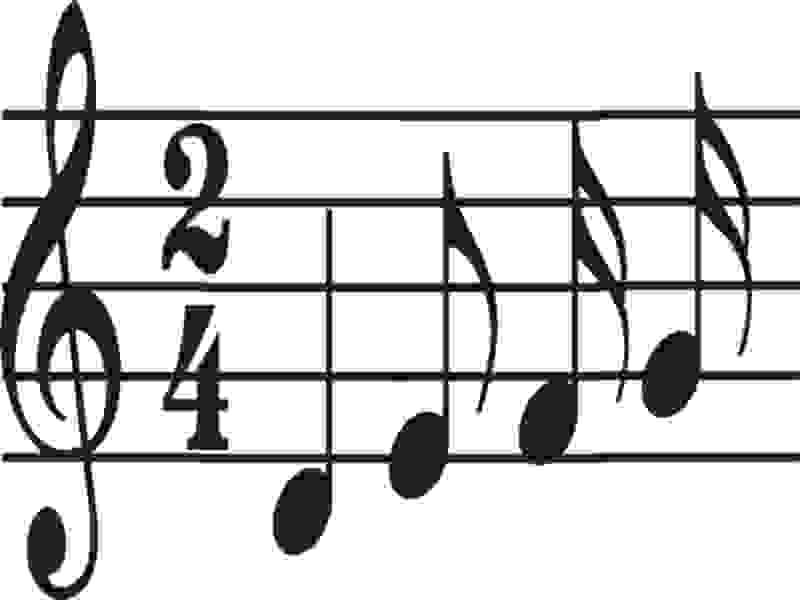 :
all'inizio del rigo c'è la chiave di violino, poi il tempo che in
questo caso è di 2/4, nel
primo movimento notiamo una semiminima, mentre nel secondo troviamo una
croma e due biscrome. Traducendo tutto con linguaggio matematico
abbiamo nel primo movimento 1/4 e nel secondo 1/8 + 1/16 + 1/16 = 1/4, in
questo modo tutta la battuta di 2/4 è soddisfatta. Analogo disorso vale
per gli altri due tempi. Torneremo su quest'argomento quando parleremo del
solfeggio. :
all'inizio del rigo c'è la chiave di violino, poi il tempo che in
questo caso è di 2/4, nel
primo movimento notiamo una semiminima, mentre nel secondo troviamo una
croma e due biscrome. Traducendo tutto con linguaggio matematico
abbiamo nel primo movimento 1/4 e nel secondo 1/8 + 1/16 + 1/16 = 1/4, in
questo modo tutta la battuta di 2/4 è soddisfatta. Analogo disorso vale
per gli altri due tempi. Torneremo su quest'argomento quando parleremo del
solfeggio. |
|
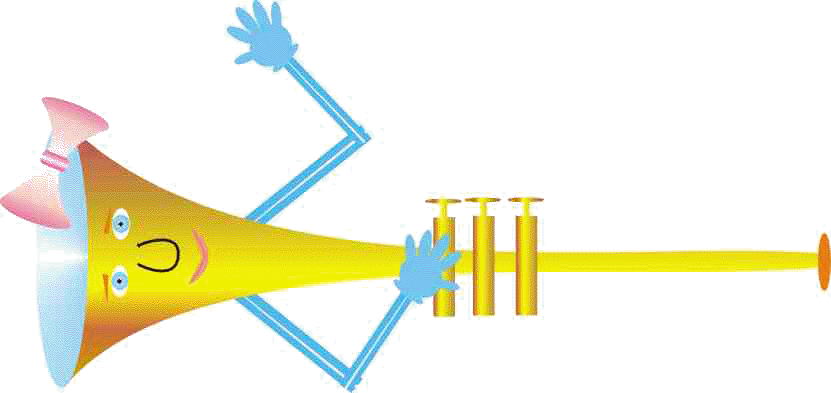 |
Torniamo al tichettio dell'orologio, se provate ad ascoltarlo vi sembrerà che uno dei due battiti sia più forte dell'altro. Nel ritmo questa impressione è invece di fondamentale importanza, infatti esso è costituito da una successione di accenti forti e deboli. Come abbiamo già accennato tre sono i ritmi principali, e più esattamente: |
| Il ritmo binario, è quando un accento forte si alterna ad uno debole, cioè un 2/4, utilizzando come esempio le sillabe: |
sia - mo |
sta - ti |
bra - vi |
| Il ritmo ternario, è quando un accento forte si alterna a due deboli, ovvero 3/4: |
ot - ti - ma |
splen - di - ta |
mu - si - ca |
| Il ritmo quaternario, o 4/4 è quando un accento forte si alterna tre deboli: |
e - se - gui - re |
no - ta - zio - ni |
mu - si - ca - li |
| Il ritmo, nella notazione musicale, viene indicato all'inizio dello spartito, subito dopo la chiave musicale. Nel pentagramma le stanghette verticali delimitano le porzioni di tempo, in ogni sezione o battuta, le note vengono eseguite rispettando gli accenti o i movimenti. | 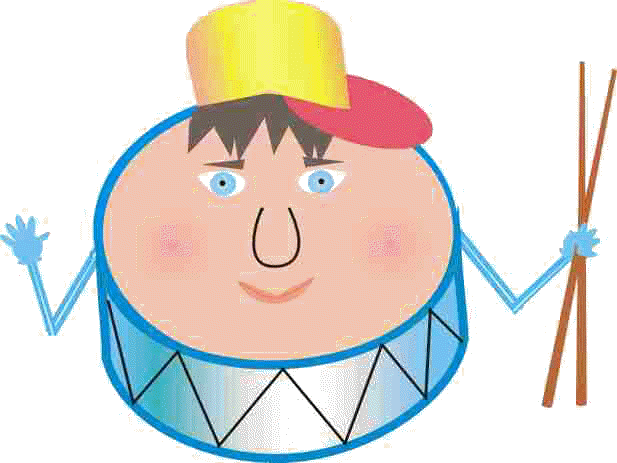 |
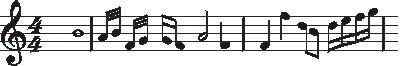 |
Nella figura qui accanto potete vedere come
è raffigurato ciò che fino ad ora abbiamo detto. |
| All'inizio del rigo la chiave musicale (chiave di sol o di violino); poi l'indicazione del ritmo 4/4, costituito da un accento forte e tre deboli; le barrette verticali che delimitano la battuta. Provate a osservare le notazioni musicali di uno spartito, vi renderete conto che qualsiasi sia il numero delle figure ritmiche all'interno di ogni battuta, la somma totale corrisponderà al tempo indicato all'inizio della pagina musicale. |
| TORNA A INIZIO PAGINA | AVVISO |
| Abbiamo visto che cos'è il ritmo e come, grazie alla combinazione dei diversi valori delle note, un brano musicale comincia a predere corpo. Ma ancora tutto ciò non basta. La notazione musicale è una scittura, e come si conviene in ogni tipo di scrittura, si utilizzano degli artefici per renderla semplice e di conseguenza la sua lettura. Nella notazione musicale tutto questo viene costruito con dei simboli che vanno ad arricchire il ritmo. Questi sono: | 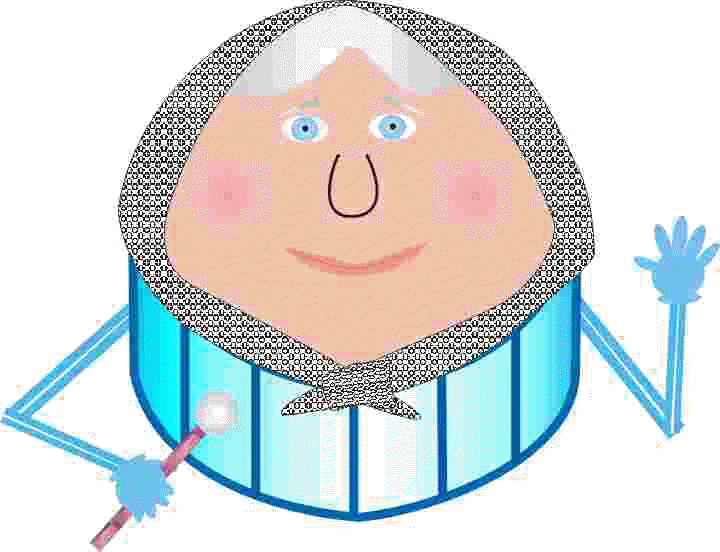 |
 |
|
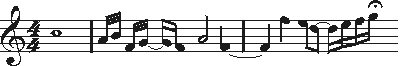 |
In questa figura si vedono le legature, sia nella stessa battuta che tra battute vicine, sull'ultima nota il punto coronato. |
|
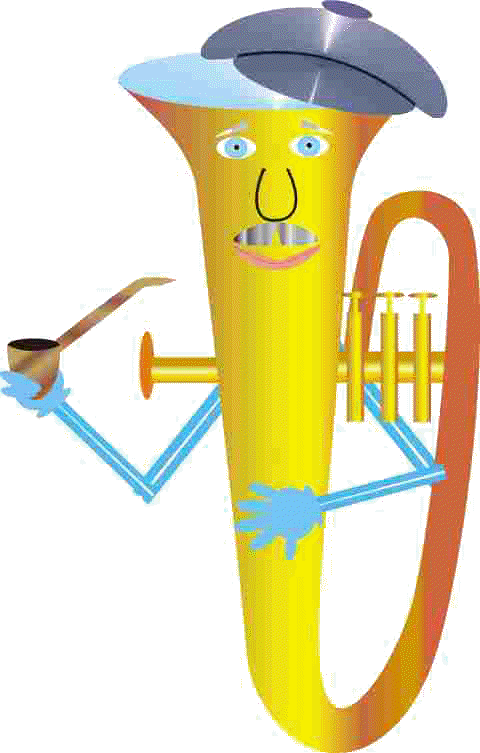 |
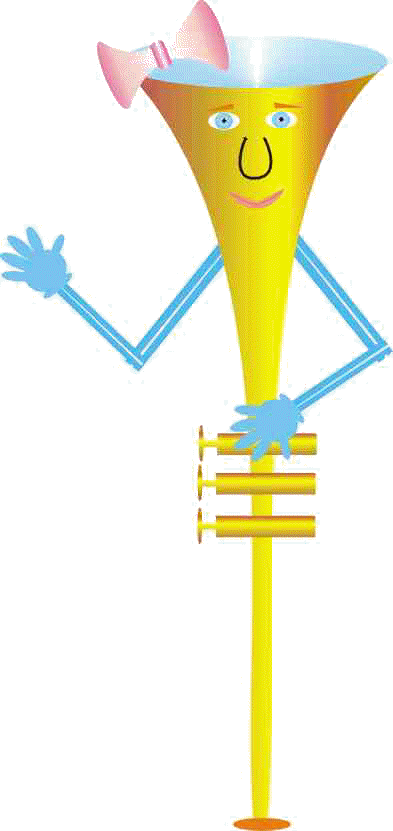 |
L'agogica.
Abbiamo visto che cos'è il ritmo, ma da solo non basta a determinarne la
velocità d'esecuzione. Per siegare meglio: quando accompagniamo una funzione religiosa,
eseguiamola musica in modo lento, viceversa quando suoniamo una marcia il suo andamento
sarà senz'altro veloce. Per indicare a quale velocità vanno eseguiti i brani i
compositori si servono di determinati aggettivi (indicati all'inizio del brano), detti
appunto angogica. I più diffusi sono: Lento - Adagio - Andante - Moderato - Mosso - Allegro - Presto queste indicazioni angogiche indicano la velocità del brano e non necessariamente il carattere, un brano Allegro può in realtà possedere un carattere drammatico e severo. Altre due indicazioni vengono usate quando all'interno del brano c'è una variazione di velocità, accel.=accelerando e rall.=rallentando. Si pone l'indicazione a tempo quando si vuole interrompere questi due ultimi effetti, tornando alla velocità iniziale. |
| TORNA A INIZIO PAGINA | AVVISO |
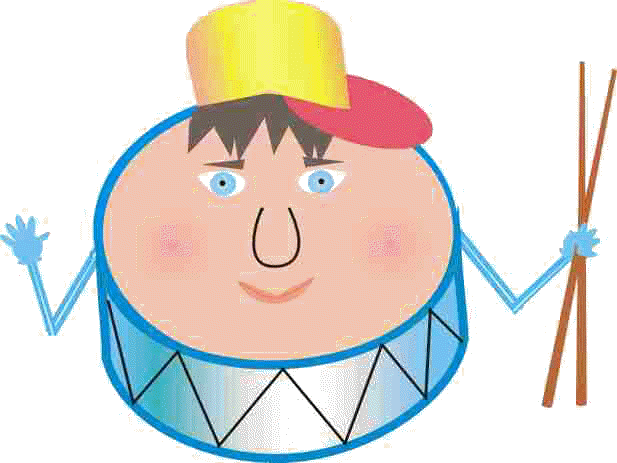 |
Fin qui abbiamo visto le note, la loro altezza, la durata, il ritmo e i suoi arricchimenti con il quale eseguire le successione delle note. Ma per eseguire un brano musicale tutto questo non è ancora sufficente. Quì la notazione musicale possiede una marcia in più rispetto alla scrittura normale, dove al suo interno non ha i simboli per esprimere oralmente il contenuto di un testo scritto. Infatti nel recitare una filastrocca o una poesia, l'interpretazione è lasciata alla sensibilità dell'oratore. Nella scrittura musicale invece ci sono dei simboli che riescono a dare al brano dinamicità, espressività e i necessari abbellimenti per dare al fraseggio musicale la giusta interpretazione che l'autore aveva sia nelle mente che nel cuore al momento delle composizione. |
| Per indicare la
dinamica si usano alcune abbreviazioni da porre sopra o sotto le note , ecco le
principali: pp pianissimo p piano mp mezzo piano mf mezzo forte f forte ff fortissimo sfz sforzato (quando un suono deve essere suonato con un particolare accento) rfz rinforzato (rfz può essere sostituito dal segno > posto sopra la nota da accentare) Inoltre nella dinamica fanno parte i crescendo e i diminuendo, cioè il progressivo aumento e diminuzione dell'intensità: cres. oppure una forcella aperta verso destra dim. oppure una forcella aperta verso sinistra |
|
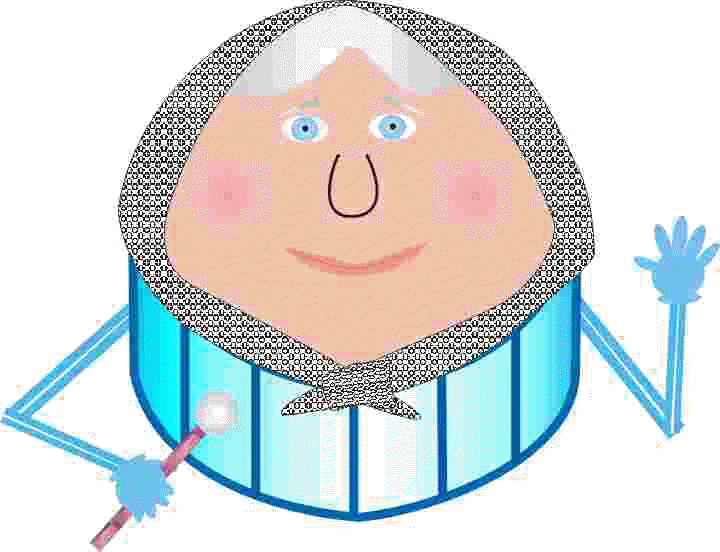 |
A questo proposito, per spiegarci meglio tii vogliamo raccontare un episodio accaduto durante le prove di un direttore d'orchestra tedesco (per essere più precisi parliamo di Hans von Bülow): il direttore fermò le prove rivolgendosi al primo corno e gli disse - Primo corno "forte"-. Ripreso le prove il musicista prese a suonare con maggiore intensità, ma il direttore le rifermò e per la seconda volta rivolgendosi al primo corno ripete - ho detto "forte"-. Ripreso di nuovo il passaggio il povero strumentista suonò con tutto il fiato che aveva e il direttore si vide costretto ha fermare di nuovo l'esecuzione e redarguirlo per la terza volta. "Non mi sono spiegato, ma lei deve suonare forte". Il primo corno rispose" Sig. Maestro, non riesco a suonare più forte di così", "appunto" rispose il maestro, "lei stava suonando fortissimo, mentre la partitura indica forte". |
Altri segni
che contribuiscono ad accrescere le informazioni necessarie per interpretare un brano
musicale sono:
|
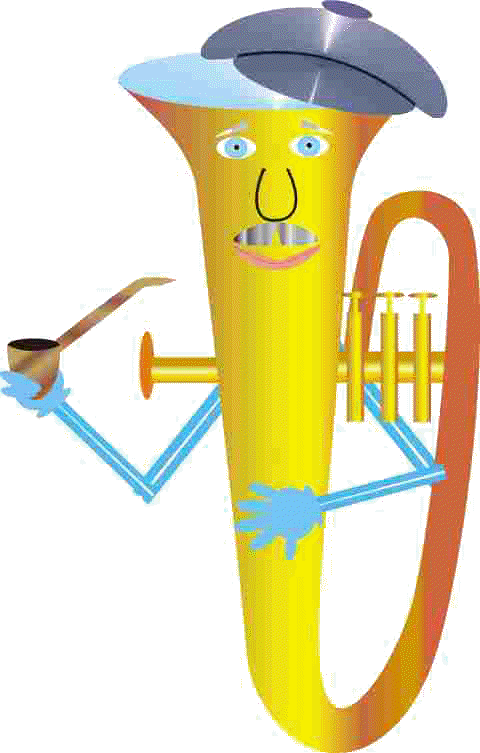 |
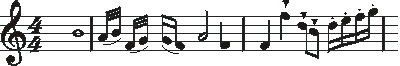 |
Nella figura si
possono vedere questi due primi segni: nella seconda battuta c'è la legatura d'espressione, mentre nella terza lo staccato. |
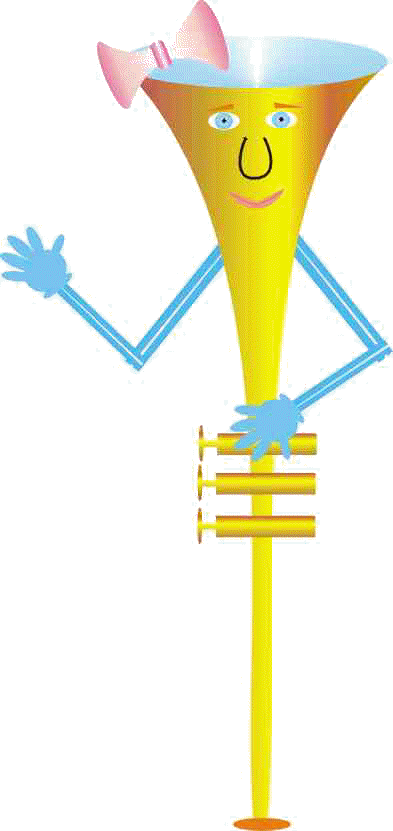 |
Gli abbellimenti
o fioritura, nel discorso musicale, non sono essenziali hanno
solo una funzione decorativa, contribuiscono però a renderlo più espressivo e
caratteristico. Sono delle figure standardizzate e per questo vengono indicate più
piccole o con segni convenzionali. in ordine sono:
|
| Nella figura qui
sotto sono rappresentati questi altri simboli e le corrispondenti modalità d'esecuzione.
|
| TORNA A INIZIO PAGINA | AVVISO |
 |
L'argomento
che andiamo a trattare in questa lezione è:
|
| Per indicare queste alterazioni o accidenti si usano i seguenti segni: |
| Diesis |
Bemolle |
Bequadro |
| alterazione che innalza la nota di un semitono | alterazione che abbassa la nota di un semitono | questo segno toglie l'alterazione alla nota riportandola allo stato naturale |
| Tenendo bene a mente questa tabella e riguardando la tastiera del pianoforte, si può affermare che ogni tasto nero può essere definito in due modi diversi: |
| Do |
Re |
Fa |
Sol |
La |
Mentre se si alterano le note Mi, Fa,Si e Do, non facciamo altro che indicare il suono del tasto vicino.
| Mi |
Fa |
Si |
Do |
L'alterazione è
segnalata in due diversi modi, fissa e mobile:
Il simbolo del bequadro, come abbiamo già detto, annulla l'alterazione. Quest'annullamento avviene:
In fine le alterazioni possono essere doppie, ossia:
|
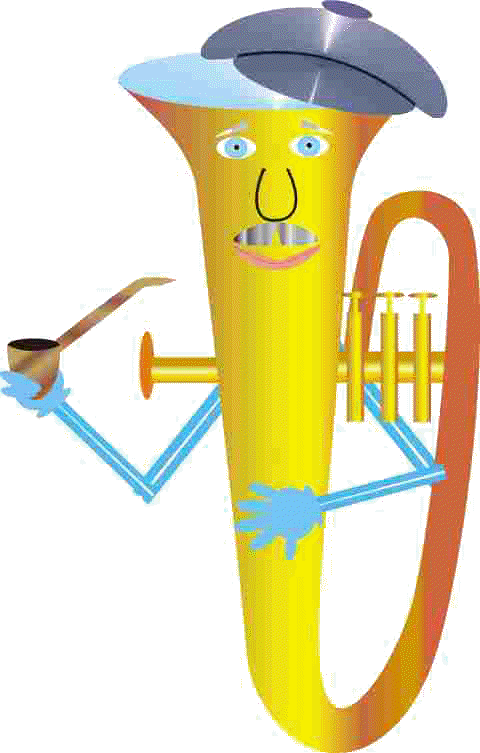 |
| TORNA A INIZIO PAGINA | AVVISO |
| A lezione di solfeggio | A lezione di ritmica |
Gli strumenti |
Cos'è |