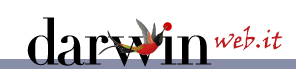a possibilità di curare malattie con terapie basate sulle cellule
staminali ha suscitato un enorme interesse sia fra i ricercatori sia
fra i malati. L’entusiasmo è però frenato dal fatto che, al momento,
le staminali embrionali sono ritenute tecnicamente superiori a quelle
derivate da altre fonti, quali il sangue del cordone ombelicale o i tessuti
dell’organismo umano adulto. In questo contesto, le scelte politiche
e normative riguardo alla ricerca sulle staminali si sono intrecciate con
il dibattito etico sulla creazione e la distruzione degli embrioni, lasciando
il legislatore alle prese con il dilemma, a quanto pare arduo, del
valore morale dell’embrione umano. Il dibattito continuerà ma inevitabilmente
proseguirà anche la ricerca sulle staminali, e sembra altrettanto
inevitabile che, con il progredire delle conoscenze, sorgeranno
ulteriori dilemmi etici e politici. Lo spostamento del fulcro delle ricerche
dalla scienza di base allo sviluppo di applicazioni terapeutiche, ormai
vicino, fa sorgere importanti questioni di giustizia sociale. La transizione
è contraddistinta da un crescente interesse per l’istituzione di
banche di cellule staminali, sia come strumento per aiutare la ricerca sia
in vista dell’impiego di trapianti di materiale ricavato dalle staminali per
la terapia di malattie come la sclerosi laterale amiotrofica, il morbo di
Parkinson e il diabete. La creazione di tali banche solleva interrogativi
riguardo a chi beneficerà delle banche stesse e delle loro applicazioni
alla ricerca e alla terapia. Il primo dubbio è su chi avrà i mezzi finanziari
per accedere alle terapie. Inoltre, dato che alcune paesi hanno vietato
per legge l’impiego delle staminali embrionali, l’accesso alle terapie
ricavate dalle linee cellulari conservate nelle banche, e in particolare
da quelle di origine embrionale, potrà essere limitato da ostacoli legali.
Un’ultima questione, l’oggetto di questo articolo è chi avrà accesso
biologicamente alle nuove terapie. Come si vedrà, le stesse proprietà
biologiche delle cellule staminali possono renderle meno utilizzabili
per alcuni potenziali beneficiari che per altri. Questa situazione è stata
da noi definita come il problema dell’accesso biologico. Se tale nodo
non sarà affrontato con attenzione, un’eventuale banca statunitense
delle staminali potrebbe favorire i cittadini bianchi, escludendo in qualche
misura il resto della popolazione. Bisogna quindi chiedersi quale,
fra tutti i modi possibili di strutturare la banca, sia il più equo.
Per il futuro, la promessa delle manipolazioni cellulari è la capacità
di controllare il comportamento e le funzioni delle cellule. Nel frattempo,
però, è plausibile pensare che verranno messe a punto terapie
cellulari che prevedono la cura di malattie e traumi mediante
il trapianto di cellule staminali o dei loro prodotti.
Come per i trapianti convenzionali, uno dei più
seri problemi che si profilano è quello del rigetto. Il rigetto
immunitario è la ragione principale per cui una
terapia basata sulle staminali potrebbe essere meno accessibile
ad alcuni malati che ad altri.
Il rigetto e i trapianti autologhi
Il rigetto è legato alla nostra costituzione genetica, e
specificamente all’insieme di geni che codifica per un
tipo di proteine dette antigeni leucocitari umani
(HLA, human leucocyte antigen). Le proteine HLA si
trovano sulla superficie di pressoché ogni cellula dell’organismo,
incluse le staminali, e svolgono un ruolo
importante nel riconoscimento e nel rigetto da parte
del sistema immunitario. I geni che codificano per gli
antigeni HLA sono molti e di ciascuno ne possediamo
due copie, ereditate una da ciascun genitore e situate
su ciascuna coppia dei cromosomi. Fra i geni più importanti
per il riconoscimento e la risposta immunitaria
legata al sistema HLA ci sono HLA-A, HLA-B e
HLA-DR. Questi geni sono altamente polimorfici, ne
esistono cioè numerose varianti, ciascuna delle quali è
nota come allele. Quando un individuo ha due alleli
diversi, ereditati da ciascun genitore, è eterozigote per
quell’allele. Ma se per caso entrambi i genitori trasmettono
lo stesso allele per un dato gene, il figlio è
omozigote per quell’allele, vale a dire che ne ha due
copie identiche.
Gli alleli possono essere caratterizzati con diversi
metodi, mediante esami sierologici o del DNA, e di solito
sono denominati con codici numerici, come 0101.
Individuare il tipo HLA di un individuo significa stabilire
quali alleli possiede in specifiche posizioni sul cromosoma.
Per la funzione immunitaria mediata dal sistema
HLA sono particolarmente importanti tre posizioni:
A, B e DR. Si dice che il donatore e il ricevente
sono compatibili quando entrambi possiedono gli stessi
alleli HLA-A, HLA-B e HLA-DR. In realtà anche altri
geni del complesso HLA e non contribuiscono al riconoscimento
e alla risposta immunitaria, sia pure con
effetti minori. Quindi, anche quando fra donatore e ricevente
si ha una compatibilità perfetta per HLA-A, B
e DR, con la coincidenza di tutti e sei gli alleli, occorre
comunque impiegare un certa dose di immunosoppressori.
Il tipo HLA di ogni individuo dipende dalla
famiglia da cui discende, tuttavia anche fra i membri
di una stessa famiglia gli antigeni HLA variano. I gemelli
identici hanno gli stessi antigeni HLA perché
hanno ricevuto dai genitori lo stesso corredo genetico.
I fratelli hanno all’incirca una probabilità su quattro
di possedere uno stesso tipo HLA. Viceversa, non
succede praticamente mai che genitori e figli abbiano
HLA identici perché entrambi i genitori contribuiscono
agli alleli dei figli e la probabilità che i due genitori
abbiano lo stesso tipo HLA è irrisoria. Nel trapianto
del midollo osseo e di alcuni organi solidi la corrispondenza
fra il tipo di HLA del donatore e quello del
ricevente è cruciale nel determinare l’accettazione o il
rigetto del tessuto estraneo. Se si eccettuano i gemelli
identici, trovare una compatibilità perfetta fra due
persone è difficile a causa della natura altamente polimorfica
degli alleli HLA. L’insieme di alleli che una
persona possiede è detto aplotipo. Per chi ha un aplotipo
relativamente comune, trovare un donatore compatibile
può non essere difficile; per chi ha aplotipi più
rari, il donatore idoneo può non essere disponibile. Si
possono anche eseguire trapianti in cui non ci sia una
buona compatibilità, ma è una scelta non ottimale perché
in tal caso è necessario ricorrere a farmaci immunosoppressori
a dosi più alte, con effetti collaterali più
gravosi e complicazioni più frequenti. Alcuni dati fanno
pensare che il numero di alleli HLA non corrispondenti
abbia un effetto cumulativo nel determinare
gli esiti negativi; i risultati, cioè, si fanno gradatamente
da buoni a scadenti man mano che cresce il numero
di alleli non corrispondenti.

Chi possiede aplotipi più comuni ha quindi maggiori
probabilità di trovare un donatore compatibile -
vale a dire, di avere accesso biologico alla terapia - e ottenere
un trapianto di successo. È dimostrato che
l’HLA è associato all’ascendenza geografica. Fra gli
originari dell’Africa subsahariana, per esempio, si ritrova
una maggiore varietà di tipi HLA che in qualsiasi altro
gruppo geografico o etnico. L’ascendenza di un individuo
può quindi ridurre o accrescere di molto le
probabilità di trovare un donatore compatibile, tanto
di midollo osseo, o di certi organi solidi, quanto di cellule
staminali. Il rigetto è un tema di primo piano negli
studi sui trapianti e c’è un’attiva ricerca di metodi che
permettano a ogni paziente, a prescindere dal suo aplotipo,
di ricevere un organo estraneo con buoni risultati.
Se questa linea d’indagine avrà successo il concetto
di accesso biologico finirà forse per perdere significato.
Per ora, comunque, il rigetto è un ostacolo concreto
al successo clinico. Dato che la compatibilità perfetta
fra donatore e ricevente riduce di molto il rischio
di rigetto, gli autotrapianti, in cui il tessuto da
trapiantare viene prelevato dal paziente stesso, sono ritenuti
una via promettente per evitare questo pericolo.
Purtroppo però due soluzioni che permetterebbero l’uso
di tessuto autologo, il trasferimento di nucleo da cellule
somatiche - la cosiddetta clonazione terapeutica -
e l’isolamento delle staminali presenti nel corpo del paziente
stesso, non sono al momento praticabili.
La prima tecnica prevede che il nucleo di una cellula
somatica del paziente cui è destinato il trapianto
sia introdotto in un ovocita, dove in precedenza è stato
asportato il nucleo; l’ovocita viene quindi indotto a
svilupparsi. Le cellule staminali ricavate dalle blastocisti
umane così create potrebbero offrire al ricevente
una compatibilità genetica perfetta eccetto per i geni
mitocondriali, comunque irrilevanti ai fini del tipo
HLA. Secondo chi la sostiene, tale tecnica permetterebbe
di ricevere terapie su misura dal punto di vista
della compatibilità HLA. Ma la validità di questa asserzione
è smorzata da considerazioni economiche e
organizzative. Anche se in teoria il trasferimento di
nucleo può risolvere il problema del rigetto e dell’accesso
biologico, può farlo solo per un individuo alla
volta, e il dispendio di tempo e denaro necessario a
creare le linee di staminali personalizzate rende improbabile
che tale soluzione sia praticabile su larga
scala. Per di più, in un futuro prevedibile, la ricerca nel
settore continuerà a essere oggetto di controversie politiche
e morali.
Alcuni dei limiti descritti affliggono anche la seconda
strategia autologa: l’impiego di cellule staminali
isolate e coltivate dai tessuti del paziente stesso. C’è chi
sostiene che, perlomeno nei modelli animali, si possano
ricavare dall’adulto staminali con capacità di sviluppo
simili a quelle embrionali. Dal punto di vista delle
scelte politiche pubbliche si tratta di un’alternativa
molto attraente, perché evita del tutto il difficile nodo
della distruzione dell’embrione. Se i tessuti adulti siano
davvero in grado di sostituire gli embrioni come fonte
di staminali resta da dimostrare, ma anche se le staminali
dell’adulto si dimostreranno altrettanto potenti e
versatili di quelle embrionali, usarle per ricavarne terapie
autologhe non sarà facile, perlomeno per il prossimo
futuro. Infatti le procedure di laboratorio disponibili
sono estremamente inefficienti nel generare cellule
in quantità sufficiente, perché l’isolamento delle staminali
adulte ha una resa molto scarsa e le cellule sono
difficili da coltivare. Al pari del trasferimento di nucleo,
quindi, il ricorso alle staminali adulte è dispendioso in
termini sia di tempo sia di denaro.
In particolari circostanze gli sforzi necessari a preparare
terapie personalizzate potrebbero essere giustificati.
Nel caso di un bambino con una grave malattia
cronica, per esempio, una terapia che lo guarisse risparmierebbe
al sistema sanitario i costi di un’intera vita
di cure e offrirebbe al piccolo un beneficio immenso.
Per la maggior parte delle malattie, però, i costi delle
terapie autologhe personalizzate sarebbero proibitivi,
anche per i paesi ricchi. Inoltre per condizioni quali
gli ictus o i traumi, in cui per ottenere i migliori risultati
può essere necessario un trattamento molto
tempestivo, la preparazione delle terapie a partire da
cellule adulte (o clonate) rischia di essere impossibile
nei tempi richiesti. In teoria, nell’arco di tempo necessario
a preparare la terapia personalizzata si potrebbe
aiutare il paziente con trapianti non autologhi abbinati
a un trattamento immunosoppressivo, ma con ogni
probabilità, ancora una volta, i costi sarebbero proibitivi.
I tessuti adulti non sembrano quindi molto più
promettenti della clonazione come soluzione definitiva
del nodo del rigetto e dell’accesso biologico, perlomeno
per il futuro prevedibile.
Strategie alternative
Di qui in avanti si prenderà in considerazione l’ipotesi
che non esiste una soluzione “autologa” al problema
dell’accesso biologico, perlomeno finché la capacità
di manipolare le cellule non sarà progredita al punto
da rendere la manipolazione in vivo delle staminali
una procedura ordinaria. Nel frattempo, le terapie
umane ricavate dalle staminali richiederanno con ogni
probabilità il trapianto di tessuti generati a partire da
un donatore non geneticamente identico. Si darà inoltre
per scontato che, sebbene gli interventi su organi
come il fegato o il cervello possano risultare relativamente
esenti dal pericolo di rigetto, almeno alcune
delle terapie con cellule staminali dovranno fare i conti
con tale rischio.
Al momento per affrontare il rigetto ci sono tre
possibilità di rilievo: i farmaci immunosoppressori, la
tolleranza indotta clinicamente e la compatibilità
HLA. Spesso due o più di queste tecniche sono usate
in combinazione. Una quarta tecnica, la modificazione
genetica delle linee cellulari per ridurne la capacità
di suscitare una reazione immunitaria, oggi non trova
applicazioni nella clinica dei trapianti ma forse potrà
essere impiegata in futuro nelle terapie cellulari. In teoria
con le manipolazioni genetiche si potrebbero creare
cellule staminali “universali”, che non provocano risposte
immunitarie nella maggior parte dei pazienti.
Dal punto di vista di equità sociale uno sviluppo del genere
sarebbe l’ideale, perché garantirebbe l’accesso
biologico a tutti. Gli esperimenti su animali indicano le
strade per perseguire tale obiettivo, ma gli ostacoli tecnici
da superare per sconfiggere le molteplici difese del
sistema immunitario sono formidabili e potranno occorrere
anni, se non decenni, prima che questi tentativi
abbiano successo.
La strategia più utilizzata contro il rigetto è l’immunosoppressione.
L’impiego su vasta scala degli immunosoppressori
è iniziato negli anni Ottanta e ha accresciuto
notevolmente la fattibilità delle donazioni di
organi non compatibili. In molti casi, tuttavia, chi riceve
il trapianto deve proseguire a oltranza l’immunosoppressione
farmacologica per evitare il rigetto acuto
o cronico, anche quando la compatibilità HLA è buona.
I rischi della terapia immunosoppressiva sono ben
documentati e a volte gravi, includono nefrotossicità,
complicazioni diabetiche e vascolari e un maggior rischio
di infezioni.
Un’altra strategia antirigetto è l’induzione della
tolleranza immunologica. Gli esperimenti su animali
hanno mostrato che esistono diversi metodi per ridurre
la risposta immunitaria dell’ospite e promuovere
l’accettazione del tessuto trapiantato, frenando così il
rigetto e riducendo il bisogno di immunosoppressori.
Tuttavia le applicazioni sull’uomo sono ancora in via
di sviluppo e al momento piuttosto rischiose. Una tecnica
per indurre la tolleranza, il chimerismo misto, è
particolarmente interessante alla luce del fatto che una
singola linea di staminali può generare diversi tipi di
tessuti. Nel chimerismo misto il candidato al trapianto
è sottoposto a un temporaneo trattamento immunosoppressivo
e a un innesto di midollo osseo del donatore,
prima di ricevere il trapianto d’organo dallo
stesso donatore. Se la tecnica riesce il ricevente sviluppa
un sistema immunitario chimerico, composto
sia da cellule immunitarie proprie sia da quelle nuove
giunte con il midollo osseo. Il sistema immunitario
chimerico dovrebbe essere tollerante verso i nuovi
tessuti provenienti dallo stesso donatore, incluso l’organo
trapiantato. Al momento la procedura è stata utilizzata
su pochi pazienti, soprattutto per via dei rischi
che comporta, dell’incerta efficacia e della necessità di
un donatore vivente che fornisca sia il midollo osseo
sia l’organo (per esempio un rene). I dati dagli esperimenti
sugli animali sono comunque promettenti. Nel
caso delle terapie con staminali, se dalla stessa linea di
staminali si riuscisse a ricavare sia le cellule emopoietiche
per indurre la tolleranza sia il tessuto da impiegare
per la terapia, la tecnica del chimerismo misto potrebbe
essere adoperata per trattamenti che non richiedono
né una pesante immunosoppressione né la
compatibilità HLA.
La terza strategia per evitare il rigetto è la compatibilità
HLA, la cui importanza varia comunque a seconda
del tessuto o dell’organo. Per il midollo osseo,
per esempio, la compatibilità HLA è ritenuta essenziale
per un buon esito clinico, mentre nel caso del fegato
di solito non se ne tiene conto. L’importanza della
compatibilità varia anche a seconda della disponibilità
di donatori e della gravità della malattia; come si è detto
in alcune circostanze, e in primo luogo se manca un
donatore compatibile, si ricorre ai trapianti a bassa
compatibilità, seppur ritenuti non ottimali.
Lo US National Marrow Donor Program (il programma
nazionale statunitense per la donazione del
midollo osseo) ha compilato un registro di oltre quattro
milioni di donatori, ciascuno dei quali è stato tipizzato
per gli alleli HLA-A e B, ritenuti critici per la compatibilità.
A causa dell’alto grado di polimorfismo degli
alleli in questione, anche con un pool così vasto solo
il 50-60% dei pazienti bisognosi di trapianto trova
un donatore idoneo. Non solo gli alleli HLA sono altamente
variabili, ma nei diversi gruppi etnici gli specifici
alleli sono presenti con frequenze differenti, i dieci
alleli HLA-A più comuni negli statunitensi bianchi,
per esempio, sono diversi dai dieci più frequenti negli
afroamericani. La comunità dei trapianti ha lottato per
anni con il problema dell’ineguale distribuzione degli
alleli HLA e delle sue conseguente sui rischi di rigetto,
in particolare per chi, per la sua appartenenza etnica o
razziale, ha meno probabilità di trovare un donatore
compatibile. La questione si porrà anche per i trapianti
di staminali, perché queste cellule possiedono l’aplotipo
dell’individuo da cui derivano; anche se l’importanza
della compatibilità dipenderà verosimilmente
dal tessuto trapiantato, ci saranno almeno alcune applicazioni
terapeutiche importanti in cui la compatibilità
sarà essenziale per il successo clinico. Con ogni
probabilità, quindi, le disparità che oggi sussistono nel
campo dei trapianti sono destinate a ripresentarsi nella
pratica del trapianto di staminali, a meno che non
vengano prese specifiche contromisure.
Si è discusso altrove, vedi articolo a pagina 80, se
le linee di staminali oggi esistenti siano adatte ai trapianti
nell’uomo. Ma anche nell’ipotesi che fossero
idonee all’uso umano, le linee esistenti sono drammaticamente
poche dal punto di vista della compatibilità
HLA. La situazione è particolarmente critica negli
Stati Uniti. Al momento non è disponibile pubblicamente
alcuna informazione sui tipi HLA delle linee di
staminali embrionali su cui si possono condurre ricerche
con fondi federali. In ogni caso, visto che le linee
approvate sono pochissime (al 14 ottobre 2003, appena
12) e per di più sono ricavate da embrioni creati
per fecondazione in vitro a scopo riproduttivo, la varietà
dei tipi HLA è probabilmente molto limitata.
Nell’immediato la scarsa varietà di aplotipi delle linee
disponibili può essere un serio ostacolo all’efficienza e
al successo delle prime sperimentazioni cliniche umane.
In ogni caso guardando ai futuri usi terapeutici, si
profilano due grosse preoccupazioni: per prima cosa,
molti malati non troveranno una linea compatibile e
dovranno affrontare regimi immunosoppressivi più
pesanti, con minori probabilità di successo; in secondo
luogo, alcuni gruppi rischiano di essere sistematicamente
svantaggiati se la linea di ascendenza o il
gruppo etnico cui appartengono non erano ben rappresentati
nel materiale biologico da cui si sono ricavate
le staminali, perché in tal caso è meno probabile
che i loro aplotipi siano inclusi nelle linee di cellule ad
uso terapeutico.
Le scelte normative
Raccomandiamo con forza che tutte e quattro le strategie
per affrontare il rigetto siano perseguite attivamente.
Anche se l’induzione della tolleranza è ancora
in una fase preliminare di applicazione clinica, i progressi
sono molto promettenti non solo per le terapie
con staminali ma per i trapianti in generale. La prosecuzione
delle ricerche sull’immunosoppressione potrà
portare a farmaci di nuova generazione con effetti collaterali
ridotti. La possibilità di creare cellule staminali
universali va senz’altro esplorata, anche se gli ostacoli
scientifici restano immensi. Nel breve termine tuttavia
la compatibilità HLA, accompagnata al bisogno dall’immunosoppressione,
resta lo strumento principe per
evitare il rigetto.
Il nodo della compatibilità nei trapianti solleva serie
questioni di scelte normative e di giustizia. Nel contesto
statunitense si sono fatti molti tentativi di affrontarne
una: la relativa rarità di donatori compatibili per
gli afroamericani. Le risposte si sono limitate di solito
agli appelli alla donazione rivolti alla comunità afroamericana
e alle strategie per accrescere il numero complessivo
di donazioni. Nel caso delle terapie con staminali,
però, nulla impone che la disponibilità di tipi
HLA sia soggetta alla stessa aleatorietà che caratterizza
la donazione d’organi. Al momento non si possono
produrre organi solidi o tessuti da trapiantare, ma è
possibile creare le linee di staminali da utilizzare per la
ricerca e, in futuro, per le terapie. È dunque possibile
costituire una banca di linee di staminali che includa un
ampio spettro di tipi HLA, specificamente selezionati
per rispondere a considerazioni di equità sociale.
Molti paesi hanno una notevole esperienza nella creazione
e nella gestione di banche di materiali biologici
di uso terapeutico, quali il sangue, lo sperma, le cornee
e il sangue del cordone ombelicale. Esistono inoltre sistemi
di raccolta e distribuzione degli organi solidi e
del midollo osseo. La maggior parte di queste banche
e di questi sistemi è organizzata e finanziata dai governi
o da qualche forma di partnership pubblico-privato.
Indipendentemente dalla loro struttura queste raccolte
di tessuti e di organi, se si eccettuano alcune banche
private dello sperma e del sangue ombelicale, sono
considerate risorse pubbliche. Certo, ci sono numerosi
ostacoli etici e politici alla creazione di una banca
pubblica di cellule staminali. Specie negli Stati Uniti, è
arduo che nel clima attuale possa esserci un qualsiasi
coinvolgimento del governo nell’istituzione, nel finanziamento
o nella supervisione della banca. In primo
luogo, comunque, bisogna concentrarsi sul problema
di come, in una prospettiva di giustizia, le banche di
cellule staminali andrebbero strutturate.
Progettare una banca terapeutica
Vediamo ora di quali elementi bisogna tener conto nell’allestire
una banca a fini terapeutici, per poi esaminare
che cosa cambia se la collezione di linee è costruita
a scopo di ricerca. Ciò che emerge è che per i due casi
sono preferibili strutture distinte.
Idealmente una banca di cellule staminali dovrebbe
includere una tale varietà di linee da permettere a
qualsiasi potenziale ricevente di ottenere un tessuto
compatibile. Una simile banca però richiederebbe la
creazione e il mantenimento di una collezione di dimensioni
spropositate. Come si è osservato, anche con
un registro di oltre quattro milioni di donatori, lo US
Bone Marrow Donor Program offre tessuti compatibili
solo al 50-60% di coloro che ne hanno bisogno. Il
Bone Marrow Donor Program è un registro, che consente
di ricercare le informazioni sui potenziali donatori.
Visti i lunghi tempi necessari ad allestire una linea
di staminali, difficilmente un sistema analogo sarebbe
adatto per i trapianti di staminali. La soluzione che proponiamo
è invece una banca che mantenga e conservi
le linee cellulari e distribuisca al bisogno i campioni ai
centri clinici. Si può però ritenere che l’allestimento di
una banca con centinaia di migliaia o milioni di linee
sia improponibile, se non altro per gli enormi costi che
comporterebbe.
Il solo progetto che ci appare praticabile è dunque
quello di una banca in cui le linee di staminali sono progettate
in modo da essere omozigoti per gli alleli più
importanti per i trapianti. Di norma per stabilire la
compatibilità si mettono a confronto fra il donatore e
il ricevente sei alleli: due ciascuno per i geni HLA-A, B
e DR. Una persona o una linea cellulare omozigoti, però,
esprimono solo un allele per ciascuno dei tre geni.
Una banca di linee omozigoti quindi offrirebbe
cellule compatibili a un numero di pazienti molto maggiore,
perché solo tre degli alleli del paziente dovrebbero
coincidere con quelli del donatore, anziché sei.
Costruire una banca di linee omozigoti non sarà
facile, non solo per le tante difficoltà etiche e politiche
che si discuteranno più avanti. La probabilità di
trovare embrioni sovrannumerari omozigoti nelle cliniche
per la riproduzione assistita è, nel migliore dei
casi, scarsa. Una strategia più promettente ma più
controversa è la costruzione della banca a partire dai
gameti donati. Gli embrioni potrebbero essere creati
usando i gameti di due donatori che hanno un aplotipo
in comune; circa uno su quattro degli embrioni così
prodotti sarebbe omozigote per i tre alleli HLA. In
alternativa, se divenisse tecnicamente fattibile, la tecnica
del trasferimento di nucleo permetterebbe di produrre
le linee di staminali desiderate a partire da adulti
omozigoti per l’aplotipo richiesto. Questa tecnica
tuttavia è ancor più controversa, sia moralmente sia
politicamente, rispetto alla creazione di embrioni per
via convenzionale. In futuro si potrebbe anche arrivare
a creare le linee desiderate da particolari cellule degli
adulti omozigoti o dal sangue ombelicale di neonati
omozigoti, ma al momento nulla assicura che le
staminali provenienti da queste fonti si dimostreranno
abbastanza potenti da rimpiazzare del tutto quelle
embrionali. Nonostante gli enormi ostacoli, che saranno
discussi più avanti, a nostro parere la creazione
di una banca pubblica di cellule staminali è tecnicamente
fattibile. Nonostante la maggiore efficienza, e
dunque la preferibilità, di una banca di linee omozigoti,
il numero di linee necessario per fornire tessuti
compatibili a tutti i potenziali pazienti resterebbe
proibitivo. Individuare e procurarsi gameti maschili e
femminili che condividono uno stesso aplotipo, creare
da questi gli embrioni (solo uno su quattro dei quali
sarebbe omozigote), ricavare le staminali dall’embrione
selezionato e allestire una linea cellulare è
un’operazione difficile. Per di più alcune linee omozigoti
sono pressoché impossibili da ottenere, perché
alcuni aplotipi sono così rari che è oltremodo difficile
trovare i gameti o le fonti adulte necessari. Con questi
limiti, a nostro parere, la sola strategia ragionevole
è quella di creare una banca di dimensioni limitate,
che contenga linee omozigoti scelte perché esprimono
le combinazioni desiderate di alleli HLA.
La sfida etica centrale in questa proposta è di stabilire
quali combinazioni di aplotipi includere nella limitata
banca di linee omozigoti preparate a scopo terapeutico.
Il primo passo per compiere la scelta è di
esaminare le diverse opzioni. A nostro giudizio per selezionare
le linee da includere una banca siffatta le strategie
principali sono tre, ciascuna improntata a considerazioni
di giustizia differenti. Un orientamento che
mira tout court alla massima copertura punterà a includere
le linee che offrono la compatibilità al maggior
numero di pazienti. Un orientamento egualitario offrirà
a tutti gli individui che è materialmente possibile includere
nella banca la stessa probabilità di trovarvi rappresentato
il proprio aplotipo. La strategia che definiamo
di rappresentazione etnica presceglierà gli aplotipi
più comuni in ciascun gruppo etnico o di ascendenza,
così da dare ai membri di ogni gruppo le stesse probabilità
di trovare nella banca una linea compatibile.
Saranno ora passate in rassegna le tre strategie, per
giungere alla conclusione che, a nostro parere, la più
sostenibile è l’ultima.
Massima copertura
La prima strategia punta a includere quelle linee omozigoti
che permetterebbero alla massima percentuale
possibile della popolazione di trovare nella banca una
linea compatibile. Tale strategia riconosce che non tutte
le linee si equivalgono quanto al numero dei possibili
beneficiari. Alcuni aplotipi sono molto più comuni
di altri e una banca di dimensioni contenute può soddisfare
più persone se include le linee cellulari che possiedono
gli aplotipi più diffusi. L’evidente attrattiva di
tale strategia è che permette di offrire terapie con cellule
staminali compatibili al numero più ampio di potenziali
pazienti.
Un simile orientamento soffre però di due seri inconvenienti.
Innanzitutto sottrae ai portatori degli
aplotipi meno comuni qualsiasi possibilità di beneficiare
della banca, una scelta della cui equità è ragionevole
dubitare. Per di più una banca delle linee cellulari
con gli aplotipi più comuni negli Stati Uniti favorirebbe
statisticamente gli statunitensi bianchi, per il semplice
fatto che questo è il gruppo più numeroso nel
paese. Alcuni degli aplotipi più frequenti fra i bianchi
sono i più diffusi anche in altri gruppi etnici, ma fra le
varie etnie ci sono differenze notevoli (le coincidenze
e le differenze fra cinque gruppi etnici o di ascendenza
statunitensi sono illustrate nella tabella a fianco). Per
esempio l’aplotipo HLA-A/B più comune fra gli statunitensi
bianchi, A 0101 B 0801, è fra i dieci più comuni
anche per gli afroamericani, per gli ispanici e per i
nativi americani; non è però fra i 25 più comuni per gli
statunitensi di origine asiatica. Inoltre gli aplotipi presentati
in tabella sono solo quelli per HLA A e B; se si
considera anche HLA-DR, le coincidenze diminuiscono
ulteriormente.
Dato che negli Stati Uniti i bianchi sono più numerosi
degli altri gruppi, l’inclusione di un aplotipo
presente in una percentuale relativamente piccola di
bianchi potrebbe estendere la copertura a un numero
di persone maggiore che l’inclusione dell’aplotipo più
comune in un altro gruppo. Per questo, se una banca
raccogliesse le linee omozigoti per i 50 aplotipi più comuni
negli Stati Uniti, all’atto pratico si avrebbe una
collezione composta in prevalenza dagli aplotipi comuni
fra i bianchi. Con queste strategia il numero di
potenziali pazienti compatibili sarebbe più alto che
con qualsiasi altra, ma i beneficiari sarebbero concentrati
nel gruppo di origine caucasica; si inasprirebbero
così le disparità sanitarie che oggi sussistono fra i diversi
gruppi etnici statunitensi, figlie di antiche storie
di oppressione e di ingiustizia sociale.
Pari opportunità
Una risposta alle preoccupazioni di equità verso chi
possiede gli aplotipi meno comuni potrebbe essere di
dare a tutti gli aplotipi che si possono materialmente
includere in una banca, e quindi a tutti gli individui che
li possiedono, la stessa opportunità di essere rappresentati.
Nella pratica, è impossibile creare linee di staminali
omozigoti per aplotipi che eccedono una certa
soglia di rarità. Si potrebbero però includere in una
banca molti aplotipi di rarità intermedia. La strategia
delle pari opportunità mira a promuovere l’equità dando
a tutti coloro i cui aplotipi possono concretamente
essere rappresentati nella banca la stessa probabilità di
accesso biologico alle terapie.
A questo scopo, la scelta degli aplotipi da rappresentare
potrebbe essere affidata al caso, per esempio
mediante un’estrazione a sorte fra tutti quelli candidati.
Offrire al maggior numero possibile di individui le
stesse opportunità di beneficiare della banca può rispondere
ad alcuni criteri intuitivi di equità, ma una simile
strategia comporterebbe due concreti inconvenienti.
Per prima cosa, la strategia non è concepita per
affrontare il problema dell’accesso ineguale da parte
dei diversi gruppi etnici o di ascendenza. L’esito concreto
potrebbe essere quello di alleviare le iniquità o
quello di inasprirle, a seconda dei risultati della lotteria,
ma in ogni caso si tratterebbe di un risultato dovuto
alla sorte e non a una programmazione deliberata
e le disparità fra i gruppi potrebbero acuirsi ancora
di più che con il principio della massima copertura. Si
può sostenere che le iniquità etniche risultanti dal caso
sarebbero più accettabili di quelle dovute alla ricerca
della massima copertura, perché il processo che le
genera è equo. Nondimeno, chi pensa che a prescindere
da tutto ci siano forti ragioni morali per non arrecare
ulteriori svantaggi ai gruppi storicamente oppressi,
non sarà soddisfatto da un processo rischia di
avere proprio questo.

Inoltre, mentre una lotteria potrebbe per caso selezionare
lo stesso insieme di aplotipi previsto dalla
strategia della massima copertura, se si adotta il principio
delle pari opportunità è per rendere possibili anche
esiti diversi, inclusa una collezione composta in tutto o
in parte da aplotipi relativamente rari. In tal caso, com’è
ovvio, solo un piccolo numero di persone potrebbe
beneficiarne. Il nodo si fa più spinoso se si considera
quali aplotipi si potrebbero ragionevolmente escludere
dalla lotteria per la loro rarità. Va escluso ogni
aplotipo la cui rarità rende letteralmente impossibile
trovare i donatori dei gameti necessari a crearlo. Se si
escludono anche gli aplotipi per i quali trovare i donatori
non è impossibile, ma solo molto difficile e costoso,
la scelta sarà dovuta alla valutazione che i costi dell’inclusione
sono superiori ai benefici. Ma escludere alcuni
aplotipi dalla lotteria su questa base è incoerente
con le ragioni di fondo che giustificano la strategia delle
pari opportunità.
Tale giustificazione si basa su due asserzioni: primo,
che i tentativi di beneficiare il maggior numero
possibile di pazienti vanno temperati dalle esigenze di
giustizia e, secondo, che la giustizia impone di offrire
a chi possiede aplotipi poco comuni le stesse opportunità
di beneficiare della banca. Se queste assunzioni sono
corrette, il fatto che la strategia delle pari opportunità
offra benefici a un minor numero di pazienti rispetto
alla massima copertura non vuol dire che non
debba essere adottata. Analogamente, tuttavia, se un
aplotipo è così raro che la creazione della relativa linea
omozigote rischia di assorbire gran parte delle risorse
della banca, ciò non dimostra che tale aplotipo vada
escluso. Ma se la lotteria deve includere tutti questi
aplotipi, il numero di aplotipi poco comuni rischierà di
essere maggiore del previsto e crescerà di pari passo la
probabilità che la banca risulti utile solo a pochi.
Non riteniamo che le esigenze di giustizia richiedano
l’adozione della strategia delle pari opportunità.
Se si progetta una banca per garantire la massima copertura,
non si privano i portatori di aplotipi rari di un
beneficio a cui a priori hanno titolo né si chiede loro di
fare sacrifici da cui non possono attendersi di trarre
vantaggio. Ci si trova, piuttosto, in una situazione in
cui bisogna decidere come allocare al meglio risorse
scarse. In altre situazioni del genere non c’è la percezione
che la sola maniera equa di prendere decisioni sia
di ricorrere al caso. Per esempio chi destina altre risorse
sanitarie scarse, quali i posti letto in terapia intensiva
o gli organi per i trapianti, non si affida a una lotteria
per decidere, e in genere queste pratiche non sono
percepite come inique. A seconda delle circostanze le
scelte tengono conto di fattori come le esigenze mediche
o la prognosi, anche se ciò significa che chi versa
in condizioni meno gravi o chi ha meno speranze di sopravvivere
non gode di un’eguale opportunità di aggiudicarsi
la risorsa. Se non c’è motivo di ritenere che
la scelta delle linee di staminali da includere in una banca
sia di natura diversa rispetto alle altre decisioni sull’allocazione
di risorse scarse cui nessuno ha titolo a
priori, bisogna concludere che l’equità non richiede l’adozione
della strategia delle pari opportunità.
Un’altra ragione per rifiutare tale strategia è che,
almeno a giudizio di alcuni, la giustificazione primaria
per investire nella ricerca sulle staminali e creare una
banca pubblica è il progresso generale del benessere
umano. Da questo punto di vista un processo di creazione
della banca destinato a dare scarsi benefici sarebbe
controproducente. Qualunque opinione si abbia
sull’equità dell’offerta di pari opportunità, non va perso
di vista che in questo caso si sta ricercando l’equità
nell’ambito di un miglioramento del benessere sociale.
Se i benefici sono troppo modesti, la presunta equità
ha un prezzo troppo alto.
Rappresentazione etnica
Anche se non tutti gli autori del presente articolo concordano
su questo punto, la maggioranza ritiene che la
scelta preferibile sia di selezionare gli aplotipi più comuni
in ciascuno dei gruppi etnici o di ascendenza degli
Stati Uniti, per far sì che la banca sia utile a una medesima
percentuale dei membri di ciascun raggruppamento.
Tale strategia è meno efficiente di quella della
massima copertura perché richiede più linee cellulari
per soddisfare lo stesso numero complessivo di pazienti.
Ciò accade per due ragioni. Per prima cosa, la
strategia della rappresentazione etnica parte dall’assunto
che si debba estendere la copertura alla stessa
proporzione di ciascun gruppo etnico, anche se una
data percentuale di un gruppo poco numeroso include
meno persone della stessa percentuale di un gruppo più
ampio. In secondo luogo, per coprire una stessa percentuale
di gruppi differenti occorre un numero diverso
di linee cellulari, perché in alcuni gruppi c’è una
maggiore variabilità di tipi HLA che in altri. Per esempio,
se si considerano HLA-A, B e DR e si vuole ottenere
una copertura di circa il 50% degli statunitensi
bianchi e del 50% di tutti gli afroamericani, occorrono
dalle 60 alle 80 linee cellulari. Venti linee omozigoti
bastano a coprire il 48,6% dei bianchi, ma solo il
28,7% degli afroamericani. Per coprire circa il 50% di
ciascun gruppo, occorrono da 20 a 30 linee per i bianchi
e da 40 a 50 per gli afroamericani.
Se oltre ad A e B si tiene conto anche degli alleli
DR la probabilità di trovare una linea compatibile si riduce
e il numero di linee necessarie a coprire una data
percentuale di una popolazione cresce. In alcuni casi,
a seconda del tessuto trapiantato e della probabilità di
un buon esito clinico, può essere ragionevole limitarsi
a considerare A e B. In tale ipotesi, per coprire il 30%
di ciascuno dei cinque gruppi illustrati nella tabella occorrerebbe
allestire circa 23 linee per gli afroamericani,
12 per i bianchi, 24 per gli ispanici, 14 per i nativi
americani e 12 per gli asiatici, per un totale di 85 linee
cellulari (in realtà un po’ meno, visto che alcuni aplotipi
sono comuni a più gruppi etnici). Se invece si includessero
gli 85 aplotipi più frequenti nel complesso della
popolazione statunitense, a prescindere dalle etnie,
la maggior parte dei potenziali fruitori sarebbe costituita
da bianchi.
Seguendo la proposta appena illustrata, avrebbe
accesso alle terapie con staminali un numero di pazienti
minore di quello che si avrebbe secondo altri criteri.
Non proponiamo con leggerezza un criterio di
progettazione della banca che restringa il numero di
pazienti in grado di fruirne. Nondimeno riteniamo che
la strategia della rappresentazione etnica sia quella da
adottare. Negli Stati Uniti i gruppi etnici e di ascendenza
non bianchi sono le sole categorie di persone
che condividono due aspetti: sarebbero sistematicamente
sottorappresentati in una banca che mirasse alla
massima copertura e hanno alle spalle una storia di
discriminazioni sociali. La strategia della massima copertura
riprodurrebbe queste discriminazioni e ne
acuirebbe gli effetti, il che, a nostro parere, depone
contro la sua adozione. Per di più, offrendo una equa
rappresentazione etnica si può prevenire il notevole
danno che scaturirebbe da una rappresentazione ineguale.
Nondimeno, se una banca rendesse disponibili i
benefici della terapia quasi esclusivamente ai bianchi, i
membri delle minoranze potrebbero a buon diritto dubitare
che i loro interessi siano stati tenuti nella debita
considerazione da chi ha deciso quali linee includere.
Vista la storia delle relazioni razziali negli Stati Uniti,
e del trattamento riservato agli americani non bianchi
dalla comunità medica, questa preoccupazione non
può essere liquidata come irragionevole.
Il bisogno di evitare che alcuni possano ragionevolmente
dubitare di essere considerati cittadini a pieno
titolo ed eguali i cui interessi sono tutelati a dovere,
specialmente quando tali preoccupazioni sono state
spesso ben fondate in passato, è un’ulteriore motivo per
rifiutare la strategia della massima copertura. Anche se
il principio della rappresentazione etnica non è il più
efficiente, assicura il massimo beneficio compatibile
con il rispetto per l’eguaglianza fondamentale dei
membri di almeno i principali gruppi etnici e di ascendenza
degli Stati Uniti. Vista la storia di oppressione di
svariate minoranze del paese e la perdurante fragilità
delle relazioni interetniche, una politica che permette
un ulteriore beneficio per i bianchi rispetto agli altri
gruppi segnalerebbe l’incapacità di riconoscere la pari
dignità ai membri di tutti i gruppi.
Una banca per la ricerca clinica
Passiamo ora a considerare come costruire una banca a
scopo di ricerca. Gli scopi della ricerca clinica sono diversi
da quelli della medicina clinica e così le considerazioni
morali di cui tenere conto. È interesse di tutti
che la ricerca dia risultati con la massima efficienza
possibile e quindi che i ricercatori trovino con facilità
e rapidità soggetti umani idonei alle sperimentazioni.
Nelle situazioni in cui la compatibilità HLA è ritenuta
importante, sarà molto più facile trovare soggetti di ricerca
idonei se la linea di staminali con cui si è realizzata
la terapia possiede un aplotipo diffuso. Pertanto in
una banca di ricerca, a differenza di una terapeutica, le
ragioni a sostegno della strategia delle pari opportunità
non hanno alcuna rilevanza. Anche le ragioni a favore
della rappresentazione etnica possono apparire
meno persuasive, dato che l’obiettivo primario è di accertare
in fretta se un dato trattamento sperimentale è
davvero sicuro ed efficace e se quindi sia opportuno
renderlo disponibile a tutti.

Conveniamo che una banca di ricerca vada progettata
per soddisfare le esigenze dell’impresa scientifica e che
quindi debba essere composta in prevalenza da linee di
staminali omozigoti per gli aplotipi più comuni nella
popolazione statunitense. C’è però una forte motivazione
per includere almeno un certo numero di linee
con gli aplotipi diffusi in particolari gruppi etnici o di
ascendenza. Senza tali linee c’è il rischio che i ricercatori
abbiano meno possibilità di portare avanti gli studi
su malattie che colpiscono in misura molto maggiore
particolari gruppi etnici o che in questi si presentano
in forma diversa. Se ciò accadesse, non tutti potrebbero
beneficiare in modo equo degli investimenti
della società nella ricerca sulle staminali. Posto che ci
siano buone ragioni per contenere il numero di linee in
una banca di ricerca a un livello minimo, una banca di
linee omozigoti potrebbe funzionare con efficacia con
appena 14 linee: i sei aplotipi più comuni nella popolazione,
compatibili con circa il 25% degli statunitensi
(per lo più bianchi), e i due aplotipi più comuni in
ciascuno degli altri quattro gruppi, compatibili con il
5-10% della popolazione di ciascun gruppo.
Giustizia globale
In questo articolo ci si è concentrati sulle banche per la
ricerca e la terapia negli Stati Uniti e l’analisi di come
realizzare tali strutture in modo equo è specifica per il
contesto statunitense. Per le banche di staminali progettate
in altri paesi o a livello multinazionale le considerazioni
di giustizia possono essere differenti e possono
dunque essere necessarie collezioni di aplotipi
costruite secondo criteri diversi.
Una preoccupazione particolarmente importante
dal punto di vista dell’equità è come aiutare la popolazione
di tutto il mondo man mano che la medicina basata
sulle staminali progredisce. Gli studi di genetica
delle popolazioni indicano che fra chi vive in regioni
diverse è probabile incontrare frequenze degli alleli
HLA significativamente divergenti, sia fra una popolazione
e l’altra sia rispetto agli statunitensi, il che rischia
di complicare gli sforzi per produrre terapie di ampia
disponibilità su scala globale. Per esempio, le popolazioni
dell’Africa subsahariana presentano il massimo
grado di diversità genetica al mondo e questa varietà
non è ben rappresentata nei gruppi di altre regioni del
globo. Per i paesi del Sud del mondo, i cui bilanci per
la sanità e la ricerca sono già molto ristretti, entrerebbero
chiaramente in gioco anche considerazioni economiche,
ma anche questo tema merita un’analisi a parte
ed esula dagli scopi della presente analisi. La nostra
ipotesi è che i paesi relativamente benestanti svilupperanno
terapie basate sulle staminali e che queste saranno
infine rese disponibili agli abitanti dei paesi più poveri.
Per ottenere l’accessibilità biologica su scala mondiale
sarà necessario un impegno concertato fra i paesi
sviluppati in cui le terapie vengono messe a punto,
così che la diversità genetica sia considerata in termini
abbastanza ampi da soddisfare anche le necessità dei
malati nei paesi poveri.
Sfide politiche e morali
Per creare banche di cellule staminali secondo i criteri
esposti bisognerà superare notevoli ostacoli.
Supponendo che per il momento le linee dovranno essere
ricavate da embrioni, la prima sfida sarà procurarsi
i gameti. Occorrerà tipizzare l’HLA di molte persone
per individuare i donatori che possiedono l’aplotipo
desiderato. Le donatrici dovranno sottoporsi alla
procedura dell’iperstimolazione ovarica e della raccolta
degli ovociti, un processo gravato da rischi e disagi
non irrilevanti. L’accettabilità di tali rischi può essere
in parte valutata dal confronto con i rischi e i disagi cui
vanno incontro i donatori di midollo osseo, di rene o
di fegato. Al pari di questi ultimi, i donatori di gameti
non dovrebbero essere pagati, ponendo così una netta
distinzione fra le banche e le pratiche dei programmi
per l’infertilità.
Il peso della realizzazione di un sistema equo di
accesso alle terapie ricadrà sulle donne molto più che
sugli uomini, per i quali la donazione di gameti è al
confronto un impegno irrisorio. Non è detto che le
donne siano disponibili a donare gli ovociti in assenza
di un compenso economico, anche se quanto accade
con la donazione di midollo osseo, di rene e di fegato
fa pensare che ci siano molte persone disposte a
sottoporsi a procedure mediche gravose per il bene di
altre. Può anche darsi che si arrivi a mettere a punto
procedure di laboratorio per indurre le staminali embrionali
umane a differenziarsi in ovociti, eliminando
la necessità delle donazioni da parte delle singole donne;
questa tecnologia però non è ancora pienamente a
punto e non si può quindi farvi affidamento.
Una difficoltà legata a quanto appena detto sarà
quella di procurarsi un numero sufficiente di gameti
da esponenti delle minoranze e in particolare dagli
afroamericani. Lo scopo primo della strategia di rappresentazione
etnica è di garantire che le minoranze
non siano sistematicamente svantaggiate nell’accesso
alle terapie sanitarie. Allo stesso tempo, però, nella
comunità afroamericana vige un clima di sfiducia dell’establishment
medico e scientifico che si manifesta
in vari modi, inclusa la riluttanza a dare il consenso alla
donazione di organi e a partecipare alla ricerca medica.
La mancata partecipazione degli afroamericani
e degli altri gruppi minoritari renderebbe impossibile
allestire una banca secondo i criteri descritti ed è
quindi essenziale assicurarsi la loro fiducia e il loro
coinvolgimento.
L’ostacolo più evidente e più arduo alla creazione
di banche di staminali negli Stati Uniti è la diffusa
controversia sullo status morale della vita umana nei
suoi primissimi stadi. Senza dubbio una porzione
consistente della popolazione si opporrà alla creazione
delle banche, per il solo fatto che ciò comporta la
creazione e la distruzione degli embrioni. L’entità delle
controversie che accompagnano la materia può
rendere difficile per i politici o per le istituzioni governative
sostenere l’idea di una banca di staminali
costruita secondo il modello descritto. Perlomeno nel
breve termine, per creare la collezione desiderata di
linee cellulari omozigoti bisognerà ricavare tali linee
da nuovi embrioni. Lo sviluppo di un equo sistema
d’accesso ai benefici delle terapie con staminali sembra
dunque richiedere la creazione strumentale e la
distruzione di vite embrionali. Sul piano morale ci
sembra quindi preferibile rinviare la creazione della
banca terapeutica, fin quando dalle sperimentazioni
cliniche non giungeranno le prime prove convincenti
che le terapie in questione funzionano. Nel frattempo
bisognerà esaminare i progressi realizzati con
le fonti non embrionali di staminali e con l’immunosoppressione
e l’induzione della tolleranza. Se una di
queste strade avrà dato risultati significativi nel momento
in cui le terapie con le staminali saranno vicine
all’impiego clinico, la creazione di una banca terapeutica
mediante la distruzione di embrioni potrebbe
non essere più necessaria.
Allo stesso tempo, tuttavia, è essenziale allestire
una banca di staminali a scopo di ricerca, per procedere
in modo equo e sicuro alle ricerche cliniche sull’uomo.
Diversi filoni di ricerca sulle staminali si stanno
avvicinando alla prima sperimentazione umana. Si
è discusso in altra sede – vedi articolo successivo –
perché le linee di staminali oggi approvate per le ricerche
con fondi federali non siano adatte all’uso negli
esseri umani. A meno che non si accerti molto a
breve che si possono creare valide linee di staminali a
partire da tessuti adulti, è verosimile che la transizione
dalla ricerca di laboratorio a quella clinica richieda
la distruzione di ulteriori embrioni umani. Una banca
di ricerca costruita in modo da includere linee omozigoti
per gli aplotipi comuni può essere uno strumento
per ridurre al minimo il dispendio di embrioni; 14 linee
potrebbero già fornire una base abbastanza ampia
per la ricerca clinica, incluse le applicazioni di particolare
interesse per le minoranze.
Un’altra sfida sarà di identificare una struttura
che permetta alla banca di ricerca di funzionare come
un bene pubblico, onorando così il suo scopo sociale.
Una complicata rete di diritti e brevetti ha reso
molto difficile per i ricercatori avvalersi con efficacia
delle linee di staminali esistenti. Non è chiaro se sia
possibile costruire una banca di ricerca che eviti questo
pantano, specie se la banca non è istituita o regolamentata
dal governo federale. Dato che un intervento
del governo in tal senso è improbabile, i fondi
dovrebbero arrivare dai privati e un sostegno filantropico
potrebbe garantire, più di un consorzio di interessi
commerciali, che la banca operi davvero come
un bene pubblico. Può darsi che nel momento in cui
si renderà necessaria una banca terapeutica sarà possibile
costruirla con l’appoggio del governo; i valori
del pubblico potranno cambiare, per esempio, se le linee
di staminali embrionali dimostreranno la loro utilità
clinica. In alternativa, tessuti non embrionali potrebbero
rivelarsi una fonte affidabile di staminali,
permettendo di costruire banche terapeutiche senza
ricorrere agli embrioni.
Anche se i progressi nella ricerca sulle fonti adulte
sono incoraggianti, sembra improbabile che la soluzione
ai dilemmi morali e di public policy qui illustrati
possa arrivare da nuove soluzioni tecniche. Con
ogni probabilità, il valore terapeutico delle staminali
sarà provato prima che si sia dimostrata la praticabilità
di fonti alternative agli embrioni. Ci sembra altresì
che, anche se sosteniamo con forza la prosecuzione
delle ricerche sulle terapie immunosoppressive e sull’induzione
della tolleranza e confidiamo nei progressi
del settore, difficilmente questi sviluppi metteranno
in discussione i vantaggi clinici della compatibilità
HLA. Pertanto la società si troverà a dover scegliere se
ritiene più importante garantire che tutti beneficino
con equità dei progressi nel campo delle staminali o
proteggere la vita degli embrioni. Se si opterà per la
creazione di una banca terapeutica, bisognerà fare
ogni sforzo per coordinare l’iniziativa con quelle analoghe
in corso in altri paesi, così da ridurre al minimo
il numero di embrioni distrutti. Il Regno Unito ha annunciato
di aver già intrapreso la creazione di una propria
banca di staminali. Nel momento in cui scriviamo
non sappiamo se il progetto sarà improntato a considerazioni
di equità né quale distribuzione di tipi HLA
sarà rappresentata o se sia possibile una compatibilità
immunologica con una certa quota della popolazione
statunitense.
Le politiche di ricerca scientifica attuali e future
dovranno essere sensibili ai problemi di equo accesso
biologico qui delineate. Le linee di staminali embrionali
esistenti su cui negli Stati Uniti si può fare ricerca
con fondi federali non saranno sufficienti a questo
scopo. Le restrizioni federali alla ricerca dovranno
quindi essere riesaminate, insieme con le scelte normative
riguardanti le priorità dei finanziamenti, le
protezioni brevettuali e gli incentivi alla comunità
scientifica, per garantire che le questioni di giustizia
siano affrontate in modo adeguato man mano che la
ricerca procede. Anche se si tratterà di un processo
controverso, le esigenze di equità andranno bilanciate
con il rispetto per la vita umana nascente. Un accorto
dibattito fra gli scienziati, i responsabili delle
scelte politiche e il pubblico su temi così complessi
aiuterà a garantire che le nuove terapie siano sviluppate
in modo equo e responsabile.