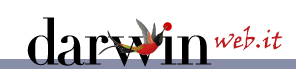a ricerca sulle cellule staminali embrionali sta vivendo una
transizione cruciale. Un tempo pertinenza esclusiva della ricerca
di base, le staminali sono ora oggetto d’indagine per le loro
possibili applicazioni cliniche in una gamma di condizioni che, per fare
solo qualche esempio, spazia dall’ictus alla malattia di Alzheimer, dal
morbo di Parkinson alla sclerosi laterale amiotrofica e alle lesioni spinali.
I ricercatori subiscono forti pressioni dalle associazioni di pazienti
perché approntino il più in fretta possibile terapie efficaci, ma devono
anche sottostare all’imperativo morale di non iniziare le sperimentazioni
sull’uomo finché i rischi che queste comportano non saranno
chiariti negli studi preclinici, di laboratorio e sugli animali. Per quanto
riguarda la sicurezza delle staminali embrionali, la Food and Drug
Administration (Fda) statunitense e gli altri organi che sovrintendono
alle ricerche sull’uomo dovranno affrontare due ordini di incertezze:
quali linee cellulari siano le più indicate per le sperimentazioni umane
e come si comporteranno le staminali una volta trapiantate nel ricevente.
Il numero di linee di staminali embrionali esistenti è limitato. Ce
n’è qualcuna con le caratteristiche adatte per essere usata nella preparazione
di interventi sperimentali, e se sì, quale? Abbiamo individuato
tre questioni di sicurezza di cui tener conto nella scelta: i rischi di infezione,
i rischi genetici e il controllo di qualità. Qualsiasi trapianto
d’organo o di tessuto comporta il rischio di trasmettere un’infezione dal
donatore al ricevente; i trattamenti sperimentali con cellule staminali
embrionali, che con ogni probabilità prevederanno il trapianto nei malati
di cellule derivate dalle staminali, non fanno eccezione. Sarà quindi
essenziale uno screening dei tessuti trapiantati per proteggere il ricevente
da agenti infettivi.
In aggiunta a questo rischio di base, nel caso dei tessuti ricavati
dalle staminali embrionali ce n’è però un altro. La maggior parte delle
linee di staminali embrionali oggi esistenti sono state coltivate insieme
a cellule di topo, i fibroblasti fetali, che secernono alcune sostanze
essenziali per le staminali umane. Ne discende il rischio che, se
le staminali in questione o i loro prodotti fossero introdotti nell’uomo,
un’infezione presente nelle cellule murine potrebbe ipoteticamente
trasmettersi alla specie umana. Di recente si è trovato il modo di rimpiazzare
le cellule di topo con cellule umane
(nota 3). Negli Stati Uniti però,
secondo le norme federali vigenti, le sole linee di staminali embrionali
su cui si può fare ricerca con fondi federali sono quelle che sono state
coltivate insieme a cellule di topo
(nota 2); difatti la Food
and Drug Administration ha stabilito che l’impiego
delle staminali deve sottostare al quadro normativo
che disciplina gli xenotrapianti
(nota 3). Le conseguenze di
questa linea politica per gli statunitensi sono sconcertanti:
o la ricerca clinica sulle staminali embrionali
andrà condotta senza fondi federali, oppure i ricercatori
si vedranno costretti ad adoperare linee che
comportano rischi maggiori di quelle usate nel resto
del mondo e negli studi che non impiegano sovvenzioni
federali.<

Al nocciolo della questione c’è un conflitto fra il
dovere di ridurre al minimo i pericoli e il dovere di
proteggere la vita embrionale. Per chi trova accettabile
distruggere gli embrioni per fare progredire la ricerca
biomedica, nulla giustifica l’esposizione di esseri
umani al rischio di infezioni da altre specie, per
quanto piccolo possa essere. Chi al contrario attribuisce
grande valore alla protezione della vita embrionale
difficilmente riterrà il pericolo teorico di infezione
una ragione sufficiente per giustificare la creazione di
nuove linee di staminali embrionali. Anche se il rischio
che una malattia infettiva si trasmetta da una
specie all’altra è con ogni probabilità molto scarso, si
tratta di un azzardo del tutto evitabile.
Per questo riteniamo che non sarebbe etico introdurre
in esseri umani le staminali coltivate in presenza
di cellule di topo. Se questa visione sarà condivisa
ma le norme statunitensi non cambieranno, le prime
sperimentazione umane nel settore non potranno
ricevere fondi federali. Ci sarebbe allora di che preoccuparsi
per due ragioni: in primo luogo, senza finanziamenti
governativi le ricerche procederebbero molto
più a rilento; in secondo luogo, se si delega tutto ai
privati si rischia di limitare la capacità del governo di
vigilare sulle sperimentazioni sull’uomo.
I rischi genetici e il controllo di qualità
Se il trapianto dei materiali biologici ricavati da cellule
staminali comporti per il ricevente un rischio genetico
è difficile da valutare. È presumibile che per
molte malattie genetiche il rischio non si ponga, specie
se il gene alterato non è essenziale per la funzione
del tessuto prodotto; tuttavia, in assenza di sperimentazioni
umane o animali, non lo si può dare per
scontato. Pertanto, sembra prudente verificare almeno
l’assenza delle malattie genetiche che potrebbero
colpire direttamente il tessuto prodotto. Se per esempio
si volesse usare una cellula staminale per creare
isole pancreatiche, bisognerebbe escludere la presenza
nel suo genoma di mutazioni che predispongono
al diabete di tipo 1.
Più in generale, bisognerà fare delle scelte su quali
esami genetici condurre di routine sulle linee di staminali.
Bisognerà inoltre decidere se la presenza di un
difetto genetico, inclusi quelli senza prevedibili conseguenze
sui tessuti prodotti, sia condizione sufficiente
per scartare la cellula. A nostro parere sarà opportuno
raccogliere le anamnesi familiari di tutte le coppie disposte
a cedere gli embrioni sovrannumerari per usi di
ricerca, in particolare riguardo alle malattie genetiche.

L’altra questione di sicurezza da risolvere è quella delle
buone pratiche di produzione e dei meccanismi per
il controllo di qualità. Il Biological Research Modifiers
Advisory Comittee (Brmac) della Fda ha stabilito che i
processi produttivi devono essere tracciabili in tutti i
passaggi, dal donatore originario al trapianto nel ricevente.
Molti controlli di qualità possono essere riprodotti da
altre operazioni con agenti biologici, ma le staminali
embrionali pongono problemi peculiari per
quanto riguarda il mantenimento in coltura, la moltiplicazione
e la conservazione. Per esempio, dato che le
staminali embrionali possono essere coltivate in laboratorio
per molte generazioni, bisognerà prevedere
procedure di controllo adatte a scoprire le eventuali
mutazioni accumulatesi nel tempo.
Al momento non è chiaro se le linee di staminali
approvate per la ricerca federale possano soddisfare
simili standard di qualità, né se soddisferanno i requisiti
previsti dalle future linee guida sui difetti genetici.
In assenza di tali requisiti, non sarà accettabile
impiegare queste linee nell’uomo. I rischi menzionati,
che complicano la scelta delle linee da impiegare,
non sono i soli; altri timori riguardano il comportamento
delle staminali e dei loro prodotti una volta
trapiantati. Questi rischi possono essere valutati con
completezza solo mediante studi in vivo, fra i quali i
test preclinici negli animali. I quattro principali sono
i disguidi nel differenziamento e nella migrazione, la
cancerogenesi e il rigetto.
Gli errori di differenziamento
Al momento non sappiamo con esattezza come o perché
una cellula staminale si differenzi. Non è chiaro se
le popolazioni di cellule differenziate siano omogenee
né se l’omogeneità sia importante per gli esiti clinici.
Non si sa nemmeno se le cellule possano dedifferenziarsi,
cioè modificarsi dopo essersi già differenziate in
un dato tipo cellulare. Inoltre, anche se le cellule si differenziano
a dovere e in modo stabile, nulla assicura
che una volta iniettate nel ricevente migrino verso la
zona desiderata anziché in sedi improprie. I disguidi
nel differenziamento e nella migrazione comportano
rischi a breve e a lungo termine ed entrambi, a quanto
si può prevedere, possono causare seri effetti collaterali.
Per di più, anche se il differenziamento e la migrazione
vanno nel senso desiderato, ciò non assicura che
le cellule trapiantate funzioneranno a dovere 5.
La situazione si fa ancor più complessa se si pensa
alla scelta dei giusti modelli animali per gli esperimenti.
Se le staminali embrionali non umane vengono
trapiantate in animali della stessa specie d’appartenenza,
i dati sul differenziamento e la migrazione
rifletteranno con accuratezza le vie di trasmissione
dei segnali fra cellule, gli effetti degli ormoni e delle
citochine e gli altri processi in vivo che coinvolgono
molecole specie specifiche. Tali disegni sperimentali
però non dicono cosa accadrebbe se lo stesso esperimento
fosse svolto con cellule umane su soggetti
umani e non è chiaro fino a che punto i risultati possano
essere estrapolati. Al momento le norme della
Fda richiedono che la ricerca preclinica sia condotta
su almeno due modelli animali prima di iniziare le
sperimentazioni sull’uomo.
Una delle difficoltà nelle sperimentazioni su animali
è stabilire con quali metodi verificare il destino e
il comportamento delle cellule. Il Biological Research
Modifiers Advisory Comittee ha individuato i parametri
da verificare: la migrazione e il differenziamento
delle cellule, il fenotipo che esprimono, la loro integrazione
funzionale e la sopravvivenza dopo l’impianto.
Gli standard per questi esiti però devono ancora essere
sviluppati.
La cancerogenesi
La capacità di formare tumori è difficile da valutare, anche
perché la cancerogenesi può avvenire a distanza di
anni, se non decenni, dal trapianto. La necessità di raccogliere
dati preclinici adeguati condizionerà la scelta
dei modelli animali e la durata del follow up degli studi;
i piccoli animali di solito sono poco longevi e possono
non vivere abbastanza da sviluppare i tumori, ma
quelli grandi sono più costosi da allevare e impiegarli
nelle ricerche solleva maggiori remore etiche.
Può darsi che il pericolo sia maggiore quando le
cellule trapiantate non sono del tutto differenziate. Le
cellule che non hanno completato il differenziamento
però possono essere vantaggiose dal punto di vista dell’efficacia
della terapia, perché per esempio, nel sistema
nervoso, possono essere più capaci di migrare e stabilire
nuove connessioni sinaptiche rispetto a quelle
differenziate appieno. Alla luce del rischio di tumori, si
potrebbero inserire nelle cellule da trapiantare geni
suicidi
(nota 4); resta aperto l’interrogativo se per procedere alle
prime sperimentazioni umane si debba aspettare che
sia disponibile tale strumento.
Il rigetto
L’importanza del rigetto immunitario nelle terapie basate
su staminali embrionali resta controversa. Nei trapianti
ordinari l’entità del problema varia a seconda
dell’organo o del tessuto; il fegato, per esempio, è meno
suscettibile del rene, mentre non è ancora certo se
si abbiano o meno reazioni immunologiche contro i
tessuti estranei trapiantati nel cervello.
Gli esperimenti su animali con cellule neurali ricavate
dalle staminali embrionali, e i trapianti sperimentali
di neuroni fetali nei malati di Parkinson, hanno
mostrato che in linea di principio il trapianto di neuroni
derivati da staminali nelle malattie neurodegenerative
è fattibile, ma le incertezze sul rigetto restano
(nota 5).
I trapianti di cellule fetali per la malattia di Parkinson
sono stati eseguiti senza l’uso di immunosoppressori e
in altri studi le cellule fetali trapiantate sono sopravvissute
per oltre un anno dopo che l’immunosoppressione
era stata interrotta; tuttavia le autopsie su alcuni dei
riceventi hanno mostrato la presenza di marcatori immunologici
e d’infiammazione, segno di un attacco immunitario
in corso. Per fare chiarezza ci vorranno forse
altri studi su animali. Viceversa per altri campi d’applicazione
delle staminali, come la riparazione di lesioni
cardiache, ci sono già ampie prove che il rigetto
sarà un ostacolo importante con cui fare i conti.
La sperimentazione
Le prime prove di nuovi agenti sull’uomo sono condotte
di norma con sperimentazioni cliniche di fase 1, il cui scopo è di verificare
gli effetti collaterali e la tossicità e,
in alcuni casi, di determinare la massima dose tollerabile.
Gli studi di fase 2 raccolgono dati sull’efficacia
e la sicurezza, mentre quelli di fase 3 prevedono
di solito il confronto fra i nuovi agenti e gli interventi
già disponibili. Questo schema di sperimentazione
è stato sviluppato e rodato soprattutto per lo
studio dei farmaci, ma trova impiego anche nei test
di agenti biologici come i vaccini e i prodotti per la
terapia genica.

Chi deve partecipare alle prime sperimentazioni
delle terapie basate sulle staminali embrionali ?
(nota 6)
Ci sono elementi che rendono più accettabile, sul
piano etico, fare affrontare tale onere a determinate
persone e non ad altre?
Nella selezione dei soggetti per le sperimentazioni
di fase 1 si adottano due modelli molto diversi.
A un estremo c’è la ricerca oncologica, in cui si scelgono
malati che non hanno tratto benefici sufficienti
dalle terapie consuete e hanno ormai poche speranze
di veder regredire la malattia. La ricerca di fase
1 di nuovi chemioterapici viene spesso condotta con
un aumento progressivo delle dosi, per cui i primi pazienti
ricevono basse dosi del composto e i dosaggi
vengono man mano aumentati per i nuovi arruolati
finché non si manifestano effetti tossici intollerabili.
Di norma la dose iniziale è troppo bassa per dare benefici
clinici anche quando il farmaco si dimostra poi
efficace; i primi pazienti non hanno quindi alcuna
possibilità di trarne giovamento. Anche per i pazienti
successivi la speranza di trarre vantaggio dal trattamento
è spesso remota, mentre gli effetti collaterali e
gli altri oneri legati alla partecipazione
sono tutt’altro che improbabili. Al contrario di quanto
accade in oncologia, la ricerca di fase 1
sui vaccini è condotta di norma su volontari
sani. I vaccini di solito sono destinati a individui sani
e devono comportare scarsi rischi. Gli effetti collaterali
attesi dalla sperimentazione sono minimi e gli effetti
avversi seri sono rari. Dato che molti dei nuovi
vaccini non si mostrano efficaci, i volontari il più delle
volte non traggono alcun beneficio medico dalla partecipazione,
ma d’altra parte non subiscono nemmeno
particolari disagi o pericoli.
Quale dei due modelli è il più adatto per gli interventi
con cellule staminali? Che la ricerca venga condotta
su volontari sani è improbabile, per diverse ragioni.
Prima di tutto gli individui sani non sono i destinatari
degli interventi, che, a quanto si prevede, saranno
di carattere terapeutico e non preventivo. In secondo
luogo, anche se si impiegassero solo linee cellulari
che hanno superato attenti controlli di qualità e test
preclinici approfonditi, le incertezze sull’entità e sulla
probabilità dei rischi per i primi soggetti umani resteranno
comunque considerevoli. Per di più, molti degli
esami istologici condotti negli studi preclinici sarebbero
impossibili da eseguire su esseri umani, se non al momento
dell’autopsia.
Alla luce di simili incertezze il modello preferibile
sembra quello oncologico: i primi soggetti vanno reclutati
fra i malati gravi a cui i trattamenti convenzionali
non offrono grandi speranze. Poiché non c’è modo
di prevedere le probabilità che le prime sperimentazioni
umane funzionino, riteniamo che non sarebbe
etico chiedere ai pazienti di abbandonare trattamenti
efficaci anche solo in parte per partecipare ai primi studi
sulla fattibilità di principio delle nuove terapie.
Anche reclutare i soggetti fra i malati colpiti da malattie
a esito fatale e privi di valide opzioni terapeutiche,
tuttavia, ha i suoi inconvenienti. Una preoccupazione
fondamentale dev’essere quella di non
sfruttare i malati. Secondo alcuni studiosi, dubbiosi
sulla validità del consenso ottenuto da pazienti potenzialmente
spinti dalla disperazione, sarebbe preferibile
arruolare nei primi studi malati in condizioni
meno gravi, almeno in alcuni casi
(nota 7).
Bisognerà considerare con attenzione l’istituzione
di comitati consultivi per i pazienti, di metodi di
verifica del consenso, di associazioni di pazienti e di
altri strumenti che aiutino i potenziali volontari a decidere
a ragion veduta. Resta da stabilire se possa essere
utile, sia alla scienza sia ai potenziali arruolati,
un comitato consultivo nazionale per la ricerca sulle
staminali, sulla falsariga del Recombinant DNA
Advisory Committee che negli Stati Uniti sovrintende
agli studi di terapia genica umana finanziati
con fondi federali.
I malati più gravi possono non essere i candidati
ideali alle prime sperimentazioni anche per motivi tecnici.
In uno studio sui trapianti di cellule neurali fetali
nei malati di Parkinson, i pazienti sotto i sessant’anni
hanno mostrato una risposta positiva, almeno a un anno
dall’intervento, mentre quelli più anziani non hanno
ottenuto miglioramenti
(nota 8). Con il passare del tempo
però anche i benefici per i più giovani si sono ridimensionati.
Dato che per valutare la sicurezza e l’efficacia
dei trattamenti può essere necessario seguire i pazienti
a lungo, i malati più anziani e i più gravi rischiano di
non essere la scelta ideale. Per di più, a volte può essere
difficile ottenere la prova di principio che il trattamento
sia praticabile, e a maggior ragione trarre indizi
sulla sua efficacia, nei malati in fase avanzata. Arruolare
malati gravi non è una buona scelta se i dati che se ne
ricavano sono di utilità scarsa o nulla.
Nel futuro passaggio dalle sperimentazioni preliminari
agli studi su vasta scala e poi alle terapie approvate,
il bisogno di raccogliere i dati per lunghi periodi
persisterà, specie per i rischi di lungo termine come la
cancerogenesi. Si potrebbe cominciare subito a pensare
all’istituzione di registri dei pazienti o di altri mezzi
per tenere traccia di quanto accade a ciascuno nel corso
del tempo.
Conclusioni
Nella transizione della ricerca sulle staminali embrionali
umane dagli studi di base alle terapie approvate ci
sono svariate questioni di sicurezza di cui tenere conto.
Al momento restano irrisolti gli interrogativi su
quali linee di staminali scegliere per sviluppare le terapie.
Quando partiranno le sperimentazioni precliniche
bisognerà affrontare ulteriori incertezze, dalle incognite
sulla migrazione e il differenziamento delle cellule
ai rischi di cancerogenesi e di rigetto. Nel progettare
le sperimentazioni preliminari sull’uomo bisognerà
decidere con oculatezza quali soggetti arruolare.
Infine, una volta che le terapie si saranno dimostrate efficaci
e sicure, sarà prudente continuare a raccogliere i
dati sul destino dei pazienti per accertarsi che non ci
siano imprevisti sul lungo termine.
È difficile stabilire quali condizioni andranno
soddisfatte prima di procedere alle sperimentazioni
umane, vista le difficoltà di valutare i rischi dei trattamenti
e la mancanza di prove sulla loro efficacia. Le
questioni etiche, di procedura e di sicurezza da affrontare
prima di avviare una ricerca innovativa sugli
esseri umani sono formidabili. Mettere a punto terapie
che fanno uso di nuove tecnologie è sempre una sfida
etica difficile; sotto questo profilo, la ricerca sulle staminali
non differisce da altre aree di ricerca medica innovativa.
Quel che fa la differenza rispetto ad altri
ambiti di ricerca sono invece le controversie sul valore
morale da attribuire all’embrione umano ai primissimi
stadi di sviluppo.