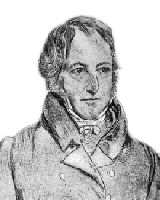|
|
|
News
|
Scrivi
|
Cebete |
L'autore |
Il progetto |
Credits |
Mappa del sito
|
|
|
|
|
|
http://web.tiscali.it/claufi
|
|
|
G.W.F. Hegel
|
|
|
|
Georg Wilhelm Friedrich
Hegel
(Stuttgart, 27 agosto
1770 - Berlin, 14 novembre 1831)
|
1. Vita
Nasce il 27
agosto 1770 a Stuttgart, studia a Tübingen teologia e filosofia, poi fa il
precettore fino al 1805 quando diviene professore a Jena e nel 1808 direttore
del ginnasio di Norimberga; nel 1816 è professore a Heidelberg, nel 1818 a
Berlino dove muore il 14 novembre 1831.
|
2. Opere
|
1793-1800 - |
Scritti
teologici giovanili |
|
1807 - |
Fenomenologia dello spirito |
|
1812-1816 - |
Scienza della logica |
|
1817 - |
Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio |
|
1821 - |
Filosofia del diritto |
|
|
«La vera figura nella quale la verità esiste, può essere soltanto
il sistema scientifico di essa. Collaborare a che la filosofia si avvicini alla forma della scienza, - alla meta raggiunta la quale
sia in grado di deporre il nome di amore del sapere per essere vivo sapere, - ecco ciò ch'io mi sono proposto»
(da G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, La Nuova Italia, Firenze 1960, p. 3).
|
|
|
U.D. 3
La questione della religione
Cfr. G.W.F. Hegel, Scritti teologici giovanili
|
Il giovane Hegel

Inediti,
sul piano teologico e politico. Parte da una domanda: come è possibile il
passaggio dalla religiosità cristiana alla religiosità del popolo, morale e
culturale? Risposta: vi è continuità. Nella Vita
di Gesù abbiamo la religione razionale che combatte contro le credenze
farisaiche.
A
Francoforte (1797) giunge al panteismo: l’unità di Dio e uomo espressa
nell’amore. L’amore è la vita di Dio, che si
realizza ogni volta che la vuota idealità del regno di Dio si cala nella realtà
del mondo. Hegel sente l’esigenza che l’ideale non rimanga tale, ma che
acquisti la potenza di realizzarsi e divenire realtà attuale.
Il mondo
interiore, pertanto, deve produrre un ordine giuridico esterno.
Ecco la
vita che è l’Idea = l’ideale realizzato,
attuato, manifestato, l’unità che si è realizzata nel molteplice senza perdersi
né dividersi. La vita è l’infinito e Dio, la Totalità. Solo la religione può
unire il finito dell’uomo all’infinito di Dio. Negli scritti giovanili l’unità
si realizza nella religione.
|
|
U.D. 4
L'idealismo assoluto
Cfr.
G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito
|
I capisaldi del sistema

Sono due:
a)
la
risoluzione del finito nell’infinito:
La realtà è
una struttura globale che come tale non lascia nulla fuori di sé (infinito). Il
finito in quanto tale non esiste, perché quello che chiamiamo finito è, in
realtà, un’espressione parziale dell’Infinito, dell’Assoluto, Idea, Ragione,
Spirito.
Il finito è tale solo nell’Infinito e in virtù dell’Infinito. È sì spinoziano
ma con l’enorme differenza che la Sostanza di Spinoza è statica e coincide con
la Natura, quella di Hegel è un soggetto spirituale in divenire che coincide
con l’uomo.
b)
l’identità
di razionale e reale:
Nella
prefazione alla Filosofia del diritto Hegel dice: «ciò che è razionale è
reale (1) e ciò che è reale è
razionale (2)».
(1)
la
razionalità non è pura idealità, vuoto dover-essere, ma è la struttura di ciò
che esiste;
(2)
la
realtà non è materia caotica, ma il dispiegarsi della struttura razionale,
inconsapevolmente nella natura, consapevolmente nell’uomo.
La realtà è quindi il luogo di realizzazione di un soggetto spirituale
infinito, di cui ciò che vediamo è una parte, un momento. la realtà è una
totalità processuale necessaria, l’articolazione vivente dell’unica Idea
mediante passaggi obbligati.
Ciò che è, deve essere. Discussione
critica: l’atteggiamento giustificazionista non è una banale giustificazione
del fatto compiuto (almeno non lo vuole essere) in quanto realtà è solo
l’essere determinato. Hegel infatti distingue tra essenziale e accidentale:
solo l’essenziale deve essere. Ma questa sembra una scappatoia.
|
|
U.D. 5
Il sistema delle scienze
Cfr.
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
|
Compiti e partizioni della filosofia

Compito
della filosofia è «intendere ciò che è, è il compito della filosofia, poiché
ciò che è, è la ragione». Nell’orizzonte teoretico fondato sulla totalità e
necessità Hegel rinuncia a determinare e guidare la realtà: “la verità non è
mai un problema”; vuole solo (ciò che può, ossia…) prendere atto della realtà e
mostrarne la sua razionalità: filosofia = giustificazione razionale della
realtà (sia essa politica, etica…).
Ne risulta
che il finito per sua natura è il diventare infinito. Perché ciò che è, è
infinito.
La Logica – scienza dell’idea in sé (e per sé).
La Filosofia della Natura – scienza dell’idea fuori di sé (esser altro).
La Filosofia dello Spirito
– scienza dell’idea nell’autocoscienza.
Ecco il
processo per cui tutto è uno, l’Assoluto non è fuori del progresso.
|
|
U.D.
6
Ce n'è per tutti...
Cfr.
G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito
|
La critica delle
filosofie precedenti 
a) L'Illuminismo
ha preteso di separare
ragione e realtà. La sua ragione finita, il suo intelletto astratto vuole
giudicare la realtà che come tale non sarebbe razionale, ma irrazionale, altro.
b) Kant
con la sua filosofia del finito
ha detto che l’essere non si adegua al dover essere, ha posto quella x
della cosa in sé che rende impotente l’io. Hegel contrappone la
filosofia dell’infinito.
c) Il
Romanticismo
ha privilegiato il
sentimento, l’arte, la fede, l’immediato. Ma Hegel dice che la scienza
dell’assoluto non può che essere sapere
mediato e razionale. In più Hegel non sopporta l’individualismo dei
Romantici.
d) Fichte
sbaglia nel dire che la realtà
deriva dall’Io. Invece la realtà
è
l’io, cioè lo Spirito stesso nel suo realizzarsi dialettico. In più l’infinito
fichtiano non supera mai realmente il finito, ma lo fa costantemente
riemergere: è un progresso all’infinito, è l’indefinito superamento del finito,
un cattivo infinito (schlechte Unendlichkeit),
e perciò esprime solo l’esigenza astratta del suo superamento.
e) Schelling, infine, concepisce
l’Assoluto in modo a-dialettico, un’unità statica, identica, indifferente. Ma
per Hegel è questo è un abisso vuoto senza determinazioni in cui tutte le
vacche sono nere. Solo l’unità dinamica dell’Assoluto hegeliano è l’unità
che si attua nella molteplicità, è l’unificazione del molteplice. Schelling, in
definitiva, non spiega la molteplicità.
|
|
U.D.
7
Il metodo
Cfr.
G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito
|
La dialettica
La dialettica è il metodo del sapere, la legge di
sviluppo della realtà: è il processo mediante il quale la ragione si
riconosce nella realtà conciliando l’opposizione nella pacifica unità
razionale del tutto.
L’idea
della dialettica deriva dall’amore cristiano che supera la molteplicità
mantenendola.
Se
da un lato vi è l’INTELLETTO che ferma la realtà in determinazioni rigide
dall’altro vi è il movimento DIALETTICO o NEGATIVO (o negativamente
razionale) in cui le determinazioni sono messe a confronto con i loro opposti e
cosi messe in crisi, dissolte. È la crisi del finito.
Infine il terzo momento SPECULATIVO positivo e razionale mostra l’unità
delle diverse determinazioni.
La
dialettica non è più procedimento logico, ma è necessaria sintesi razionale
di opposizioni autentiche (la negazione non è quindi
astratta o assoluta, ma concretamente determinata), il cui motore è «l’immane
potenza del negativo» e il cui scopo è di ridurre la molteplicità alla
perfezione dell’unità.
La
tragedia del mondo è solo – quindi – il modo d’essere passeggero di una
sostanziale commedia che è la stessa storia dell’Assoluto.
|
|
U.D. 8
La via all'Assoluto
Cfr.
G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito
|
La Fenomenologia dello
Spirito
Ora Hegel
descrive:
A)
la via percorsa dalla coscienza umana fino allo Spirito o la via che lo Spirito
ha percorso la coscienza umana per giungere a sé.
B)
lo Spirito come appare in atto nelle sue determinazioni fondamentali della
Realtà.
A è
la Fenomenologia dello Spirito e B è l'Enciclopedia delle
scienze filosofiche.
A è compreso in B ma come ormai pacificato. A, infatti,
mostra tutta la drammaticità della conquista di sé da parte dello Spirito nella
coscienza umana.
La Fenomenologia è la storia romanzata della coscienza che attraverso
erramenti, contrasti, scissioni e quindi infelicità e dolore, esce dalla sua
individualità, raggiunge l'universalità e si riconosce come ragione che è
realtà, e realtà che è ragione.
Ripercorriamo
quindi le dolorose tappe della via crucis dello Spirito.
|
|
coscienza (a)
|
|
a.1
|
La coscienza parte dalla certezza sensibile, rigidamente legata al questo
qui.
|
|
a.2
|
Ma chi sente è l'io universale: quindi nella percezione l'io prende su di
sé l'unità dell'oggetto e la riconosce stabilita da sé.
|
|
a.3
|
Ecco quindi la coscienza si fa intelletto: l'oggetto è fenomeno per la
coscienza, esso è interamente risolto nel sé. È dunque divenuta coscienza di
Sé o autocoscienza.
|
|
|
autocoscienza
(b)
|
|
b.1
|
L'autocoscienza è la coscienza che si riconosce tale e si vuole affermare
tra le altre autocoscienza. Nasce così la lotta
che uccide l'altro e che porta alla sottomissione nel rapporto di signoria-servitù in cui il padrone è cosciente
del proprio potere, lo schiavo no. Ma piano piano, per mezzo del lavoro, lo
schiavo diviene indispensabile al padrone e, quel che più conta, diviene
cosciente di questa sua indispensabilità: acquista cioè potere e coscienza di
tale potere. Rivendica quindi la propria libertà.
|
|
b.2
|
Con lo stoicismo la libertà è il fine
ultimo della coscienza che la rivendica, ma la realtà non è ancora negata e
la libertà è ancora desiderata astrattamente.
Più radicale è lo scetticismo che, negando
la realtà, pone questa nella coscienza stessa. Ma la coscienza è pur sempre
singola.
|
|
b.3
|
La coscienza si sente singola, una tra le tante, è coscienza infelice: riconosce l'infinità divina ma ne è
lontana. L'uomo è mutevole e finito. Nasce così la devozione religiosa
medievale che culmina nell'ascetismo dell'uomo che si ritiene nulla di fronte
a Dio: la miseria della carne tende a unificarsi con l'immutabilità di Dio.
Ma è proprio questa tensione che la salva.
La salvezza della coscienza infelice consiste nell'abbattimento
dell'individualità nell'atto dell'indiarsi. Ma una tale azione ha come
oggetto un principio trascendente e l'individualità non viene negata di per
sé ma solo risolta in un principio altro.
Con l'atto del riappropriarsi della propria individualità superata, cioè con
l'atto del rientrare dall'esteriorità ascetica della coscienza medievale,
abbiamo la Ragione. La Ragione è l'autocoscienza che si riconosce di essere
coscienza assoluta, soggetto assoluto. Ha cioè riportato nell'immanenza quel
principio che nella sua trascendenza serviva per abbattere il radicamento
all'individualità. Ora che nell'ascesi cristiana l'individualità è dissolta
in Dio, lo Spirito è pronto a riappropriarsene e a tornare nel mondo. D'ora
in poi non si parlerà più di individuo ma di soggetto
assoluto.
|
|
|
RAGIONE (g)
|
|
g.1
|
La ragione, soggetto assoluto, ha assunto in sé ogni realtà. Ma sente il
bisogno di giustificarsi.
Comincia quindi con un «inquieto cercare» nella osservazione
della natura (fisiognomica, frenologia...). Ma rimane deluso dalla sua
frammentaietà e dalla mancanza di un fondamento.
|
|
g.2
|
Si getta quindi nel piacere che la disperde. Cerca quindi di ritrovarsi in
una legge del cuore (il Romanticismo) che
ha la sua norma nella virtù (il bene astrattamente vagheggiato) ma è
sconfitta dal corso del mondo (il bene concretizzato).
|
|
g.3
|
Non rimane all'autocoscienza che liberarsi definitivamente di ogni
individualità (NB: tutta la storia dello Spirito non è che un progressivo
liberarsi dall'individualità): agire, quindi, e operare, divenire cosciente
in quanto realizzantesi nelle istituzioni storico-politiche, in un popolo e
soprattutto nello Stato.
Ecco il momento etico (in cui la morale del dover-essere si realizza): solo
col riconoscersi Stato l'autocoscienza depone con l'individualità, ogni
scissione interna, ogni infelicità, e raggiungere la pace e la sicurezza di
sé.
|
|
|
SPIRITO (d)
|
|
d.1
|
Lo Spirito è l'individuo nei suoi rapporti con la comunità sociale: il
primo momento e l'armonia della polis greca.
|
|
d.2
|
Il secondo momento è la frattura dell'alienazione dall'Impero romano alla
Rivoluzione Francese.
|
|
d.3
|
Lo Stato Etico tedesco è l'incarnazione
della moralità astratta più l'anima bella romantica.
|
|
|
RELIGIONE (e)
SAPERE ASSOLUTO (z)
|
|
|
Con la Religione e il Sapere Assoluto arriviamo all'individuo che acquista
la piena, totale ed esplicita coscienza di sé come Spirito. Ma questo è già
oggetto della Logica.
|
|
|
U.D.
9
L'idea in sé
Cfr.
G.W.F. Hegel, Scienza della logica
|
La Logica
La
Logica è l'Idea nella sua purezza in sé.
La Logica è
la scienza dell'Idea pura. Non è formale, il suo contenuto è l'assoluta verità,
la realtà, Dio stesso. È quindi la metafisica che si sviluppa mediante concetti
oggettivi che esprimono la realtà stessa nella sua essenza necessaria,
l'ossatura e la sostanza della realtà.
Il primo momento è il cominciamento
(l'azione dell'inizio, non l'inizio - che è un punto statico - ma l'azione
dell'iniziare, il cominciamento appunto) che come tale non è nulla, ma
deve avere in sé già tutto. Quindi il cominciamento consiste nel concetto
indeterminato, vuoto, privo di contenuto, massima estensione e minima
intenzione: l'essere. Questo, come tale,
è identico al nulla, è pura astrazione, è assolutamente privo di ogni determinazione,
di per sé, preso per sé è un puro nulla..
Essere e nulla (lo sanno anche i greci) sono
l'essenza del divenire. L'essere astratto
richiama quello determinato secondo qualità, quantità e misura (quantità della
qualità).
L'essere poi, riflettendo su di sé, scorge le proprie relazioni e si conosce
come essenza: identico, diverso, ragion
d'essere, che è l'esistenza (che appare nel fenomeno).
Ciò che è, la realtà, è quindi l'unità di essenza ed esistenza (interno ed
esterno). Le relazioni dell'essenza sono quindi sostanzialità, causalità,
reciprocità.
Ora, l'essere arricchito dalla riflessione su di sé e sulle sue relazioni
diviene infine concetto: soggettivo,
oggettivo e IDEA.
Il concetto soggettivo è formale (universale, particolare, individuale; poi
giudizio e poi sillogismo).
Il concetto oggettivo è naturale (meccanicismo, chimismo, teleologia -
categoria fondamentale della natura organizzata).
Infine c'è l'Idea, l'unità, l'unità dell'oggettivo e del soggettivo, il
soggetto-oggetto, la ragione autocosciente, la totalità della realtà in tutta
la sua ricchezza di determinazioni e relazioni interiori. L'idea è vita,
è conoscenza e, come unità dei due, è idea assoluta, ossia la
logica stessa.
|
|
U.D.
10
L'idea fuori di sé
Cfr.
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
|
La Filosofia della natura
La
Natura è l’Idea che si estrania da sé nel mondo, si realizza nell’esteriorità.
Ha la sua essenza nella NECESSITÀ (del
meccanicismo).
La Natura è
la forma dell'essere altro, l'esteriorità, la contraddizione insoluta, il
non-ens, la decadenza dell'Idea stessa (anche se di per sé anch'essa è divina):
Hegel parla di impotenza della natura.
Hegel non
rinuncia a tentare una schematizzazione triadica della struttura della Natura.
Vediamola, per dovere di cronaca:
|
NATURA
|
meccanica
|
spazio-tempo
|
|
materia e movimento
|
|
meccanica assoluta
|
|
fisica
|
individualità
universale
|
|
individualità
particolare
|
|
individualità totale
|
|
organica
|
natura geologica
|
|
natura vegetale
|
|
organismi animali
|
|
|
U.D. 11
L'idea in sé e per sé
Cfr.
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
|
La Filosofia dello Spirito
Lo Spirito è l'Idea che, dopo essersi estraniata da sé nel mondo della Natura
ritorna a sé.
Ha la sua essenza nella LIBERTà.
Si divide in:
·
Spirito soggettivo
·
Spirito oggettivo
·
Spirito assoluto
|
I. SPIRITO SOGGETTIVO
|
|
|
È lo Spirito individuale, l'anima.
L'anima è senziente, reale e coscienza che si fa autocoscienza universale,
ossia ragione teoretica e pratica.
La razionalità teoretica dell'anima è
l'insieme di determinazioni mediante le quali la ragione trova se stessa nel
suo contenuto (intuizione, rappresentazione e pensiero).
L'attività pratica è l'unità delle
manifestazioni con cui lo Spirito giunge in possesso di sé e quindi diviene
libero (sentimento pratico, impulsi, felicità).
La spiritualità soggettiva culmina nella libertà. Lo Spirito libero è
la volontà di libertà divenuta essenziale e costitutiva dello Spirito stesso.
|
|
II. SPIRITO OGGETTIVO
|
|
|
La libertà si realizza pienamente solo nello Spirito
oggettivo, cioè nelle istituzioni
storiche, dove volere razionale e volere singolo si toccano fino a
venire a coincidere.
|
|
a) DIRITTO
|
|
|
Ecco quindi il diritto astratto: la proprietà
della persona individuale.
|
|
b) MORALITà
|
|
|
Ecco la moralità che è la sfera
dell'azione che ha per fine il benessere: è la volontà soggettiva
come tale può generare il male.
|
|
c) ETICITà
|
|
|
Ecco infine l'eticità dove la
separazione tra la soggettività e il bene viene superata: il bene si è
realizzato concretamente, è divenuto esistente. Questa a sua volta ha tre
momenti: la famiglia, la società civile, lo STATO.
Solo nello Stato è la volontà divina.
Solo nello Stato si realizza pienamente la sostanza infinita e razionale
dello Spirito.
Niente contratto sociale (v. Rousseau), niente democrazia (v.): lo Stato trae
da sé la sua sovranità e solo la STORIA può essergli giudice (la storia è il giudizio universale!).
Sì, la storia non è un tessuto di fatti contingenti (come può sembrare ad un
intelletto finito). Hegel prende dalla fede l'idea della razionalità
immanente la storia il cui fine è l'autocoscienza e la realizzazione dello
Spirito e i cui mezzi sono i singoli individui e i popoli.
A questo scopo giocano i conservatori interpreti della tradizione e
(all'opposto) gli eroi rappresentanti del progresso.
|
|
|
Accenni di
filosofia della storia:
·
il mondo orientale è l'uomo solo libero,
·
il mondo greco sono alcuni uomini liberi,
·
il mondo germanico è quello in cui tutti gli individui
sono liberi nella totalità dello Stato e, in più, lo sanno: sanno di essere
tutti liberi nello Stato.
Ecco lo
Stato perfetto: lo STATO ETICO che
risolve l'individuo nell'organismo universale della comunità.
|
|
U.D. 12
La grande triade
Cfr.
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
|
Lo Spirito Assoluto 
Nello
Spirito Assoluto lo Spirito di un popolo si manifesta nella sua...
spiritualità.
Lo Spirito Assoluto ha un unico contenuto... l'ASSOLUTO, DIO.
Ma in tre forme:
|
ARTE
|
=
|
intuizione
sensibile
|
|
RELIGIONE
|
=
|
rappresentazione
|
|
FILOSOFIA
|
=
|
concetto
|
|
I. ARTE
|
|
|
Lo Spirito acquista coscienza di sé mediante forme sensibili che
riuniscono Natura e Spirito. Prima nell'arte
simbolica orientale che è caratterizzata da uno squilibrio (tra
contenuto spirituale e forma sensibile) e la sua espressione è il simbolo.
Poi nell'arte classica greca che è
caratterizzata dall'armonia espressa dalla figura umana.
Infine nell'arte romantica che è così
vicina allo Spirito che è di nuovo squilibrata sentendo l'inadeguatezza delle
forme sensibili a contenere l'interiorità spirituale così ricca. Di qui la
crisi dell'arte moderna (che non è però morta; è morta invece quella classica
e c'è chi sente il romanticismo proprio come nostalgia dell'ingenuità
classica... v. Schiller).
|
|
II. RELIGIONE
|
|
|
L'arte è l'immediato nell'intuizione.
La religione è l'Assoluto nella forma della rappresentazione (Vor-stellung:
porre davanti).
La filosofia della religione non crea la religione ma la giustifica mostrando
in essa l'idea infinita in atto.
L'oggetto è il più alto possibile: DIO. Il soggetto è l'uomo, lo scopo è
l'unificazione e la riconciliazione dei due.
La religione ha dunque (tanto per cambiare) una struttura triadica: Dio, coscienza di
Dio e culto.
La filosofia è il più alto culto in quanto evidenzia la più pregnante
prerogativa di Dio: il pensiero («in principio era...»).
Immediatezza del sentimento, intuizione e rappresentazione di Dio sono i
(tre) momenti del culto.
La rappresentazione di Dio porta alla religione naturale (cinese e buddista),
alla religione della libertà (persiana ed egiziana), alla religione
dell'individualità (greca, romana ed... ebraica) infine alla religione
assoluta (il Cristianesimo) che coglie l'unità del divino e dell'umano.
Ma non si finisce qui. L'esito della religione assoluta
nella rappresentazione dell'Assoluto quale
unità di divino e umano mediante l'affermazione della più grande peculiarità
della divinità stessa e della caratteristica dell'uomo in quanto tale (il
pensiero) sembra essere definitivo, ma non lo è. Non lo è perché è un esito
rappresentantivo. La religione è solo rappresentazione dell'Assoluto.
|
|
III. FILOSOFIA
|
|
|
Se la religione è la rappresentazione dell'Assoluto ciò
vuol dire che l'Assoluto è fuori di sé. La filosofia è il ritorno in sé
dell'Assoluto stesso, è l'ASSOLUTO VERO.
L'Assoluto vero coincide con la storia stessa
della filosofia ormai giunta a compimento, storia in cui ogni tappa è
necessaria e Hegel è... l'ultima tappa.
Il concetto abbraccia e comprende quel che la religione
rappresenta. In termini tedeschi si può distinguere la Vor-stellung dalla
Dar-stellung e dal Be-griff: la rappresentazione esteriore, estraniata ed
alienata dalla comprensione del concetto. Ciò che nella religione è esterno
nella filosofia diviene interno. Ecco quindi perché la filosofia di Hegel può
essere riassunta in un grande movimento (dialettico) di interiorizzazione o
ri-interiorizzazione - in tedesco: Er-innerung, ritornare all'interno - in
italiano: memoria.
|
|
|
U.D. 13
|
Conclusioni

...
|
|
Ultimo aggiornamento:
giovedì 20 marzo 2003
|
![]()
![]()