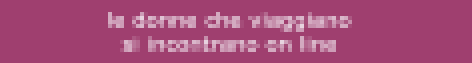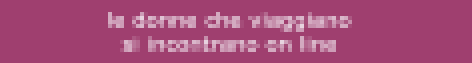| |
Ora solo un pazzo
potrà «pentirsi»
Un intervento sulla nuova legge per i collaboratori di giustizia
di Armando Spataro

La nuova legge sui collaboratori
è l'ennesimo esempio delle conseguenze
tecnicamente perverse prodotte da una legislazione che, in
materia penale e processuale, procede da almeno due anni sulla
base di unanimi mediazioni politiche piuttosto che in vista
di esigenze di efficienza e giusti risultati. Da oggi la
collaborazione processuale è ancora più difficile,
perché solo un pazzo accetterà di collaborare
sapendo che i suoi familiari saranno protetti solo se sono
con lui conviventi e che potranno subire il sequestro anche
di beni di provenienza lecita.
Ignorando l'importanza dei riscontri ed i principi del giusto
processo così pubblicizzati, il legislatore prevede
poi la protezione speciale solo per il collaboratore
portatore di accuse connotate da novità, ben sapendo
che la mafia teme di più i contributi dei collaboratori
che sopravvengono a confermare il primo. E poi è
incompatibile con il nostro ordinamento l'ampliamento
dei poteri del Procuratore Nazionale Antimafia
e dei Procuratori Generali che diventano competenti a formulare
proposte e pareri sulle libertà, persino all'interno
di processi, nei quali non hanno alcuna veste.
Vengono introdotti, ancora, dei veri obbrobri sul piano giuridico,
come la revisione di una sentenza definitiva per effetto
di un delitto commesso successivamente: immagino che la dottrina
inorridirà! E perché mai si prevede l'improcedibilità
di difendere più collaboratori senza prevederla
per la difesa degli altri mafiosi sicuramente interessati
all'inquinamento? E perché mai, vista l'obbligatorietà
dell'azione penale, saranno inutilizzabili le dichiarazioni
rese dopo sei mesi dallíinizio della collaborazione,
per effetto, magari, di ritardi addebitati al lavoro dei pm?
Si salva molto poco: per esempio la specificazione delle ragioni
delle erogazioni economiche possibili, il programma
di protezione per i meri testimoni, l'aumento di pena
per le calunnie e poco altro. Dopo la legge sulle investigazioni
difensive, un'altra pagina nera per l'accertamento
della verità in sede processuale.
La nuova legge sui collaboratori
di giustizia
di Armando Spataro
La nuova legge sui collaboratori di giustizia, approvata
in via definitiva dal Senato il 7.2.2001, è stata accolta
da un coro pressocchè unanime di positivi apprezzamenti,
il che non impedisce di rilevarne difetti e lacune: è
ragionevole temere, anzi, che essa determini l’inaridirsi
del fenomeno della collaborazione processuale, che pure tanta
parte ha avuto, negli ultimi anni, nel contrasto della criminalità
mafiosa e nell’accertamento delle responsabilità
per gravissimi reati. Naturalmente, non vi può essere
dubbio che il legislatore si sia fatto carico efficacemente
di alcuni rilevanti problemi che la normativa previgente aveva
fatto emergere (ad es., assenza di adeguate previsioni su
protezione e reinserimento dei testimoni puri, sulle specifiche
causali delle erogazioni economiche possibili in favore dei
collaboratori, sul catalogo dei loro diritti, etc.) e, del
resto, alcuni insoddisfacenti aspetti della situazione preesistente
(ad es., difficoltà per ottenere il cambio di identità
o reperire occasioni di lavoro) erano frutto più delle
prassi adottate che delle lacune legislative: vi era bisogno,
in ogni caso, di una normativa che riordinasse il delicato
settore.
Alcune delle scelte ora adottate, per«, da un lato
appaiono di dubbia utilità e scarsamente comprensibili
e, dall’altro, hanno determinato l’introduzione
nell’ordinamento di soluzioni criticabili sul piano strettamente
giuridico. Intanto, va detto che le premesse giustificative
della legge, più volte pubblicizzate dal Governo e
da autorevoli parlamentari, fondate sulla necessità
di ridurre drasticamente il numero dei collaboratori e dei
loro familiari ammessi allo speciale programma di protezione,
non hanno tenuto conto del rapporto confortante tra il numero
delle collaborazioni intervenute ed i risultati ottenuti in
sede di indagini. Per quanto attiene alle dimensioni del fenomeno,
poi, sarebbe stato significativo porre in relazione il numero
dei collaboratori con quello degli appartenenti alle organizzazioni
criminali operanti in Italia, anzichè, con analisi
assai riduttiva, presentare gli «oltre mille collaboratori»
come dato dimostrativo della impossibilità di gestione
del fenomeno: semmai, alla luce degli straordinari risultati
conseguiti dal ’92 in avanti, vi sarebbe stata necessità
di interventi legislativi tendenti a stimolare la crescita
quali-quantitativa del fenomeno e non a determinarne la sua
contrazione.
E’ opportuno, allora, passare in rassegna le scelte
del legislatore che maggiormente destano perplessità,
piuttosto che quelle condivisibili, con la specificazione
che di seguito, quando si citeranno le norme di legge, si
farà sempre riferimento all’articolato dell’originaria
L. 15.3.91 n.82, così come modificata dalla legge di
cui qui ci si occupa. Quanto ai connotati che la collaborazione
deve assumere perché possano essere applicate le speciali
misure di protezione, il comma 3 dell’art.9 prevede che
essa debba presentare, oltre quello della intrinseca attendibilità,
il carattere della «novità», sia pur previsto
alternativamente (e non congiuntamente) a quelli della completezza
o della notevole importanza per lo sviluppo delle indagini
o ai fini del giudizio etc.. Orbene, il connotato della novità
appare di difficile valutazione soprattutto in tema di reati
associativi e sembra limitare, inoltre, la possibilità
di collaborazioni particolarmente significative: una interpretazione
rigida di tale requisito, cioè, potrebbe precludere
l’accesso alle specifiche misure di protezione di tutti
quei collaboratori che, nella vicenda giudiziaria, non sono
unici o primi portatori di conoscenze sul tema che ne è
oggetto.
Tra l’altro, si dimentica che spesso è
proprio una collaborazione successiva che - nel suo significato
di rafforzamento della isolata, e perciò meno temibile,
prova originaria- può determinare reazioni da parte
del gruppo criminale. Tanto più ove si pensi all’importanza
che una pluralità di contributi può assumere
in presenza del mutato quadro costituzionale (ci si riferisce,
è chiaro - alle modifiche dell’art. 111 Cost.)
e processuale. I requisiti della «completezza»
e della «notevole importanza», poi, ben difficilmente
potranno costituire oggetto di valutazione da parte della
Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle
speciali misure di protezione, che è organo amministrativo,
poichè quelle valutazioni rientrano direttamente nelle
competenze della Procura proponente: l’attribuire poteri
valutativi di questo tipo alla Commissione crea le premesse
per possibili contrasti tra l’A.G. e l’organo amministrativo,
con evidenti e gravi ripercussioni anche sui dibattimenti.
Singolarmente, peraltro, la legge prevede il requisito
della «notevole importanza» della collaborazione
solo in relazione ad attività di indagine sulle connotazioni
strutturali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso
o terroristico-eversive, con ingiustificata esclusione delle
associazioni finalizzate al narcotrafico (at. 74 DPR 309/’90)
che pure rientrano nella competenza delle DDA. Anche la prevista
limitazione (ex art. 9 comma 2 della Legge) delle speciali
misure di protezione a coloro che tengano condotta di collaborazione
in relazione ai soli delitti commessi per finalità
di terrorismo o di eversione ovvero ricompresi tra quelli
di cui all’ art. 51 comma 3 bis c.p.p. appare priva di
reale giustificazione atteso che una utilissima collaborazione
può trovare l’occasione anche in delitti non di
stampo mafioso: a titolo esemplificativo la norma esclude
da ogni misura speciale di protezione il soggetto che abbia
prestato collaborazione in riferimento ad una pluralità
di omicidi commessi in un ambito di criminalità organizzata,
ma non di stampo mafioso (ad es. gruppi criminali emergenti),
ovvero il trafficante in sostanze stupefacenti per ingenti
quantitativi che non risulti inserito in organizzazione corrispondente
alla previsione di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 ovvero
l’indagato che riferisca in ordine ad una organizzazione
non mafiosa dedita alla pratica estorsiva ed all’usura,
spesso anticamera della pratica mafiosa in senso proprio.
Insomma, come l’esperienza insegna, l’emergere della
realtà mafiosa è spesso la conseguenza di
collaborazioni che non hanno, inizialmente, quello specifico
oggetto. La limitazione prevista dall’art. 9 comma 4
della Legge per le categorie di parenti del collaboratore
ammissibili alle speciali misure di protezione non appare
condivisibile. La distinzione tra conviventi con il collaboratore,
categoria per la quale l’estensione del programma non
sembra richiedere ulteriori condizioni, e tutti gli altri
soggetti per i quali l’estensione è subordinata
all’esistenza di grave ed attuale pericolo (difficilissimo
da provare in concreto) a causa delle relazioni intrattenute
con il collaboratore, pone i parenti non conviventi in una
posizione deteriore, atteso che anche per questi ultimi la
situazione di pericolo nasce spesso dal mero rapporto di parentela,
come l’esperienza di questi anni ha tragicamente dimostrato.
Ma la sola parentela, in difetto di stabile coabitazione,
non è sufficiente a determinare l’applicazione
delle misure. In realtà, le scelte della Commissione
non dovrebbero essere collegate alla previsione di categorie
astratte, ma a situazioni concrete, come del resto si prevede
(art. 16 bis c.3) per i parenti o per coloro che intrattengano
relazioni con i "testimoni di giustizia".
Anche lo specifico riferimento alla forza di intimidazione
di cui il gruppo è localmente in grado di valersi,
quale requisito nella determinazione delle situazioni di pericolo
rilevanti (art. 9 c. 5 della Legge) sembra di difficile lettura
e valutazione: non pare logico infatti, limitare la possibilità
di ammissione a misure di protezione di un collaboratore solo
se l’organizzazione mafiosa di cui egli abbia rivelato
struttura e crimini sia operante nel territorio in cui egli
risiede. Si può seriamente sostenere che il collaboratore
che abbia rivelato quanto a sua conoscenza su Cosa Nostra
o sulla Ndrangheta o sulla Camorra non sia soggetto a pericolo
solo per il fatto di non risiedere in zona «a rischio»?
Insomma, queste opzioni legislative rischiano di disincentivare
la capacità di «resistenza» del collaboratore
rispetto al rischio, anche solo astratto, di minacce e pressioni
esterne tese a fargli ritrattare le dichiarazioni rese: rischio
tanto più grave ove si pensi che, a seguito della modifica
dell’art.111 Cost., non potranno essere utilizzate le
dichiarazioni antecedentemente rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all’esame
da parte dell’imputato o del suo difensore. E’ vero
che tali dichiarazioni potranno essere valutate come prova
dei fatti in esse affermati quando risulti che la persona
che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè
si sottragga all’esame, ma è pur vero che, a prescindere
da ogni rilievo sulla oggettiva difficoltà di raccogliere
questa prova (specie in relazione ai procedimenti previsti
dall’art. 51 c.3 bis c.p.p.), tale previsione, pur di
agevole interpretazione sul piano logico, non contiene alcun
riferimento alle modalità della formazione della prova
relativa all’intervenuta violenza, minaccia, offerta
o promessa di denaro o di altra utilità.
Secondo la formulazione dell’art.111 Cost., infatti,
è logico ritenere che anche questa prova si debba formare
in dibattimento e nel contraddittorio tra le parti, sicchè
ben difficilmente un collaboratore processuale che, dopo avere
reso dichiarazioni erga alios in fase di indagine preliminare,
scelga in dibattimento la strada del silenzio per effetto
di violenza o minaccia, sarà disposto a svelare in
dibattimento le violenze, le minacce o le offerte di cui lui
o i suoi familiari siano stati destinatari. Né la nuova legge
sui collaboratori si è fatta carico di prevedere particolari
meccanismi per agevolare l’acquisizione della prova in
ordine a minacce e pressioni rivolte al collaboratore. La
composizione della Commissione Centrale riflette un’esigenza
di corretto equilibrio tra competenze politiche, giudiziarie
(due sono i magistrati componenti) e di polizia, ma non è
comprensibile il divieto di farne parte per i magistrati provenienti
dall’Ufficio del Pubblico Ministero (art. 10, lett. «d»,
c. 2 bis della Legge), che pure sono portatori delle più
dirette conoscenze relative al fenomeno oggetto dell’investigazione
ed al concreto dispiegarsi delle collaborazioni processuali.
Il rischio di eccessiva «contiguità» rispetto
ai destinatari delle misure di protezione sarebbe stato
facilmente evitabile prevedendo per loro, come è per
i giudici (art. 10, lett. «d», c. 2 octies), il
divieto di svolgere il ruolo di P.M. nei procedimenti cui
partecipano a qualsiasi titolo i soggetti destinatari delle
misure di protezione. Con l’art. 11 c. 2 della Legge,
relativo alla proposta di ammissione» alle speciali
misure di protezione proveniente dall’A.G., si prevede
la possibilità che più uffici del PM, in particolare
D.D.A., procedano ad indagini collegate ex art. 371 c.p.p.,
richiedendosi, in tal caso, che la proposta venga formulata
da uno di essi d’intesa con gli altri. Ma si prevede
pure che «nel caso di mancata intesa, il Procuratore
Nazionale Antimafia risolve il contrasto». E’ questa
la prima di una serie di norme che, risolvendosi nell’attribuzione
al P.N.A. di poteri giustificabili solo in un diverso assetto
ordinamentale (contemplante, ad es., un rapporto gerarchico
tra DDA e DNA o l’attribuzione a quest’ultima della
titolarità dell’azione penale), appare criticabile.
E’ ovviamente possibile ed anzi auspicabile che il
PNA si attivi -nell’ambito dei propri poteri- per realizzare
l’intesa tra le Procure interessate alle indagini collegate,
ma altro è l’attribuzione di un potere di risoluzione
del possibile contrasto: l’intesa, rientrando nel genere
degli atti amministrativi complessi, è atto che presuppone
l’esistenza di due o più soggetti titolari di
interessi distinti anche se convergenti, interessi che si
riconoscono anche in capo all’organo preposto alla soluzione
dei conflitti. Ma la Procura Nazionale non è titolare
di poteri di indagine (a cui va direttamente collegata la
proposta di ammissione al programma di protezione), sicchè
il potere conferitole appare espressione di una funzione di
controllo gerarchico, non prevista dalla legge che l’ha
istituita. Le conoscenze della Procura Nazionale dei fenomeni
criminali non rilevano rispetto alla fase della formulazione
della proposta, ma semmai nella fase della decisione della
Commissione attraverso la formulazione d un mero parere non
vincolante che consentirebbe a quell’ufficio di interloquire
con manifestazioni di conoscenza e non con manifestazioni
di volontà che non le competono in questa materia.
Tra gli impegni che il soggetto ammesso al programma di protezione
deve assumere, la legge prevede (art. 12 c.2, lett. «d»)
l’obbligo di «non rilasciare a soggetti diversi
dall’A.G., dalle forze di polizia e dal proprio difensore
dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per
i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato prestano
la loro collaborazione». E’ facile rilevare un’evidente
contrasto tra questa previsione ed i poteri che, in base alle
Disposizioni in materia di indagini difensive (L. 7.12.2000
n.397), sono stati attribuiti ai difensori di indagati ed
imputati che, come è facile prevedere, proprio nei
confronti dei collaboratori accusanti concentreranno innanzitutto
i loro sforzi. Nell’art. 12 c. 2, lett. «e»
della Legge, si richiede che, all’atto della sottoscrizione
delle speciali misure di protezione, il collaboratore si impegni
«a specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti
o controllati, direttamente o per interposta persona, e le
altre utilità delle quali dispongono direttamente o
indirettamente, nonchèa versare il denaro frutto di
attività illecite». Di tutto l’A.G. dispone
l’immediato sequestro.
La previsione risponde alla sacrosanta esigenza di evitare
che il collaboratore furbescamente trattenga per sé
i profitti delle sue precedenti attività delittuose
: tuttavia è agevole rilevare che, a fronte di un impegno
a rendere dichiarazioni leali e complete, si prevede un obbligo
di sequestro ad opera dell’A.G. difficilmente realizzabile
proprio per le formule troppo generiche adottate dal Legislatore
(quando, ad es., un bene intestato a terzi è riconducibile
alla controllo ed alla disponibilità del collaboratore?)
e che potrebbe rivelarsi iniquo nei confronti di congiunti
titolari di beni acquisiti legalmente (la provenienza illecita,
infatti, viene richiesta solo per il denaro). Un’iniquità
alla quale saranno ovviamente sensibili proprio i collaboratori,
specie ove nei loro confronti, come finora è troppo
spesso avvenuto, la complessiva assistenza fin qui assicurata
dal Servizio Centrale di Protezione continuerà a rivelarsi
inidonea ai fini del reinserimento sociale. A proposito di
assistenza, non può non destare stupore la previsione
dell’ultima parte del c.6 dell’art.13 della Legge
secondo cui, a richiesta dei difensori dei soggetti accusati
dai collaboratori, il giudice del dibattimento può
acquisire e dunque rendere pubblici i documenti contenenti
«l’indicazione dell’importo dettagliato delle
spese sostenute per la persona sottoposta al programma di
protezione».
Orbene, quanto questa indicazione dettagliata sia incompatibile
con l’esigenza di riservatezza in ordine alle misure
adottate per la protezione ed il reinserimento del collaboratore,
che pure la legge enuncia in più passaggi, lo comprende
chiunque: si è voluto, in realtà, prestare ascolto
alla pretese di una parte dell’avvocatura penale secondo
cui le notizie in questione dovrebbero concorrere alla formazione
del libero convincimento del giudice, ovviamente nel senso
di illuminare sinistramente le dichiarazioni del collaborante.
Lo stesso potrebbe dirsi, del resto, in ordine alla possibilità
di acquisire, sempre a richiesta di parte, la copia dei registri
tenuti dai direttori di carcere attestanti dettagliatamente
gli estremi dei colloqui investigativi cui il collaboratore
sia stato sottoposto (art 16 sexies, c.2.). Tornando all’assistenza
economica, le esigenze di trasparenza potrebbero facilmente
essere assicurate mediante l’attestazione della sottoposizione
del collaboratore allo speciale programma di protezione (che
per legge comprende l’erogazione di sussidi economici)
senza pregiudicare, con la pubblicità di notizie dettagliate,
la doverosa segretezza, ad es., sul tipo di attività
economica o lavorativa intrapresa dal collaboratore o dai
suoi familiari all’interno del programma stesso.
Con l’art. 13 c. 14 della Legge si prevede il divieto
di corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica dei
collaboratori -evidentemente anche con i loro familiari -
durante la redazione dei verbali e comunque fino alla redazione
del verbale illustrativo (fase che può durare vari
mesi), salvo autorizzazione dell’A.G. «quando ricorramo
gravi esigenze relative alla vita familiare». Si introduce
un regime anche più duro di quello previsto dall’attuale
art. 41 bis c.2 Ord. Penitenziario, tanto più insopportabile
per il collaboratore perché esso si applicherà
ad una fase - quella iniziale della collaborazione - che è
notoriamente quella più carica di preoccupazioni per
la famiglia ed in cui più necessita la vicinanza psicologica
dei congiunti. Sarebbe stato forse meglio prevedere la possibilità
di colloqui con i familiari, salvo il potere di vietarli per
specifiche ragioni di sospetto. Il capo III della Legge si
intitola «Nuove norme per il trattamento sanzionatorio
di coloro che collaborano con la giustizia.», ma si
riferisce, in realtà, tanto ad aspetti processualpenalistici
cautelari che ad aspetti penalistici, concernenti sia la commisurazione
della pena che la sua esecuzione.
E’ il caso di occuparsi subito del divieto delle cosiddette
«dichiarazioni a rate», introdotto dall’art.16
quater della legge : un coro assolutamente unanime di consensi
ha salutato l’introduzione di questo divieto come frutto
di una scelta di grande civiltà giuridica. Non pare
che ci« sia totalmente vero. Dunque, il collaboratore,
entro 180 giorni dalla manifestazione della sua volontà
di collaborare, deve rendere al P.M. che lo interroga (documentando
l’atto con registrazione audiovisiva o fonografica) tutte
le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione di fatti
e responsabilità individuali, alla cattura di criminali,
al sequestro e confisca dei loro patrimoni etc.. . Sin qui
quasi nulla da eccepire, senonchè:
a) il termine di 180 giorni dalla manifestazione della
volontà di collaborazione, entro cui rendere e completare
le dichiarazioni, viene introdotto quale condizione di ammissibilità
non solo alle misure di protezione, ma anche alla concessione
delle attenuanti (art. 16 quinquies) e dei benefici penitenziari
(art. 16 nonies), con grave strappo - additivo e manipolativo
- rispetto alla disciplina della concessione delle une e degli
altri, ancorata a meri presupposti di fatto previsti da precise
disposizioni;
b) al comma 9 dell’art. 16 quater si prevede la sanzione
della inutilizzabilità (evidentemente anche come mero
riscontro o in presenza di riscontri esterni) contra alios
delle dichiarazioni rese al P.M. o alla P.G. oltre il suddetto
termine: la sanzione è all’evidenza illogica e
contraddice il principio dell’obbligatorietà dell’azione
penale (anche se fa salve le dichiarazioni irripetibili e,
sembra, indirettamente anche quelle rese in incidente probatorio
e per la prima volta in sede di udienza);
c) la previsione di un termine così rigido e ristretto
non tiene conto non solo del pur possibile vuoto di memoria
del collaboratore (quello che, ad es., si può colmare
con eventuali contestazioni che il PM è in grado di
muovere dopo le prime indagini a riscontro), ma anche della
ricorrente ipotesi in cui l’interrogatorio del collaboratore
si protragga a lungo non certo per volontà dello stesso
(che anzi invoca spesso un rapido esaurimento dell’atto),
ma per impegni del competente Pubblico Ministero (ipotesi
tutt’altro che improbabile, alla luce delle formalità
e dei tempi lunghi dei dibattimenti cui i magistrati inquirenti
sono ormai costretti dalla legislazione processualpenalistica
degli ultimi due anni): andrebbe prevista, dunque, almeno
la possibilità di deroga motivata da parte del Procuratore
della Repubblica (se si vuole, sottoposta a controllo del
giudice) o, quanto meno, spostato in avanti il dies a quo
da individuarsi nel momento di inizio effettivo della collaborazione
processuale (e non in quello di manifestazione della relativa
volontà);
d) non è chiara, infine, la natura del verbale illustrativo,
come non è chiaro il momento realizzativo; né si comprende
quale rapporto esso ha con i verbali di indagine preliminare;
ne è inoltre prevista una utilizzazione processuale
al di fuori del rispetto di tutte le disposizioni relative
agli interrogatori. Il comma 3, infatti, richiama per tale
atto alcune soltanto delle norme previste per gli interrogatori
di indagine preliminare (ad es. 141 bis c.p.p.), ma non le
più importanti (ad es., avviso al difensore; avvertimento
della facoltà di non rispondere); vengono poi previsti
l’inserimento nel fascicolo del P.M. e modalità
di impiego atipico in sede dibattimentale. Addirittura, il
verbale illustrativo deve contenere l’attestazione del
collaboratore (cui vengono attribuiti, dunque, «poteri
certificativi») di non essere in possesso di altre notizie
utili per gli investigatori. Insomma, l’ossequio ad un
principio logico e civile, la cui violazione non può
che trovare eventuale «sanzione» al momento dell’applicazione
del principio del libero convincimento del giudice, si realizza
attraverso una serie di previsioni a loro volta illogiche
e persino contrarie ad alcuni principi cardine del processo
penale.
Ma anche in altri passaggi della legge è possibile
ravvisare distorsioni di condivisibili orientamenti: il legislatore
ha voluto correttamente affermare che il collaboratore ammesso
a programma di protezione, che abbia fruito di attenuanti
in sede processuale e di benefici penitenziari, deve trasformarsi
in un soggetto rispettoso della legge e del vivere civile:
se, dunque, commette nuovamente dei reati o se si accerta
che ha goduto di attenuanti e benefici per effetto di false
dichiarazioni, il suo comportamento deve essere sanzionato,
innanzitutto con l’esclusione dal programma e con la
revoca di attenuanti e benefici. La procedura prevista, per
quanto complessa, è ragionevole (pur se l’ipotesi
della reticenza quale causa di possibile revisione determinerà
inevitabili difficoltà, trattandosi di presupposto
di difficilissima valutazione in quella sede), così
come l’aumento di pena per il reato di calunnia.
Non altrettanto, per«, può dirsi per la procedura
di revisione di sentenze passate in giudicato prevista
dall’ultima parte del comma 1, art. 16 septies : si prevede,
cioè, la possibilità di revisione della sentenza
per effetto della successiva commissione, entro un termine
massimo di dieci anni, di un delitto per il quale l’arresto
in flagranza sia obbligatorio; si tratta di un principio che
nulla ha a che vedere con l’istituto della revisione
(che non può certo dipendere da un delitto posteriormente
commesso rispetto a quello oggetto della sentenza) e realizza,
in realtà, una sorta di condizione risolutiva a tempo
determinato delle attenuanti per effetto di successivi comportamenti
di chi ne aveva legittimamente beneficiato (un diritto penale
del «tipo d’autore» riferibile ai soli collaboratori).
Ingiustificata, nella stessa filosofia della legge, appare
l’impossibilità di una revisione in pejus, in
identica situazione (reato commesso dopo il passaggio in giudicato
di una sentenza che gli riconosca delle attenuanti), per il
«delinquente irriducibile». Ma altre preoccupanti
violazioni dei principi di diritto processuale penale ed ordinamentale
derivano dalle procedure rispettivamente previste dagli artt.
16 octies e 16 nonies per la «revoca o sostituzione
della custodia cautelare per effetto della collaborazione»
e per la concessione di «benefici penitenziari».
Nel primo caso, intanto, si afferma che la revoca della custodia
cautelare o la sua sostituzione con altra meno afflittiva
non possono intervenire per il solo fatto della collaborazione
prestata, come se fino a questo momento i giudici avessero
trascurato l’esame della permanenza o meno delle esigenze
cautelari di cui al’art. 274 C.P.P..; si prevede poi
che rientra nel giudizio sulla revoca della misura cautelare
la verifica del rispetto degli «impegni contrattuali»
da parte del collaboratore (art. 16 octies ult. parte) : si
tratta di un principio che comporta sorprendenti commistioni
tra la fase amministrativa e quella giurisdizionale cautelare,
con l’introduzione di criteri di valutazione che nulla
hanno a che vedere con i profili cautelari propri dell’esame
del giudice. Ma non si tratta solo di questo: nell’un
caso e nell’altro si prevede l’intervento del Procuratore
Nazionale Antimafia che, in tema di misure cautelari, esprime
il suo parere e, per i benefici penitenziari, è titolare
del potere di proposta (negato ai Procuratori della Repubblica),
a tal punto decisivo che, nel caso di concessione del beneficio
in presenza del suo parere contrario, la magistratura di sorveglianza
ha l’obbligo di specifica motivazione.
Su aspetti essenziali dell’attività giurisdizionale,
come la valutazione delle esigenze cautelari o della ricorrenza
dei presupposti dei benefici penitenziari, dunque, si prevede
l’intervento di un soggetto estraneo al processo, non
legittimato allo svolgimento di funzioni di P.M., in termini
che sembrano escludere o condizionare il ruolo del PM che
tratta o ha trattato il procedimento (cioè del P.M.
competente ex art.299 comma 3 bis c.p.p., costituito presso
il giudice che deve provvedere) e tali da potere comunque
determinare un eventuale contenzioso tra le due figure. Qualche
perplessità, a dire il vero, potrebbe essere manifestata
circa il ruolo analogo che si attribuisce ai Procuratori Generali
presso le Corti d’Appello interessate in relazione ai
collaboratori in procedimenti per delitti di terrorismo ed
eversione, ma in questo caso si è almeno in presenza
di un ufficio che ha precise competenze in sede di esecuzione
della pena ed anche, almeno per i procedimenti in fase d’appello,
in tema di valutazione delle esigenze cautelari.
Comprensibile, anche alla luce del dibattito che ha preceduto
l’emanazione della legge, è la previsione secondo
cui, ricorrendone i presupposti sostanziali, la liberazione
condizionale della pena, i permessi premio e la detenzione
domiciliare possano essere concessi sě anche in deroga
ai limiti di pena rispettivamente previsti in via ordinaria,
ma, salvo che per i permessi premio, soltanto dopo l’espiazione
di almeno un quarto della pena inflitta o, nel caso di condanna
all’ergastolo, dopo l’espiazione di almeno dieci
anni di reclusione.
Viene esclusa la possibilità di concessione in deroga
ai limiti minimi di pena espiata dei benefici dell’affidamento
in prova al servizio sociale e della semilibertà, evidentemente
per la incompatibilità delle loro modalità di
attuazione rispetto alle esigenze di protezione e sicurezza
che pur sempre dovranno essere valutate in relazione alla
qualità di collaboratore del soggetto che ne fruisce.
Alle stesse esigenze, peraltro, si raccorda (in linea con
la sentenza della Corte Costituzionale n.227 del 1999) la
scelta di riaffermare la competenza del tribunale o del magistrato
di sorveglianza di Roma (vedi c.8 art. 16 nonies) in relazione
alla concessione di benefici penitenziari e misure alternative
alla detenzione ai collaboratori. L’alternativa possibile,
al fine di evitare ingolfamenti dell’ufficio romano,
sarebbe stata, del resto, non l’individuazione della
competenza della magistratura di sorveglianza del luogo di
residenza o domicilio reale (chè in tal caso ne sarebbe
risultata compromessa la segretezza del luogo di vita e lavoro
del collaboratore), ma della magistratura del distretto di
Corte d’Appello ove siano state pronunciate le sentenze
di merito.
Piuttosto, in tema di disposizioni transitorie, sarebbe
stato probabilmente necessaria e comunque utile - l’introduzione
di una norma che espressamente affermasse l’applicabilità
alle sole collaborazioni successive all’entrata in vigore
della Legge della citata condizione per l’accesso alla
liberazione condizionale ed alla detenzione domiciliare in
deroga ai limiti di pena ordinari: prevedere l’intervenuta
espiazione di almeno un quarto della pena inflitta o, nel
caso di condanna all’ergastolo, di almeno dieci anni
di reclusione incide innegabilmente sulla pena e, dunque,
modificando in peggio lo «statuto» del collaboratore
(che potrebbe essersi indotto alla scelta in vista di migliori
prospettive e, comunque, in presenza di un più favorevole
regime), difficilmente potrà essere ritenuta una scelta
a contenuto meramente processuale e non, invece, di natura
sostanziale.
Molti collaboratori «storici», peraltro, non sono
stati ancora condannati con sentenza definitiva e, dunque,
non usufruiscono attualmente di benefici penitenziari : appare
dubbio che, una volta condannati definitivamente, essi non
possano beneficiare della più favorevole normativa
preesistente. Per finire sul tema dei benefici penitenziari,
comunque, appare altamente apprezzabile la scelta di separare
il momento premiale dal momento tutorio-assistenziale: secondo
la normativa previgente, infatti, l’ammissione del collaboratore
condannato ai «benefici penitenziari in deroga»
era condizionata alla permanenza della sua sottoposizione
allo speciale programma di protezione, con la duplice conseguenza
di determinarne il diniego nei confronti di colui che a quel
programma non fosse più sottoposto solo per il venir
meno della situazione di pericolo preesistente o di indurre
le Procure competenti, nell’intento di evitare tale ingiusta
situazione, a richiedere il prolungamento del regime di protezione
accordato a molti collaboratori meritevoli.
La legge, infine, ha modificato il regime di incompatibilità
della difesa di più imputati nello stesso procedimento
di cui all’art. 106 del codice di rito, prevedendo, tra
l’altro, che non possa essere assunta dallo stesso difensore
la difesa di più imputati collaboranti nello stesso
procedimento, o in procedimento connesso ex art.12 o collegato
ai sensi dell’art. 371, c.2, lett. «b». Anche
questa scelta, come è noto, risente delle polemiche
agitate, spesso strumentalmente, da una parte dell’avvocatura
penale nei confronti dei difensori dei collaboratori, accusati
più o meno esplicitamente di farsi strumento di manovre
inquinanti ideate dai loro assistiti: qui sorprende non solo
la sfiducia palesata dal legislatore nei confronti di quei
pochi legali che esercitano il loro mandato spesso in un clima
di evidente difficoltà, ma anche il fatto che non si
sia pensato di introdurre analoghe incompatibilità
per i difensori, nello stesso processo, di più imputati
non collaboranti, i quali, proprio la natura mafiosa delle
condotte loro ascritte, sono certamente sospettabili di manovre
inquinanti in misura ben maggiore di quanto non lo siano i
collaboratori.
Ma solo per questi ultimi viene limitato il diritto di
scegliere un difensore particolarmente qualificato o di mantenere
l’assistenza di chi da tempo segue le sue vicende giudiziarie.
Insomma, come è facile rilevare, la legge presenta
luci, ma anche molte ombre; addirittura evoca rischi di preoccupanti
mutamenti ordinamentali: a proposito dei poteri riconosciuti
al Procuratore Nazionale Antimafia, infatti, prescindendo
dalle riconosciute capacità dell’attuale titolare
dell’ufficio, non si può non rilevare come sia
ormai concreto il pericolo di realizzazione di una struttura
del Pubblico Ministero gerarchizzata a livello nazionale,
il cui vertice verrebbe decisamente a collocarsi in posizione
di «cerniera» rispetto al potere politico-governativo,
con l’ulteriore rischio di estensione delle sue competenze
dal campo dell’antimafia ad altri settori dell’intervento
penale.
È auspicabile, dunque, che a fronte dell’unanimismo
che ha sorretto le scelte di politica giudiziaria degli ultimi
due anni (non a caso caratterizzate, soprattutto nel processo
penale, dall’inflazione di garanzie solo formali per
gli imputati e dal sacrificio delle esigenze di efficienza
generale), si avvii al più presto, indipendentemente
dall’identità di chi governerà il Paese,
un monitoraggio reale sulle conseguenze negative delle riforme
varate, al fine di porvi rimedio nel breve periodo: si constaterà
che quelle derivante dalla nuova disciplina del regime dei
collaboratori processuali saranno tra le prime a manifestarsi.
Armando Spataro, magistrato,
componente del Consiglio superiore della magistratura
(marzo 2001)
 |
|
|