




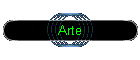

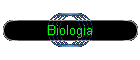

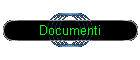
|
Storia della Psichiatria |
L'evoluzione dell'assistenza ospedaliera:
l'antipsichiatria
Nella trattazione della storia della psichiatria non è possibile non affrontare il tema dell’assistenza e dei manicomi, metodi e strutture che per decenni fecero da sfondo alle ricerche della psichiatria, che forniva assistenza all’interno dei manicomi.
Fino al secolo scorso, quando le nuove conoscenze scientifiche sono venute assumendo importanza preponderante, le scelte di funzioni, strutture e organizzazione erano determinate dalla concezione benefica dell'assistenza. Oggi tali scelte vengono affrontate sulla base delle complesse relazioni fra l'ospedale e il contesto umano, socio–economico, urbanistico. Dall'ospedale di beneficenza (solitamente religioso, con architettura di tipo monumentale), giudicato necessario in base a considerazioni di ordine morale e inteso come luogo di reclusione di individui sfortunati e destinati a non rientrare più nella società, si è passati all'ospedale come “lazzaretto”, un luogo in cui la comunità inviava gli individui malati con lo scopo di relegarli in maniera da fronteggiare la diffusione di alcune delle più pericolose forme morbose ad etiologia infettiva (ed ecco la conseguente realizzazione a padiglioni).
L'acquisizione di nuove conoscenze mediche ha imposto modifiche profonde della struttura ospedaliera, giungendo alla ricostruzione completa degli ospedali o all’aggiunta di blocchi operatori, laboratori, reparti radiologici, ecc…
E' questa l'epoca alla quale si può far risalire un primo, importante salto di qualità nella concezione del ruolo dell'ospedale: il carattere scientifico sempre più accentuato assunto dalla istituzione ospedaliera convince anche i membri dei ceti più agiati della società che solo l'ospedale è in grado di assicurare concrete possibilità di cura alle affezioni morbose.
Si finisce però con il dimenticare la necessità di considerare sempre il malato come "centro" dell'ospedale, e si mettono in atto realizzazioni strutturali concepite per ottenere un "efficientismo aziendalistico", cui consegue una disumanizzazione dell'istituzione ospedaliera.
Sulla scorta di tali esperienze oggi si tende ad un ospedale che offra sia delle strutture tecnologicamente avanzate e ben disposte, sia un rapporto umano con il paziente, partendo però dal presupposto che l’ospedale è una struttura “scomoda” per l’utente.
Verso il superamento del manicomio: le ragioni scientifiche
Le considerazioni fatte sull’assistenza ospedaliera riguardano anche la struttura manicomiale, sebbene con caratteri peculiari. Questa sezione è dedicata alla storia e alle motivazioni che hanno portato alla scomparsa del manicomio come struttura di reclusione.
Intorno al 1870 la critica dell’idealismo da parte del positivismo e del naturalismo, che si ribellavano di fronte allo scadimento della dialettica in formulazioni aride e schematiche, si rifletteva in tutti i campi della cultura. L’Italia era conquistata alle esperienze del positivismo e deponeva gli interessi più propriamente speculativi per privilegiare le scienze fisiche e naturali e la ricerca empirico–sociologica. Nello specifico campo di interessi concernente la malattia mentale, il processo ripeteva le linee percorse altrove: la presa di coscienza della ragione come non-follia diventava il primo atto necessario per avviare il riconoscimento e la conoscenza della non-ragione come follia; ma i due termini antinomici venivano a connotarsi in riferimento al parametro di normalità e di norma, ponendo le basi di un equivoco di cui ancora adesso si sentono gli influssi. Così la follia, da soggetto di timore, di mistero, di esplosione irrazionale, diventava oggetto di indagine e di conoscenza; per misurarla si richiedeva uno spazio delimitato dove potesse manifestarsi, essere conosciuta e indagata, potersi eventualmente risanare. Tale spazio veniva a costituirsi nel manicomio e dell’oggetto doveva appropriarsi una disciplina appositamente formata, la psichiatria.
A partire da quel momento, l’internamento da un lato diventava il principale strumento di identificazione sociale del folle, mentre dall’altro determinava i fondamenti della professione dello psichiatra e dell’autonomia scientifica della psichiatria.
Il positivismo aveva così contribuito a portare i folli dall’indistinta massa dei disperati al loro isolamento in manicomio. A questa operazione culturale e sociale corrispondeva in Italia, dopo l’Unità, l’affermarsi sulla scena politica di una classe borghese fortemente motivata da un lato a raccogliere esperienze progressiste e dall’altro a costruire e poi mantenere un forte potere centrale e a conservare una rigida stratificazione sociale. Il contemporaneo processo di formazione del capitalismo industriale si svolgeva in una realtà economica e sociale fortemente squilibrata, sulla quale la pressione del potere unificante dello Stato produceva ulteriori clamorosi fenomeni di degradazione e di pauperismo. La psichiatria si è costituita in Italia come dottrina scientifica all’interno di questo quadro di riferimento per cui la scienza era risolutrice di ogni contraddizione. La psicologia fu fondata perciò su un modello positivistico, basato sul principio deterministico di causalità biologica. La psichiatria italiana si è sviluppata all’ombra di quella tedesca assumendo i connotati nosologici, studiando il sistema nervoso centrale separato dai legami sociali e ambientali del paziente. Con questa operazione di segregazione per ottenere il controllo, lo studio e la cura dei folli,la psichiatria riprodusse il mistero della follia perché basata sull’affermazione pregiudiziale di un tipo preciso di causalità che, essendo da dimostrare, ieri come oggi, riproponeva i concetti d’incomprensibilità, d’imprevedibilità e quindi di pericolosità ampiamente presenti nel senso comune e nella cultura in epoca prescientifica. Accanto alle esigenze di controllo e di difesa sociale del malato si affermava la volontà di sollevarlo da condizioni inumane di trattamento e di difenderlo dal sopruso e dall’arbitrio, sempre in linea con la politica sociale borghese.
In mezzo a queste due posizioni si trovava lo psichiatra. La conclusione di questo processo è rappresentata dalla legge del 1904 sui manicomi e sugli alienati, con la quale venne sancito il potere del medico nell’organizzazione assistenziale e nella gestione della malattia. Ciò ha reso necessaria la costituzione di quello spazio chiuso che è il manicomio e ha determinato l’isolamento della psichiatria; nello stesso isolamento si sono sviluppati anche la ricerca e l’insegnamento universitario. Inizialmente questo era affidato a dei direttori d’ospedale e si confondeva con la neurologia. Solo più tardi la neurologia ha conquistato una propria autonomia; ma l’interdipendenza tra psichiatria e neurologia è rimasta nel tempo ed è ben rappresentata dal fatto che fino alla nostra epoca si è mantenuta l’unicità delle cliniche delle malattie nervose e mentali, dalla diffusione dei trattamenti biologici ad indirizzo neurologico e neurochirurgico, dallo sviluppo di indagini sempre più sofisticate impiegate indifferentemente per il chiarimento delle lesioni organiche del sistema nervoso centrale e per l’interpretazione dei comportamenti. Questo isolamento della psichiatria e la sua dipendenza dalla neurologia hanno fatto sì che il manicomio, nato per separare i folli dalla massa indifferenziata che riempiva il vecchio asilo, abbia nel tempo nuovamente accolto e racchiuso una quantità di individui dalle caratteristiche più disparate, ma accomunati da due elementi costanti: l’essere poveri e l’essere di disturbo per l’ordine sociale. Così la psichiatria, nata anche per chiarire e trattare il fenomeno della non-ragione, ha poi assunto la tendenza ad interpretare in termini di patologia tutta una serie di problematiche sociali, fino a dare una copertura ideologica ai metodi di esercizio del potere costituito. In tal modo il manicomio ha contribuito ad incrementare la propensione all’internamento di tutti i comportamenti considerati socialmente dannosi. Da questo punto di vista, il modello dell’assistenza psichiatrica delineato dalla legge del 1904 dimostrava una stretta aderenza funzionale ai bisogni sociali e di controllo e in questo senso ha avuto il massimo sviluppo nel nostro Paese, anche andando contro gli aspetti positivi della legge. Accanto a questo fatto ne vanno ricordati altri: un certo provincialismo culturale della medicina italiana; la dipendenza della psichiatria dalla neurologia; infine con il fascismo il ritorno in auge dell’idealismo, il blocco delle comunicazioni con la cultura straniera e la fuga dall’Italia di molti uomini di scienza. Tali fattori hanno impedito all’Italia di seguire i progressi europei nel campo psichiatrico, che tendevano a rivalutare la dimensione psichica individuale e quella relazionale, acquisendo come oggetto di studio per la comprensione del fenomeno psicopatologico l’uomo sano e la vita quotidiana. Ciò distaccava la psicologia dalle posizioni biologiche e neurologiche. Anche se poi nella pratica questa tendenza si andava svolgendo sempre all’interno di una logica discriminatoria, di privilegio per le classi sociali superiori, mentre alle classi popolari continuava ad essere riservata la psichiatria basilare, più efficiente sotto il profilo del controllo.
I riflessi delle nuove elaborazioni sui problemi della follia si sono avuti in Italia solo quando venne compiuta una sintesi di alcune fondamentali acquisizioni che diedero origine al movimento di lotta contro le istituzioni manicomiali. Ma tale movimento, pur avendo fatto compiere notevoli progressi all’assetto della psichiatria, ha comportato che la conoscenza scientifica e lo stimolo all’approfondimento si siano sviluppati in maniera discontinua. Ciò ha creato una scissione fra teoria e prassi nel mondo della psicologia italiana, ben visibile al momento dell’introduzione degli psicofarmaci nell’uso clinico. La scoperta che una serie di sostanze chimiche potevano avere effetti rilevanti sulla sfera psicologica e comportamentale ha aperto, a partire degli anni '50, la via alla ricerca dei modi di funzionamento del sistema nervoso centrale in base allo studio di nuovi parametri neurofisiologici e biochimici. I risultati di questi nuovi studi hanno portato all’elaborazione di ipotesi sulle basi biologiche di alcuni disturbi psichici; la modificazione di un certo numero di variabili biologiche in questi disturbi suggerisce che una base biochimica può essere ricercata, ma non è sicuro che questo dato possa condurre ad una spiegazione della vulnerabilità a questi disturbi. Nonostante questo margine di dubbio, sotto forti spinte sociali di mistificazione del dato scientifico, si è fatto un uso massiccio di psicofarmaci come unica risposta alla più vasta serie di sofferenze e problematiche. Ad aggravare l’uso indistinto degli psicofarmaci vi è l’insicurezza sull’effettiva bontà del trattamento. Viene quindi il dubbio che la riscoperta del rapporto interpersonale portato dagli psicofarmaci possa essere finalizzata al puro e semplice controllo del comportamento. Ma questo non è l’unico problema causato dalla normalizzazione con uso di psicofarmaci. La tranquillizzazione di ogni soggetto problematico ha avuto riflessi negativi incalcolabili nel senso comune e si è svolta sotto la spinta degli enormi interessi dell’industria farmaceutica. Il mercato degli psicofarmaci ha avuto così una costante e vertiginosa espansione, senza nessun riguardo per il danno apportato alla salute delle popolazioni, anche soltanto in forma di dipendenza cronica da un tale tipo di consumo. Alcuni farmaci tranquillizzanti registrano un costante incremento nel fatturato delle grandi multinazionali e la loro propaganda è sempre più diffusa. Si può ritenere che tutto ciò abbia contribuito notevolmente allo sviluppo nella nostra epoca della generale tendenza all’uso e all’abuso di sostanze chimiche per modificare gli stati di coscienza e l’attività psichica, tendenza all’interno della quale va ricondotto anche il fenomeno dell’aumento delle tossicodipendenze.
Il fatto che diede vita a tale movimento, accanto alla prima diffusione delle conoscenze scientifiche più avanzate e ad una loro iniziale applicazione pratica, è stata la presa di coscienza degli stretti legami fra scienza e politica: le interpretazioni scientifiche non sono né asettiche, né precise, ma risentono del clima culturale e dell’assetto politico nel quale si sviluppano. Conseguentemente la pratica terapeutica che ne deriva non può in alcun modo considerarsi né l’unica, né la più valida. E’ da questa consapevolezza che in Italia si è sviluppata la critica all’organizzazione istituzionalizzata della psichiatria. L’ingresso nella cultura scientifica italiana di nuovi strumenti di analisi e di critica è avvenuto in un preciso momento storico, nel quale le forze politiche e sociali progressiste sottolineavano l’esigenza di un complessivo mutamento dell’assetto sociale, che nel campo della sanità fosse rappresentato da un processo di radicale riforma. Da qui si sono mosse le iniziative per un’analisi della realtà manicomiale e della sua peculiare arretratezza, fino allo sviluppo di un ampio movimento culturale, tecnico e politico, diretto alla critica del manicomio prima, quindi alla sua negazione e alla lotta per abolirlo. Questo processo ha concluso la sua prima fase con le leggi 180 e 833 del 1978.
Il movimento di critica all’istituzione del manicomio fonda le sue ragioni in una serie di motivazioni scientifiche e non. Un primo gruppo di ragioni scientifiche che stanno alla base delle iniziative per il superamento del manicomio è riconoscibile attraverso l’analisi delle funzioni che esso ha svolto tradizionalmente nei confronti dei ricoverati. Si tratta di elementi intrecciati fra loro, che riguardano le funzioni assegnate dalla legge, dal senso comune e dalla cultura medica, ma soprattutto le funzioni realmente svolte, ossia ciò che avveniva effettivamente del ricoverato. La legge (legge 14 febbraio 1904 n. 36, “Disposizioni sui manicomi e sugli alienati”, art.1) assegnava al manicomio tre funzioni: la custodia delle persone giudicate pericolose per sé o per gli altri; la cura delle persone stesse; la salvaguardia dell’interesse sia dei malati sia della società.
La realtà del manicomio, la storia della psichiatria istituzionale, il progresso delle conoscenze, hanno insegnato che le tre funzioni sono profondamente contraddittorie. La contraddizione risiede nella necessità di conciliare, all’interno del manicomio, i concetti di custodia e di cura che sono fra loro irriducibili. E’ infatti impossibile ricercare la precisa causa che determina nel singolo individuo la necessità di cura e far partecipare direttamente il singolo alla storicizzazione del comportamento e della sofferenza, se il singolo è rinchiuso forzatamente dentro il manicomio. Va inoltre ricordato che il senso comune e la cultura medica hanno assegnato al manicomio funzioni più significative rispetto al ruolo realmente svolto. Queste funzioni si definiscono: a) nella separazione dal contesto del vivere comune degli individui apparentemente distaccatisi dalla norma sociale, considerati incomprensibili, irresponsabili e improduttivi; b) nel loro trattamento a fini di normalizzazione o comunque di controllo. L’ordinamento dottrinario della psichiatria ha costruito le ipotesi della causalità biologica, ammantando di dignità scientifica le pratiche di trattamento e rinforzando quindi nel senso comune la falsa coscienza del manicomio come luogo specializzato di cura. Ciò trova riscontro nelle funzioni reali del manicomio, molteplici e complesse, ma tali da impedire di fatto le possibilità che esso fosse luogo di cura.
La coscienza comune può essere riscontrata anche e soprattutto al momento del ricovero. Il ricovero in manicomio avveniva in conseguenza di comportamenti di disturbo o di rottura della norma o comunque inadeguati rispetto alle richieste, alle aspettative familiari e sociali, , ai riferimenti e ai modelli culturali. Tali comportamenti venivano attribuiti alla sfera della non-ragione in quanto non-comprensibili. Questa attribuzione però necessitava sempre della convalida medica, che si esercitava sotto forma di etichettatura diagnostica; si comprende quale peso avesse l’ideologia del medico in tale processo di convalida.
Nessun interesse e nessuna attenzione venivano concesse al significato del comportamento e del sintomo, sia in relazione alla storia dell’internato, sia al contesto sociale nel quale si erano manifestati i sintomi. Questo accadeva per l’incapacità scientifica della psichiatria a comprendere fenomeni esterni al proprio universo concettuale. Per definizione, il malato di mente era ritenuto incapace di essere cosciente della propria malattia, mentre tale coscienza veniva richiesta come requisito per accettare di essere curato o meglio trattato.
L’interesse della psichiatria era concentrato sul sintomo e sul comportamento inteso come sintomo, riguardati e indagati come epifenomeni del presunto danno organico.
Questo approccio al malato, estremamente rigido e riduttivo, limitava evidentemente la comprensione delle motivazioni del suo comportamento, il significato simbolico e comunicativo, i bisogni occultati dietro tale comportamento. Quando l’approccio tentava di sconfinare dall’ambito frammentario del sintomo per prendere in considerazione la personalità e la persona, il risultato era sempre quello di ordinare i fenomeni in termini di stretto determinismo. Il limiti della tassonomia basata sul principio della causalità biologica lineare non sfuggivano certo alla psichiatria accademica che, nel definire col termine generico di “endogene” le grandi psicosi, non perdeva occasione per rimandare invariabilmente ad un futuro affinamento degli strumenti di indagine il chiarimento circa il loro presunto substrato organico.
La concezione esclusivamente organicista della malattia mentale e la conseguente pratica di trattamento dei malati, hanno determinato l’impossibilità che il manicomio fosse luogo di cura. Per di più, oltre a non curare, il manicomio ha dimostrato di essere dannoso, in quanto tendeva a cristallizzare, a fissare il malato e la sua sofferenza in una dimensione astorica, sottoponendo la sua esistenza ad una gestione definitivamente alienata, cioè sottratta alla sua consapevolezza, alla sua iniziativa, alla sua volontà, e interamente affidata ad altri.
Il cerimoniale manicomiale prevedeva la spoliazione completa del malato, la sottrazione di ogni oggetto personale, spesso il taglio completo dei capelli, almeno per gli uomini, talora la fotografia del volto da allegare alla documentazione clinica, l’assegnazione di una divisa e di biancheria personale marchiata.
L’analisi dell’istituzione manicomiale e di tutte le altre istituzioni totali (luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato), ha messo molto chiaramente in evidenza la diffusione ubiquitaria e costante di tali meccanismi di spoliazione dell’identità, evidenziando che il significato di tali istituzioni risponde essenzialmente alla logica e al bisogno di conservazione e di autoriproduzione di tutte le istituzioni di questo genere. Nei casi in cui il cerimoniale di accoglimento non fosse risultato sufficiente, l’istituzione era fornita di altri mezzi di trattamento più drastici come, ad esempio, l’isolamento in cella e la contenzione meccanica; all’individuo veniva attribuito un preciso ruolo ed uno status sociale definito, suscettibile di estensione e generalizzazione, (sia per l’individuo stesso nel progredire della sua storia e della sua vita, che era da quel momento in poi contraddistinta da questo marchio; sia per tutti gli altri, sotto forma di avvertimento e di diffusione della coscienza della possibilità di essere stigmatizzati come malati di mente).
Si ponevano in questo modo le basi per la definizione dell’inguaribiltà della malattia mentale e quelle per la produzione della cronicità. Questo ha prodotto inoltre fuori del manicomio la generalizzazione del pregiudizio della irrecuperabilità del folle nella coscienza dei normali.
Si comprende quindi come l’istituzione non potesse essere che violenta. Le forme di questa violenza erano variabili, da quelle evidenti e più clamorose a quelle più occulte, ma abituali e generalizzate, che risiedevano nelle regole istituzionali tipiche, destinate a determinare lo status definitivo di “cittadino” del manicomio.
La figura del medico sovrastava e sovrintendeva con i suoi poteri assoluti a questo mondo di violenze: era lui che ordinava i provvedimenti e i trattamenti e ne forniva la motivazione scientifica e curativa; raramente era coinvolto in prima persona nel rapporto diretto con l’internato; di solito curava gli aspetti burocratici della sua funzione dirigenziale e delegava agli infermieri la diretta gestione dei ricoverati. I medici di reparto non potevano dedicare più di qualche minuto al mese ad ognuna delle persone loro affidate; questo si riduceva solitamente ad uno stereotipato cerimoniale di controllo per assicurarsi che la situazione non variasse;in caso contrario il medico interveniva su richiesta degli infermieri in situazioni di crisi acuta o per motivi di alterata situazione fisica generale. Il medico del manicomio in realtà era molto spesso un prodotto di scarto della scuola di medicina, era sottopagato rispetto alle altre figure specialistiche, si doveva teoricamente occupare di un gran numero di persone ed era a sua volta sottoposto all’autorità indiscussa del direttore, al quale venivano demandate le decisioni fondamentali. D’altra parte il pregiudizio dell’inguaribilità legittimava l’abbandono. La contraddizione tra indicazioni di legge e condizioni manicomiali era al massimo grado.
Come detto, la vita reale dei ricoverati era interamente affidata agli infermieri - di solito impreparati professionalmente - ai quali l’istituzione richiedeva sostanzialmente il mantenimento dell’ordine formale e la salvaguardia dell’integrità fisica dell’internato. In questo contesto, con la violenza istituzionale avevano spesso a che fare anche le tecniche più strettamente definite terapeutiche, dalle docce fredde ai trattamenti di shock, fino all’indiscriminata e massiccia somministrazione di psicofarmaci. I trattamenti miravano a reprimere i comportamenti disturbanti, ed assumevano perciò con facilità il significato di punizioni per l’opposizione e la ribellione alla violenza istituzionale.
Analoghe considerazioni si possono fare per i trattamenti cosiddetti riabilitativi, in particolare per l’ergoterapia, già prevista per legge come metodo di trattamento istituzionale. Si trattava in pratica di forme di sfruttamento, sia del lavoro necessario alla vita stessa dell’istituzione sia nel lavoro di accudimento dei reparti in luogo del personale e soprattutto nei compiti più sgradevoli. In molti manicomi esistevano le colonie agricole; in alcuni si organizzavano laboratori di vario genere, raggiungendo qui lo sfruttamento massimo in forme funzionali alla logica produttiva generale. I trattamenti terapeutici e riabilitativi erano in realtà mezzi di oppressione e di discriminazione, forme di violenza più o meno occulta, destinate a ridurre l’individuo al ruolo di abitante del manicomio e di occupante di uno spazio definito.
La logica del manicomio prevede una rigida distribuzione degli internati anzitutto per sesso e poi nei vari reparti o sezioni, in relazione ad una precisa stratificazione dei comportamenti e ad una conseguente speciale attrezzatura per il trattamento. Alla stratificazione per comportamento, si sovrapponevano quella per categorie nosografiche e quella risalente a criteri escogitati dalla fantasia di qualche direttore.
La caratteristica principale che differenziava i diversi spazi di vita, era quella della maggiore o minore limitazione della libertà di movimento, che veniva accentuata in base al comportamento. Il manicomio era architettonicamente strutturato nelle sembianze più del carcere che dell’ospedale e con tali forme imponeva l’evidenza della sua funzione custodialistica e segregante.
Il meccanismo dei trasferimenti,per esempio, serviva da strumento violento di oppressione, di terrore e di punizione, e quale mezzo per ridurre l’oggettiva diversità di ogni individuo ad una uniformità astratta. Il manicomio riusciva così ad entrare dentro ogni ricoverato.
Un caso particolare era rappresentato in molti manicomi dal reparto per minori. Il bambino emarginato veniva dichiarato folle affinchè fosse possibile curarlo e custodirlo convenientemente: così, mentre la diagnosi serviva per curare l’emarginazione, nello stesso tempo il folle veniva emarginato per essere curato.
Il manicomio era e rimane una sorta di macchina che funziona a violenza, producendola e alimentandola dentro e fuori di sé. Una violenza così organizzata non poteva che generare violenza, sia nel continuo perpetuarsi, arricchirsi e complicarsi dei meccanismi istituzionali, sia nel comportamento degli internati. Si pensava che le manifestazioni violente dell’internato dipendessero dalla malattia e dal cervello dell’individuo; in questa forma erano riproposte alla cultura e al senso comune a riprova e a continua alimentazione del pregiudizio, fino a diventare prescrizione del comportamento violento del folle. Ciò fa riflettere sull’imparzialità della scienza: la scienza non è sempre neutrale. La psichiatria da un lato metteva le tecniche al servizio dell’istituzione per la finalità della gestione totalizzante del diverso e dell’inutile sociale; dall’altro lato si appropriava dei prodotti dell’istituzione generalizzandoli in forma di acquisizione concettuale.