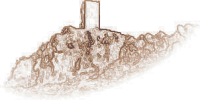|
|
|
In tutta l'Isola nobilta' e clero
osteggiarono la nuova dominazione piemontese sin quando nel 1726
l'astuto cardinale di Seneghe, Agostino Pipia,
ispiro' un concordato col Papa che fece affievolire le
nostalgie spagnole, sebbene non le estinse; il rimpianto per il precedente regime,
infatti, non fu mai in realta' completamente sopito.
|
La fraintesa questione della gestione
della terra, che ignorava a pie' pari l'uso che per costume millenario si era sviluppato in
Sardegna, non era cosi' semplice da liquidare, ne' per
editto, ne' tantomeno a livello di concezione economica.
Non e' oggetto di queste pagine, ma sintetizzeremo che l'uso
sardo coinvolgeva tutta la popolazione nella responsabile gestione dei
terreni, che si alternavano per annate a vidazzone
e paberile, cioe' un anno per la coltivazione e l'anno
dopo per l'allevamento.
Un antichissimo antenato giuridico dell'"uso civico" aveva
resistito per secoli inalterato nella sua semplice eppure articolata
struttura, con minime insoddisfazioni, ed anche attualmente la
sofisticata e dettagliatissima legislazione moderna non riesce ad
eliminarne gli effetti.
Forse ci voleva qualche mente meno leggera
per analizzare la questione e proporre soluzioni.
Va ricordato che ad introdurre nell'isola l'agricoltura "alla
piemontese", fu Giovanni Berlinguer, antenato del piu' noto Enrico;
per tali servigi ottenne
il cavalierato da Vittorio Amedeo.
Erano, e' vero, tempi nei quali non si
poneva una grande pazienza ne' un accurato scrupolo nell'analizzare
i fenomeni sociali, soprattutto per zone, come l'Isola,
di non primaria importanza; collateralmente, nella
mentalita' prevalente si preparava la strada al successo
di teorie criminologiche come quelle niceforiane o
lombrosiane, basate su collegamenti etico-somatici, quelle per le quali,
in sintesi, i delinquenti si potevano riconoscere dalla morfologia del
cranio.
La pure troppo facile equazione, pastore=criminale,
come sappiamo non e' piu' tramontata, ed anche oggi
offende la categoria.
Cio' che riesce difficile escludere e' che potessero
esservi, nell'elaborazione dei giudizi espressi da parte
dei funzionari sabaudi, interessi vergognosamente
personalistici e irrisori (non ultimo il disagio del
viaggio) capaci di provocare ai sardi disagio e lutti per
l'unta comodita' dei burocrati.
Come vedremo piu' avanti, Mazzini ne avrebbe parlato
con cruda vivezza.
|
Va detto che i Savoia effettivamente condussero regie
politiche di indiscussa modernita' ed illuminata
avanguardia, ma le riforme altrove applicate, fra le
quali l'editto
della perequazione (mediante il quale si acquisivano al
Demanio dello Stato i beni illegalmente detenuti dagli
ecclesiastici e dai nobili), furono del tutto ignorate in
Sardegna.
E quelle che invece furono applicate, come quelle in materia di
proprieta' terriera, furono fonte di guasti che i secoli successivi non
riuscirono a sanare.
Carlo Emanuele III successe
al padre Vittorio Amedeo (del quale in zona si ricorda
la privatizzazione delle miniere, fra le quali le pur
esigue miniere d'oro di Torpe') e doto' l'Isola di un
servizio di collegamento con la terraferma, oltre a munire le coste di una squadriglia di fregate, di cui una
o forse due di pattuglia al largo di Posada, per
contrastare le non ancora eliminate scorrerie piratesche.
 Il noto vicere' Marchese di
Rivarolo, fra il 1735 ed il 1738,
volendo contrastare l'incresciosa piaga del banditismo,
impose tre anni di pressione poliziesca che, fra l'altro,
proibi' ai Sardi di portare la tradizionale lunga barba,
provocando risentimenti di pesantissima portata. Il noto vicere' Marchese di
Rivarolo, fra il 1735 ed il 1738,
volendo contrastare l'incresciosa piaga del banditismo,
impose tre anni di pressione poliziesca che, fra l'altro,
proibi' ai Sardi di portare la tradizionale lunga barba,
provocando risentimenti di pesantissima portata.
Il Rivarolo, inoltre, incoraggio' il massiccio ricorso al guidatico,
un istituto giuridico spagnolo simile ad una moderna legge sul
"pentitismo" che garantiva l'immunita'
a chi avesse consegnato alle autorita' un bandito: le
delazioni vi furono, ma ovviamente risultavano
estremamente pericolose nelle comunita' dei villaggi,
dove infatti tra sospetti ed effettivi "tradimenti"
nacquero le prime faide.
"Divide et impera".
La considerazione dell'Isola sviluppata dai
primi savoiardi era decisamente negativa. Anche se le
analisi effettuate erano vergognosamente superficiali.
Le conseguenze di queste considerazioni furono, per
logico effetto, estremamente perniciose.
Leggiamo infatti dallo stesso Marchese di Rivarolo che i
delinquenti della Gallura e del Bittese "per
avversione alla coltura della terra si affezionano alla
vita errabonda del pastore, dell'ozio con la complicita'
della campagna originano furti, inimicizie, vendette".

Certamente, parve declamare il Rivarolo, la circostanza che la
terra sia proprieta' comune e dunque vi sia incertezza
della proprieta', causerebbe la delinquenza. Ergo, concludeva, stabilire
forzosamente o normativamente la proprieta' della terra (come
poi avvenne con l'Editto delle Chiudende), avrebbe
eliminato la delinquenza.
SEGUE
sponsor

|
|
|
|